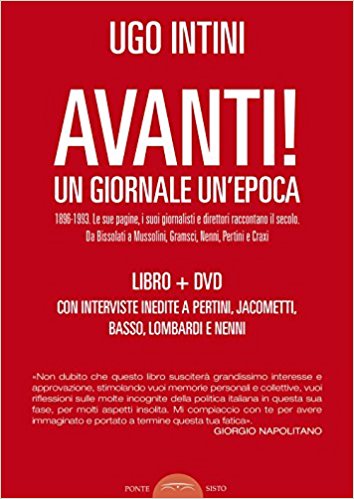Che i social networks abbiano prodotto una radicale trasformazione delle forme della comunicazione politica, è cosa risaputa. Sarebbe però un errore ritenere che la natura del mezzo determini in assoluto la qualità del messaggio; una funzione di rilievo è ancora assolta dall’armamentario della retorica. Una retorica che però si prefigge non di persuadere attraverso il ragionamento, ma di convincere facendo leva sulle passioni. Un caso di scuola è costituito da Matteo Salvini, che sfrutta sapientemente i social (da Twitter a Facebook, da Whatsapp a YouTube) ma se la sbroglia egregiamente anche nei salotti televisivi, e che perciò viene considerato un maestro della comunicazione politica.
Che i social networks abbiano prodotto una radicale trasformazione delle forme della comunicazione politica, è cosa risaputa. Sarebbe però un errore ritenere che la natura del mezzo determini in assoluto la qualità del messaggio; una funzione di rilievo è ancora assolta dall’armamentario della retorica. Una retorica che però si prefigge non di persuadere attraverso il ragionamento, ma di convincere facendo leva sulle passioni. Un caso di scuola è costituito da Matteo Salvini, che sfrutta sapientemente i social (da Twitter a Facebook, da Whatsapp a YouTube) ma se la sbroglia egregiamente anche nei salotti televisivi, e che perciò viene considerato un maestro della comunicazione politica.
La retorica di Matteo Salvini è, insieme, elementare e raffinata, nonché del tutto coerente con l’ideologia populista che la motiva. Il primo obiettivo è infatti quello di offrire di sé l’immagine di una persona comune (stavo per scrivere di un “uomo qualunque”), alla mano, che ama stare in mezzo alla gente. A questo serve la raffica di selfies in cui si ritrae mentre gioca con i figli sulla spiaggia, mentre passeggia tra la folla, mentre mangia la pizza seduto a una lunga tavolata, mentre degusta prodotti tipici, e via fotografando. Sfera pubblica e sfera privata si sovrappongono nel profilo di un leader che vuole essere scambiato per “uno di noi”, e che perciò non si vergogna di confessare alcune debolezze: nel video postato su Facebook durante l’ultima campagna elettorale per le politiche, e presto divenuto virale, il capo della Lega si accende una sigaretta e si scusa per essere ricaduto nel vizio del fumo. Al medesimo scopo è rivolto il modo di parlare. Salvini adopera la lingua dell’uso quotidiano, un lessico colloquiale qua e là infarcito di termini e frasi gergali in parte derivati dal vocabolario tipico della stagione bossiana (“strafregarsene”, “rompersi le palle”, “nisba”, “senza arte né parte”, “è finita la pacchia”), di metafore e similitudini banali (“non giochiamo al Monopoli”, con riferimento alla consapevolezza della necessità di tenere in ordine i conti pubblici; oppure: “i confini d’Italia sono come la porta di casa nostra”). E se nell’eloquio torrenziale fa capolino qualche anglismo (bisogna pur fare qualche concessione allo slang imperante), si tratta sempre di parole abusate, e quindi di immediata comprensione (per esempio, spread). Infine, Salvini predilige il discorso paratattico, con rare subordinate: in tal modo gli riesce di trasformare le proposizioni in slogan, con sicuro effetto propagandistico.

La comunicazione politica del leader leghista è dunque improntata alla regola della semplificazione; e non perché sia povera di idee, o diffidi dell’intelligenza (e del livello culturale) dei destinatari, ma perché intende rispondere a una domanda di rassicurazione. Quanto più la realtà si mostra intricata, persino indecifrabile, tanto più tendiamo inconsciamente a semplificarla, a interpretarla secondo un comodo schema binario, manicheo (buoni e cattivi, amici e nemici, ecc.); ne ricaviamo la confortante sensazione di conoscerla, e dunque di essere in grado di padroneggiarla. L’astuzia di Salvini (ma sarebbe più esatto dire: dei suoi spin doctors) consiste nel cavalcare cinicamente le paure generate dalla diffusa percezione di vivere in un mondo governato da meccanismi impenetrabili e perciò ostile, lasciando al contempo intendere che questa percezione è il frutto di una falsa, ingannevole rappresentazione delle cose ordita dai “poteri forti”, che i problemi sono meno complessi di quanto appaiano, che la loro soluzione è facile: basterebbe respingere i migranti, lasciare mano libera alle forze dell’ordine, abbassare le tasse, ribellarsi ai diktat dell’Europa. In tal modo il discorso del capo leghista legittima la rabbia contro le élites e ammannisce al popolo un miracolistico placebo.
Ma l’uomo “normale” non dimentica di essere un capo, cui si richiedono molti pregi e pure tanti sacrifici. Eccolo allora esibire ‒ in pose rodomontesche ‒ la sua ferrea volontà, peraltro giustificata dal mandato imperativo ricevuto dagli elettori, di proteggere i “confini” e la “sicurezza” degli italiani: perché «le frontiere, tutte le frontiere, sono sacre. Non si discutono: si difendono». Sicché, a seguito dell’imputazione per l’incidente della «Diciotti», proclama: “Vogliono processarmi o arrestarmi? Facciano pure, sanno dove trovarmi”. Poco c’è mancato che aggiungesse: «Se mi assolvete, mi fate un piacere; se mi condannate, mi fate un onore»; con l’implicito corollario: «Noi tireremo diritto». Ed eccolo, ancora, lamentarsi dello scarso tempo che può dedicare agli affetti familiari; e poi annunciare con fierezza ‒ nel video prima citato ‒ che rimarrà a lavorare nella sede del partito almeno fino alle tre di notte (postulando dagli eventuali passanti in transito per via Bellerio la stessa ammirazione provata tempo addietro dai romani che attraversavano piazza Venezia alle ore piccole, alla vista di una finestra illuminata nello storico palazzo). Per inciso: non tutto è di nuovo conio in questa prosopopea; c’è parecchio di Berlusconi, e non soltanto.

Vi sono figure ricorrenti nella retorica di Salvini: a cominciare dall’enumerazione, ossia dalla elencazione di termini talvolta coordinati per affinità, talaltra accumulati disordinatamente. I migranti sono “delinquenti”, “stupratori”, “terroristi”, “approfittatori”, “mantenuti”, e chi più ne ha più ne metta; le Ong sono qualificate come “taxisti del mare”, come congreghe di “amici” e “telefonisti degli scafisti” (dei “mercanti di carne umana”). All’enumerazione si accompagna la figura dell’iperbole (un espediente, si noti per inciso, di solito utilizzato per l’“invenzione del nemico”): le dimensioni dei flussi migratori vengono ingigantite al fine di creare allarmismo, di farli apparire come un’“invasione” che reca una minaccia mortale alla nostra identità; viene gonfiato il numero dei nostri connazionali che versano in una condizione di povertà assoluta per santificare la crociata contro gli immigrati. Nell’oratoria di Salvini abbonda poi l’improperio (l’ingiuria, l’insulto), talvolta rafforzato dalla furbesca associazione con la figura dell’antifrasi (un’affermazione che significa l’opposto di ciò che dice). Un esempio per tutti: nel video in precedenza citato, Salvini apostrofa Laura Boldrini come “amica”, “tifosa”, “cuginetta” degli immigrati clandestini, per professare subito dopo “rispetto” per la veste istituzionale che ricopre (all’epoca, quella di Presidente della Camera). Sembrerebbe una conversione al bon ton, e invece è una insolenza al quadrato: non si può avere deferenza verso chi sacrifica i diritti dei suoi connazionali alle pretese dello straniero, soprattutto se riveste responsabilità così alte.

Un’altra figura retorica che compare frequentemente nel discorso pubblico di Salvini è quella dell’antonomasia, in cui convenzionalmente un personaggio viene evocato a simboleggiare un carattere, una virtù o un vizio. Di questo tropo il “capitano” fornisce una stravagante versione: il nome proprio designa una linea politica e/o un orientamento culturale, per giunta connotandoli eticamente. Così il leader della Lega si propone come l’emblema del sovranismo, il paladino che sfida le autorità di Bruxelles e chiude i porti alle navi che trasportano i migranti raccolti in mare (se gli raccontassero che i “clandestini” arrivano sulle nostre coste anche alla spicciolata, con natanti di fortuna, di sicuro ordinerebbe che «non appena questa gente tenterà di sbarcare, sia congelata su questa linea che i marinai chiamano del bagnasciuga»); insomma, come un campione del bene. Di contro ci sono le incarnazioni del male: Letta, Monti, Renzi e Gentiloni, mercenari pagati dalla finanza internazionale, dai governi tedesco e francese, dall’euroburocrazia per danneggiare gli interessi degli italiani; Roberto Saviano e Gad Lerner, tipiche espressioni del giornalismo “stupido” o “ipocrita”, in entrambi i casi “complice” di coloro che attentano alla sicurezza, al lavoro, alla integrità etnica del nostro popolo. Il risultato è un imbarbarimento del dibattito politico; non si illustrano le proprie idee, non si contestano civilmente le ragioni altrui, si effigiano idoli da esporre alla gogna.
Conviene chiudere qui la sommaria rassegna, anche se ci sarebbe ancora molto da segnalare. Con una postilla: la retorica è una tecnica, e in quanto tale ‒ come insegnavano già i sofisti dell’antica Grecia ‒ può essere messa al servizio di una causa giusta e nobile, oppure iniqua e malvagia. E v’è da essere certi che Socrate, pure lui un sofista, avrebbe deprecato che l’arte dell’argomentazione fosse impiegata per mentire, per eccitare i peggiori istinti e le pulsioni più torbide, per negare la dignità dell’essere umano.
Dimenticavo: per coloro che non ne abbiano riconosciuto la fonte, le citazioni in corsivo sono di Benito Mussolini.
Ferdinando Pappalardo, già docente presso l’Università degli Studi di Bari, già parlamentare, presidente dell’Anpi provinciale di Bari, membro del Comitato nazionale Anpi
Pubblicato sabato 29 Settembre 2018
Stampato il 03/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/luomo-che-parlava-troppo/