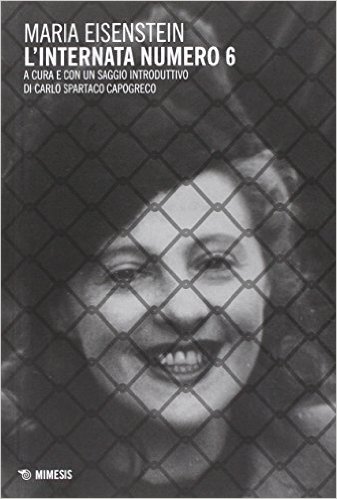Erano diventate, involontariamente, e con tutto il dolore e la sofferenza di essere state strappate alla loro casa, paese, vita, uno degli ingranaggi della stessa forza bellica nazista. Sono le donne, le ragazze, le adolescenti che, dall’agosto del 1942 all’aprile del 1945, la Siemens & Halske usò come forza lavoro nello stabilimento di produzione adiacente al campo di concentramento femminile di Ravensbrück, a 80 chilometri a nord di Berlino, in turni continui e durissimi. Cosa restava a queste 2.300 operaie per forza? Poco più che i sogni.
Erano diventate, involontariamente, e con tutto il dolore e la sofferenza di essere state strappate alla loro casa, paese, vita, uno degli ingranaggi della stessa forza bellica nazista. Sono le donne, le ragazze, le adolescenti che, dall’agosto del 1942 all’aprile del 1945, la Siemens & Halske usò come forza lavoro nello stabilimento di produzione adiacente al campo di concentramento femminile di Ravensbrück, a 80 chilometri a nord di Berlino, in turni continui e durissimi. Cosa restava a queste 2.300 operaie per forza? Poco più che i sogni.

E A volte sogniamo di essere libere è il titolo del libro promosso dall’Associazione internazionale amici del memoriale di Ravensbrück che raccoglie le testimonianze di 80 donne sopravvissute al lager, provenienti da quindici Paesi.

L’edizione italiana, recentemente pubblicata da FrancoAngeli, è particolarmente importante perché curata da Raul Calzoni, docente di letteratura tedesca all’Università di Bergamo e da Ambra Laurenzi, attuale presidente del Comitato internazionale Ravensbrück, figlia e nipote di deportate – sua madre Mirella Stanzione è attualmente l’ultima sopravvissuta italiana al lager-campo di lavoro – che da anni ha affiancato alla sua attività/professione di fotografa e docente quella sempre più vasta e importante di raccolta di fonti e testimonianze sulla deportazione femminile e non solo, come studiosa e come esponente dell’Aned, l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti.

Il libro sulle prigioniere sfruttate come manodopera forzata dall’industria bellica nazista apre una finestra importante di riflessione che finora, come ricorda Laurenzi, era rimasta poco considerata nel nostro Paese. Alla ritualità del racconto di freddo, privazioni, violenze, le testimoni del lavoro forzato aggiungono altro, a partire dall’alienazione di un lavoro ripetitivo aggravato dalle condizioni in cui viene svolto, come spiega ad esempio Lidia Beccaria Rolfi, la maestra piemontese che entra nella fabbrica Siemens la prima volta nell’ottobre 1944:

«La nostra Halle è un unico capannone senza divisioni all’interno, senza latrine, squallido e rumoroso. Le macchine bobinatrici fanno un rumore assordante. È la prima fabbrica che vedo e mi dà un senso di angoscia, con tutte le donne vestite a righe chine sul lavoro, l’Aufseherin che passeggia nel corridoio centrale con il frustino in mano, il passo cadenzato, lo sguardo truce, costantemente vigilante alla ricerca delle più lente, le sabotatrici».
Attenzione: ci saranno davvero quelle che cercheranno di sabotare, anche se in maniera minima, la produzione. Più che altro per sentirsi persone, capaci di reagire, come racconta un’altra italiana, Maria Montuori, conosciuta anche come Mara:
“Assegnata al banco della saldatura, Maia soleva bruciare l’interno di tutti gli accumulatori, con la punta arroventata dell’apparecchio elettrico, prima di chiuderli. Il lavoro era pericoloso perché le saldatrici lavoravano quasi gomito a gomito, e dappertutto abbondavano le spie”.
E allo stesso modo la belga Jane Ponsaint parla della lentezza come arma:

“Aspettare, questo è il nostro obiettivo, ci fa guadagnare tempo. (…) Aspettare. Migliaia di microfoni non vengono consegnati, telefoni militari aspettano gli ultimi pezzi. Ali di aerei, motori, non sono pronti perché manca un’ultima vite. Aspettare, la vittoria arriverà”.
Non va dimenticato che la gran parte delle deportate nel campo-fabbrica (ce n’era anche un altro di grandi dimensioni, la TexLed, centro di produzione delle stesse divise che le prigioniere indossavano lì e in tutti gli altri campi) portavano il triangolo rosso delle prigioniere politiche, ed erano quindi particolarmente attente alla possibilità di continuare, in qualche modo, la loro lotta al nazifascismo. Una lettura importante, quindi, anche nella memorialistica dei campi. Ravensbrück inoltre, ricordiamolo, è stato aperto nel maggio del 1939 per isolare le oppositrici del Reich e tutte quelle “reiette”, come prostitute o lesbiche, non gradite al regime hitleriano e non redimibili. Donne che pensano, che decidono, quando e come è possibile, di resistere anche ideologicamente, non solo – ma anche – per salvarsi la vita.

Se il libro è interessante sotto il profilo dei dati sulla produzione industriale bellica, lo deve anche grazie alla disponibilità della Siemens di permettere l’accesso ai propri archivi; ma il corpo principale del volume è costituito dalle testimonianze. Che si leggono d’un fiato: storie personali, ricordi, paure, ma anche sogni, come quello di essere libere, appunto, che le ha portate fuori dalla fabbrica-lager, ancora donne, ancora persone.
Pubblicato lunedì 8 Marzo 2021
Stampato il 02/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/ravensbruck-quelle-operaie-per-forza-che-si-sognavano-libere-sabotando-il-reich/