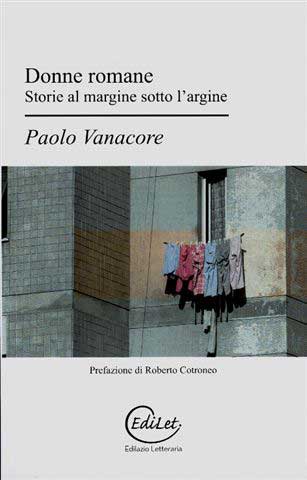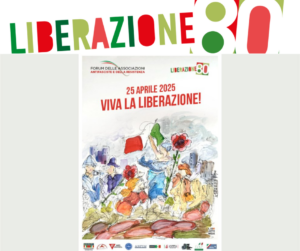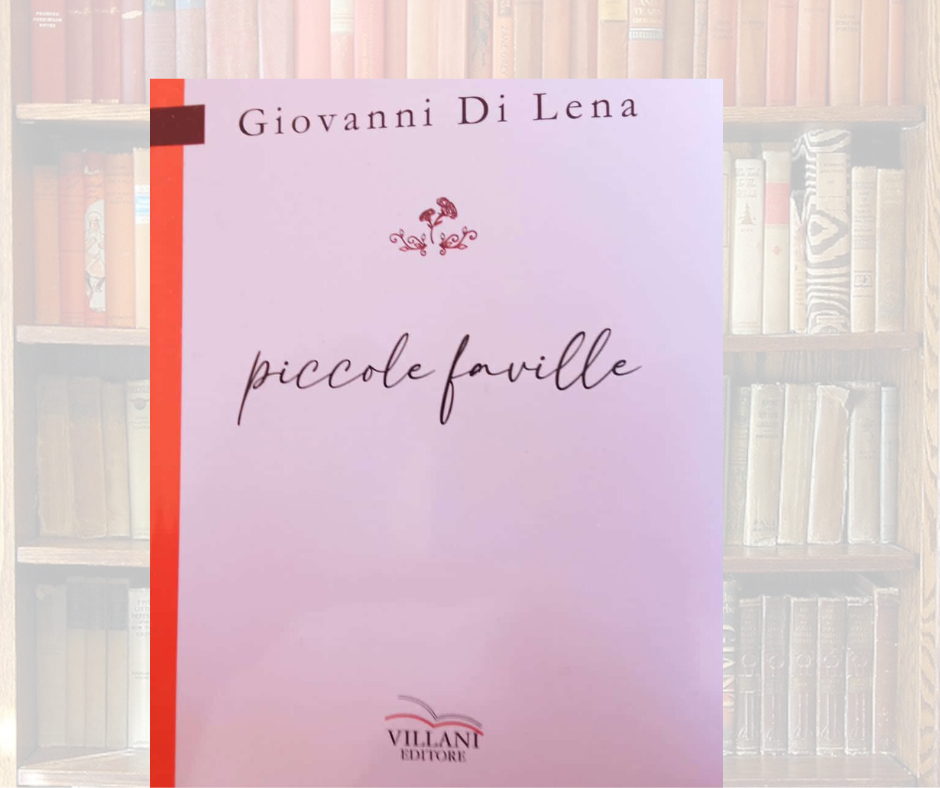 C’è chi sostiene che non esiste la poesia sociale come categoria poetica, perché tutta la Poesia è sociale, sia nell’intento dell’autore che nella risonanza che ha nei lettori, come avviene nelle “Piccole faville” di Giovanni Di Lena, una raccolta di poesie che accolgono istanze, sollecitano riflessioni e raccontano spaccati del nostro Paese e della Basilicata, terra natia del poeta e dove ha sede anche l’editore Villani che ne ha curato la pubblicazione.
C’è chi sostiene che non esiste la poesia sociale come categoria poetica, perché tutta la Poesia è sociale, sia nell’intento dell’autore che nella risonanza che ha nei lettori, come avviene nelle “Piccole faville” di Giovanni Di Lena, una raccolta di poesie che accolgono istanze, sollecitano riflessioni e raccontano spaccati del nostro Paese e della Basilicata, terra natia del poeta e dove ha sede anche l’editore Villani che ne ha curato la pubblicazione.

Sociale e dunque politico, il libro di Di Lena si apre con un testo dedicato a Rocco Scotellaro, scrittore, poeta e intellettuale che ha segnato la cultura e la storia del Novecento e di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita.

Quella di Scotellaro fu un’esperienza umana e artistica straordinaria della quale si parla ancora troppo poco: sindaco di Tricarico, in provincia di Matera, a soli 23 anni – dal 1946 al 1950 – trasse dalla sensibilità ai problemi sociali della sua terra motivi per alcune opere, ricevendo riconoscimenti nazionali importanti come il prestigioso Premio Viareggio per la poesia e il Premio San Pellegrino (1954).
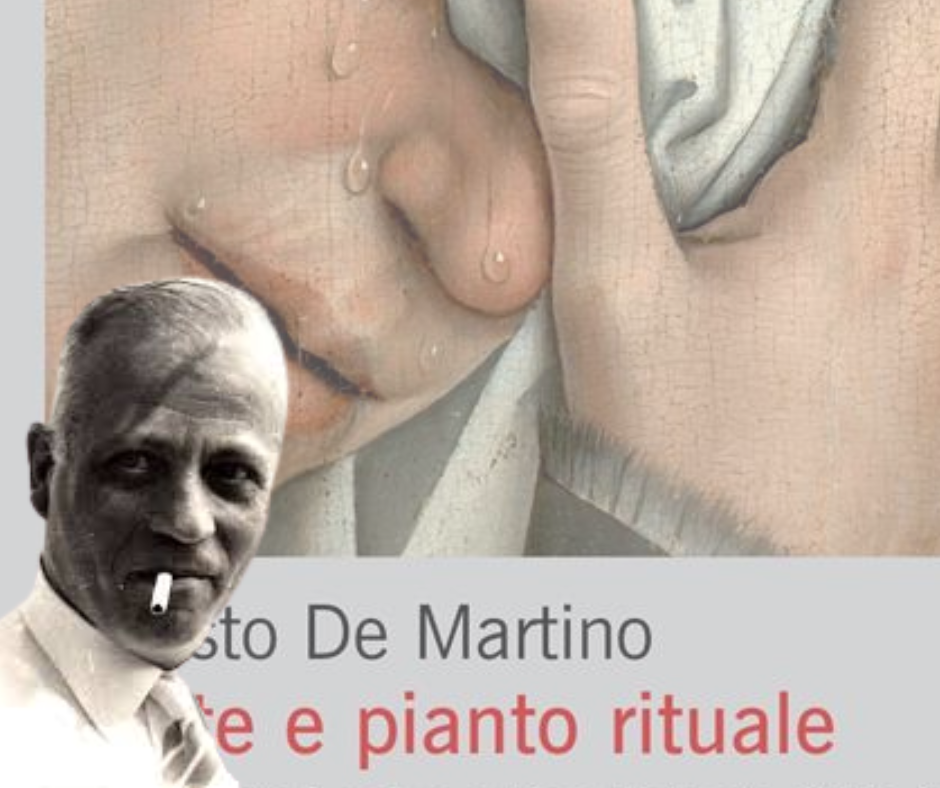
Anche le sue amicizie furono straordinarie, come quella con il meridionalista Rocco Mazzarone, lo scrittore confinato dal fascismo in Basilicata Carlo Levi, l’economista incarcerato dal regime Manlio Rossi-Doria, l’antropologo Ernesto De Martino che prese parte al movimento della Resistenza, Friedrich Friedmann, il filosofo tedesco-americano andato nel Mezzogiorno a conoscere la Weltanschauung, l’esistenza dei contadini e con George Peck, sociologo statunitense che nel 1949 arrivò nell’Italia del Sud per studiare gli effetti sociali della riforma agraria, in connessione con i fenomeni di industrializzazione e di emigrazione.
 Questo perché Scotellaro fu protagonista della stagione delle lotte per l’occupazione delle terre, alla fine degli anni ‘40, da sindaco, al fianco dei contadini, promuovendo la creazione di leghe aderenti alla Camera del Lavoro, agognando una patria nuova. “Il profumo della protesta, piccole faville inseguono l’agognata verità, ma l’alba nuova non si svela”, scrive Di Lena citando il titolo di una delle poesie più significative del sindaco-poeta. Accusato di concussione, sarà ristretto nel 1950 nelle carceri di Matera: troppi i nemici per chi, come lui, viveva per intero le contraddizioni e i drammi del Mezzogiorno post-bellico, segnato dall’irrisolto problema della discontinuità amministrativa con lo sconfitto regime fascista e soprattutto avendo avuto il coraggio, da laico socialista, di sfidare un contesto dominato dalla chiesa cattolica e dal suo clientelismo, divenuto intanto democristiano.
Questo perché Scotellaro fu protagonista della stagione delle lotte per l’occupazione delle terre, alla fine degli anni ‘40, da sindaco, al fianco dei contadini, promuovendo la creazione di leghe aderenti alla Camera del Lavoro, agognando una patria nuova. “Il profumo della protesta, piccole faville inseguono l’agognata verità, ma l’alba nuova non si svela”, scrive Di Lena citando il titolo di una delle poesie più significative del sindaco-poeta. Accusato di concussione, sarà ristretto nel 1950 nelle carceri di Matera: troppi i nemici per chi, come lui, viveva per intero le contraddizioni e i drammi del Mezzogiorno post-bellico, segnato dall’irrisolto problema della discontinuità amministrativa con lo sconfitto regime fascista e soprattutto avendo avuto il coraggio, da laico socialista, di sfidare un contesto dominato dalla chiesa cattolica e dal suo clientelismo, divenuto intanto democristiano.
Riconosciuto innocente e smascherata la natura politica del procedimento, Scotellaro venne liberato dopo quarantacinque giorni. “L’ira dei tiranni che, biasimandoti, sventolarono artificiose calunnie”, chiosa con maestria Di Lena.

E di Lucania racconta ancora in versi Di Lena, una terra, la sua terra, dissacrata dal mercato economico dell’Eni che dagli anni Novanta estrae dalle sue viscere l’8 per cento di idrocarburi del fabbisogno nazionale attraverso vari impianti disseminati nella Val d’Agri, in provincia di Potenza. Come quello di Tempa Rossa, nel comune di Corleto Perticara, “a Tempa rotta la vita s’è rotta” scrive il poeta, riportando il pianto di un pastore “sopra una pecora avvelenata”, chiedendosi – e chiedendoci – “di quale greggio avrà pace?”.
Ironica e pungente, puntuale e profonda, la forza liberatrice della poesia di Di Lena, tra le molte cose, parla anche del dramma umano dei nostri tempi, la pandemia, che ha visto “ospedali pregni d’alterigia” dove “si tocca il niente”. Parlando agli uomini degli uomini, delle loro fragilità, delle loro paure, delle loro miserie e celebrando una delle forme espressive più antiche e più belle divenuta Patrimonio immateriale dell’Umanità.
Mariangela Di Marco, giornalista
Pubblicato martedì 25 Giugno 2024
Stampato il 20/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/quella-poesia-lucana-che-racconta-tutto-il-paese/