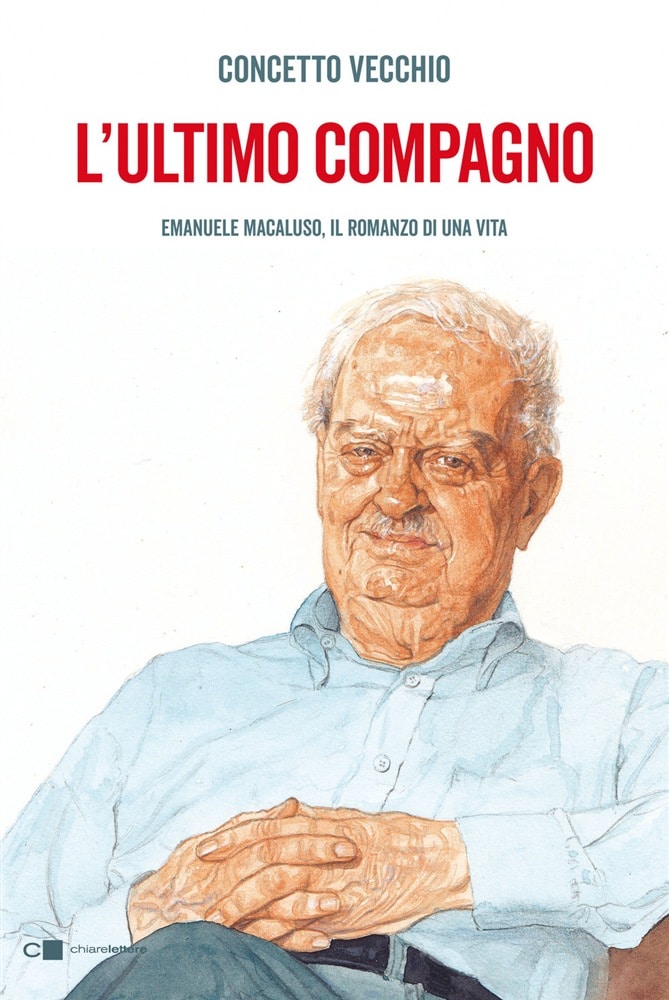 Emanuele Macaluso non ha avuto il tempo di leggere la sua biografia, se n’è andato il 19 gennaio scorso, a 96 anni, nel sonno. Probabilmente su qualche passaggio del libro avrebbe fatto le pulci, era nel suo stile spigoloso, ma poi avrebbe sorriso soddisfatto sotto gli ormai radi baffetti, coi piedi appoggiati sul pouf rosso nella sua casa di Testaccio, strabordante di libri affastellati in un apparente disordine. L’ultimo compagno, di Concetto Vecchio, è sì, come recita il sottotitolo, il romanzo di una vita e come tutti i romanzi ben scritti ha la capacità di catturare il lettore, di trasportarlo nella Sicilia dei primi decenni del Novecento; nelle miniere di zolfo dove uomini e fanciulli si spezzavano la schiena per un salario da fame; sulle strade polverose che il giovane Emanuele percorreva a piedi per decine e decine di chilometri solo per tenere un comizio; nelle piazze assolate dove sfidava a viso aperto la mafia e i suoi gabellotti.
Emanuele Macaluso non ha avuto il tempo di leggere la sua biografia, se n’è andato il 19 gennaio scorso, a 96 anni, nel sonno. Probabilmente su qualche passaggio del libro avrebbe fatto le pulci, era nel suo stile spigoloso, ma poi avrebbe sorriso soddisfatto sotto gli ormai radi baffetti, coi piedi appoggiati sul pouf rosso nella sua casa di Testaccio, strabordante di libri affastellati in un apparente disordine. L’ultimo compagno, di Concetto Vecchio, è sì, come recita il sottotitolo, il romanzo di una vita e come tutti i romanzi ben scritti ha la capacità di catturare il lettore, di trasportarlo nella Sicilia dei primi decenni del Novecento; nelle miniere di zolfo dove uomini e fanciulli si spezzavano la schiena per un salario da fame; sulle strade polverose che il giovane Emanuele percorreva a piedi per decine e decine di chilometri solo per tenere un comizio; nelle piazze assolate dove sfidava a viso aperto la mafia e i suoi gabellotti.

Ma il volume – uscito nell’aprile del 2021 per le edizioni Chiarelettere – è anche, a ben vedere, un testamento politico dell’ultimo grande vecchio del Pci, che in questi ultimi venti anni ha analizzato ostinatamente, con occhio critico e una penna tagliente quelle che anni fa, parlando con chi scrive, aveva definito le occasioni mancate della sinistra italiana. Concetto Vecchio, grande firma di Repubblica, ci restituisce un ritratto fedele di Macaluso e di una lunga e per alcuni versi irripetibile stagione politica, quella del Partito comunista italiano e della sua capacità di leggere, interpretare e poi trasformare in progetto politico i bisogni delle masse popolari e contadine del Paese.

Il passato che queste pagine ci consegnano – anche quello più privato – rappresenta un quadrante utile a non perdere la rotta nel nostro oggi confuso. E già, perché il messaggio in bottiglia che il migliorista Macaluso consegna da queste pagine ai gruppi dirigenti del centrosinistra è la riscoperta della questione sociale. Se oggi la sinistra appare incapace di parlare al suo popolo; se la sua voce, che una volta penetrava nel profondo della società italiana, appare afona, spesso impercettibile è perché fatica a rappresentare il suo blocco sociale di riferimento. Perché ha smarrito l’ancoraggio ai valori del socialismo.

Il Primo maggio del 2019 Macaluso era voluto tornare a Portella della Ginestra, dove nel 1947 era stata fatta strage di braccianti da parte della banda di Salvatore Giuliano. Il libro riporta il suo discorso da quel luogo simbolo delle lotte dei lavoratori meridionali. Macaluso, che nel ’47 aveva 23 anni e già guidava la Cgil provinciale, tanti anni dopo ricordava che «la questione sociale è la ragione per cui la sinistra esiste». Sottolineando con una sferzata polemica che «ci sono stati anche governi di centrosinistra che non hanno riconosciuto il sindacato come interlocutore» (il riferimento, pur non nominandolo, è a Matteo Renzi che nel 2014, da presidente del Consiglio sosteneva: «Se per anni si è pensato che per fare una legge bisogna chiedere il permesso ai sindacati, ci siamo sbagliati»).

Macaluso si è sempre reputato un sindacalista e la sua attività politica inizia proprio dal sindacato. «Era il suo modo di stare al mondo – scrive Concetto Vecchio – Il sindacato epico nella Sicilia dei nostri padri, quando il rappresentante dei lavoratori era l’apostolo dei diseredati, costituì per lui una specie di università». E alla domanda del giornalista di Repubblica su quali sono le qualità che doveva avere allora (ma anche oggi) un sindacalista risponde: «Qualità politiche e umane. Riconoscere i problemi dei lavoratori e saperli esprimere tenendo conto del contesto. Indire uno sciopero e governarlo cogliendo il momento magico per chiuderlo. Firmare i contratti intuendo quando è arrivato il momento giusto per farlo». È una partecipazione vera ai problemi dei lavoratori quella che ha portato Macaluso a impegnarsi in politica. E racconta all’autore di quando la notte non riusciva a prendere sonno «tormentato dai dubbi, avendo davanti agli occhi le facce interrogative dei minatori, degli operai, dei contadini. “Sto facendo la cosa giusta” mi domandavo, girandomi inquieto nel letto».

Con una scrittura avvincente Vecchio ci mostra le tante tessere del mosaico che hanno fatto di Macaluso quello che è poi diventato. Nel 1962 è a Roma, membro della direzione del partito e della segreteria guidata da Togliatti che lo aveva voluto con sé. E poi, tra gli ultimi incarichi la direzione de l’Unità nel 1982 (a volerlo lì fu Berlinguer, verso cui pure Macaluso non aveva risparmiato critiche rispetto alla vicenda del compromesso storico), periodo d’oro per il giornale fondato da Gramsci.

Ma tutto parte da Caltanissetta e da una infanzia fatta di stenti. Quando dice al padre che vorrebbe andare al ginnasio la risposta è amara: «E cuu ci l’avi i soddi. Puoi andare all’avviamento come i tuoi fratelli». Ad imparare un mestiere. E il mestiere in quegli anni è la miniera. La descrizione che Macaluso ne fa richiama alla mente il Charles Dickens di Oliver Twist: «I minatori si calavano nudi nelle viscere della terra, ingabbiati in fitti reticoli scarsamente illuminati a sessanta metri di profondità». Ma l’aspetto più «spaventoso» era l’utilizzo dei minori, i carusi. «Creature avviate alla schiavitù a sei o otto anni» racconta. E la sua non è sociologia, quei ragazzini erano suoi amici, assieme a loro calciava il pallone nella polvere della strade. Come Minicu suo compagno di giochi: il padre per sopportare la vita durissima della miniera si ubriacava e maltrattava la moglie e i figli. «Ogni volta che penso a come eravamo negli anni Trenta, mi viene in mente la faccia triste di Minicu e lo strazio che prorompeva da quella povera casa senza che io potessi farci nulla. Se ho iniziato a fare politica è stato anche perché non volevo sentire più attorno a me quelle grida».

A 17 anni Macaluso compie la sua scelta antifascista, aderisce al Partito comunista. Subito dopo il suo lungo ricovero in sanatorio per la tubercolosi («ero certo che sarei morto giovane») l’adolescente Emanuele va a conoscere Calogero Boccadutri detto “Luzio”, mitica figura di minatore e di comunista, tra i fondatori, negli anni Trenta, delle cellule clandestine del partito, a Favara, nella provincia di Agrigento e a Caltanissetta. «Viveva come un monaco, adottando mille precauzioni», in una casa nuda senza nemmeno uno specchio. Scorrono come sulla pellicola di un film figure prestigiose come Girolamo “Momo” Li Causi, Pio La Torre, Pompeo Colajanni, Elio Vittorini.
L’ascesa politica del giovane dirigente sindacale è folgorante. C’è ambizione certo, ma anche la consapevolezza che la politica «è la vita». A vent’anni è segretario della Camera del Lavoro di Caltanissetta. A 23 anni diventa segretario della Cgil regionale ed è protagonista delle lotte per l’occupazione delle terre, sull’onda delle speranze suscitate dai decreti del ministro dell’Agricoltura, il comunista Fausto Gullo. Lotte in cui si rischiava letteralmente la vita.

Come quando durante un comizio a Villalba, feudo del capo mafioso Calogero Vizzini – davanti a cui, ricorda Macaluso, si scappellava perfino il procuratore del re di Caltanissetta – Momo Li Causi fu ferito ad una gamba dagli sgherri di don Calò: «I picciotti iniziarono a sparare nella nostra direzione. Spararono numerosi colpi di pistola. E lanciarono cinque bombe a mano. Ci riparammo tutti dietro al tavolo. L’unico che rimase al suo posto fu Li Causi». Era stato ferito da un proiettile al ginocchio ma non si nascose, «le pallottole gli fischiavano attorno e lui continuava a parlare».
Rigoroso e spregiudicato Macaluso. È nel 1958 che grazie a lui, racconta l’autore, che prende forma quello che è passato alla storia come il milazzismo, l’operazione che estromise dal governo della Sicilia la Democrazia cristiana. Un fatto enorme. E infatti Togliatti appoggiò l’operazione. Il suo ruolo nella vicenda, Macaluso l’avrebbe pagato caro. La Dc fanfaniana provò a colpirlo sul fronte personale.

Era legato da anni con una donna sposata, Lina (madre dei suoi figli Pompeo e Antonio) conosciuta nel 1941 dopo essere stato dimesso dal sanatorio. Una storia d’amore intensa (e il libro ci regala anche le lettere d’amore tra i due e una foto bellissima di Lina) ma inaccettabile per la cultura ipocrita e perbenista di quegli anni in cui il divorzio era solo un sogno a venire. Emanuele e Lina erano concubini colpevoli, così recitavano le carte, di “aver alterato lo stato civile dopo l’iscrizione all’anagrafe dei figli”. Insomma per la legge di allora i figli avuti da Lina non potevano essere i suoi. E lui invece li aveva riconosciuti come tali.
Uomini dei servizi segreti del Sifar avevano seguito per mesi la famiglia, aprendo un dossier. Già nel 1944 per la sua storia d’amore, assieme alla compagna, conobbe il carcere. Stavolta fu costretto ad allontanarsi dalla Sicilia per diversi mesi e a rifugiarsi in un casolare del Modenese.

Ma perbenismo, o meglio la doppia morale, vi fu pure nel Pci che non lo mandò alla prima scuola di partito a Roma perché convivente. «Erano sicuri che il popolo non avrebbe apprezzato. Il popolo! Erano ancora della stessa idea trent’anni dopo, certi che i siciliani si sarebbero schierati contro il divorzio al referendum del 1974». E invece il no trionfò anche in Sicilia.
È un libro da leggere L’ultimo compagno. Anche perché – e su questo Vecchio fa con grande onestà intellettuale mea culpa – straccia via tanti luoghi comuni e tanti pregiudizi sui miglioristi del Pci, dipinti per anni come attaccati al potere per il potere, proni nelle trattative, quasi quinte colonne del craxismo nel Pci. La vita di Macaluso, la sua libertà di pensiero, la sua fede nelle conquiste quotidiane di migliori condizioni di vita per i ceti popolari la sua fede nel socialismo, sono lì – almeno nel suo caso – a dimostrare il contrario.
Pubblicato mercoledì 21 Luglio 2021
Stampato il 03/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/quel-politico-apostolo-dei-diseredati-nella-sicilia-delle-zolfatare/






