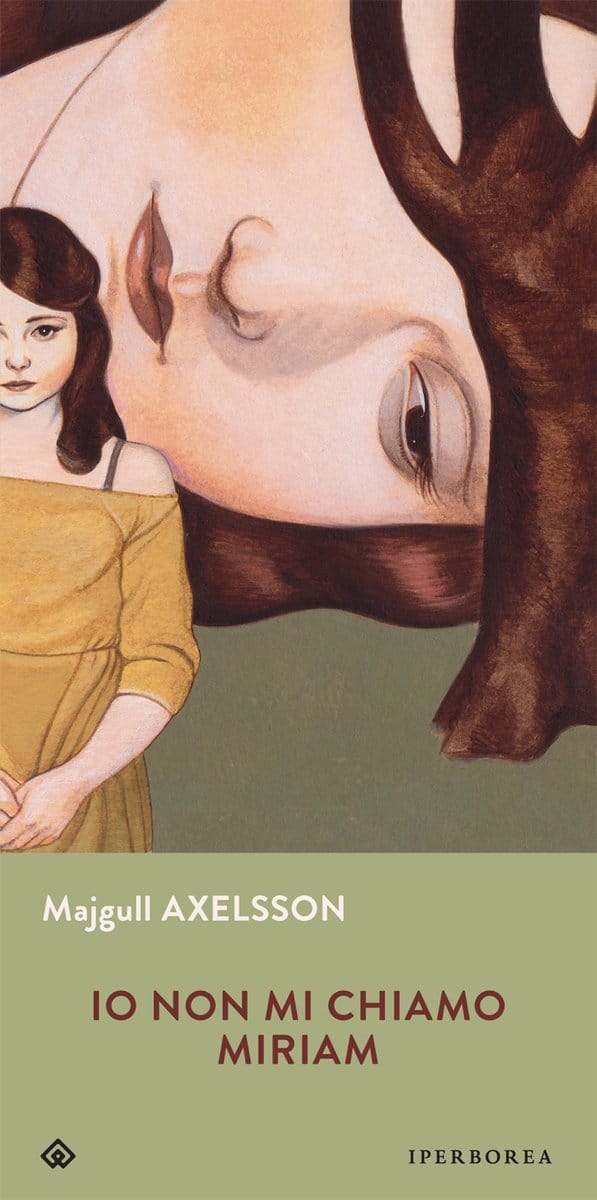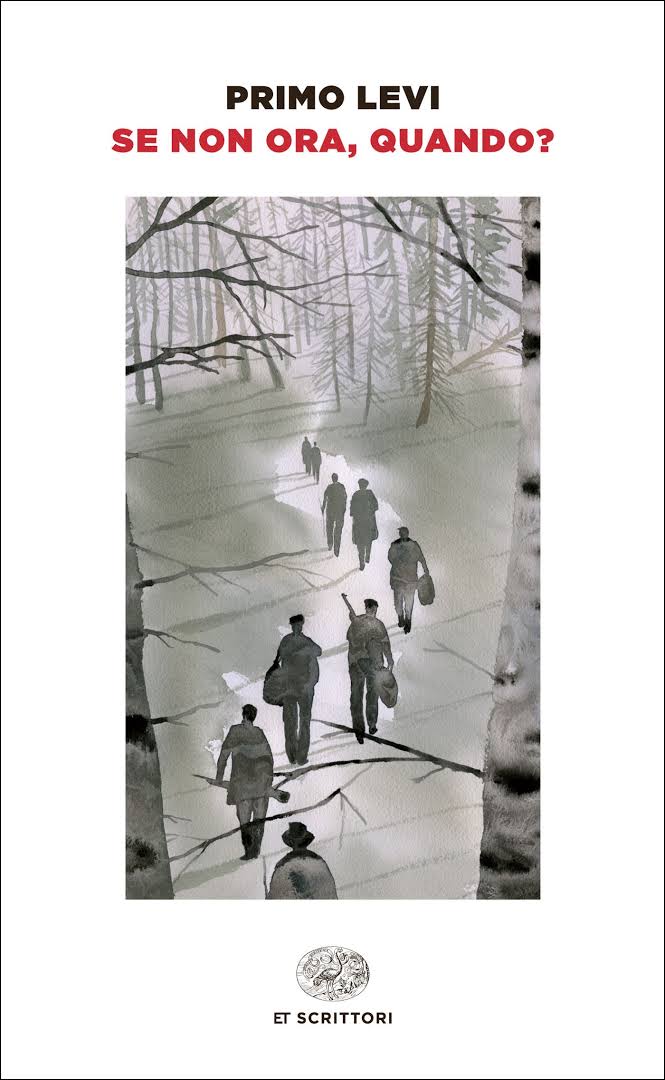
 Per quanto si tratti di un fenomeno laterale rispetto ad altri movimenti partigiani europei, è esistita una Resistenza armata di ebrei che non intendevano in nessun modo farsi condurre docilmente alle camere a gas da parte dei nazisti.
Per quanto si tratti di un fenomeno laterale rispetto ad altri movimenti partigiani europei, è esistita una Resistenza armata di ebrei che non intendevano in nessun modo farsi condurre docilmente alle camere a gas da parte dei nazisti.
Per quanto limitata, questa lotta è stata argomento di uno dei libri meno compresi e letti di Primo Levi, ossia Se non ora quando, uscito nel 1982, che racconta le vicende di alcuni partigiani ebrei polacchi. Nella galassia dell’opposizione ebraica va menzionata la brigata che prendeva il nome dai fratelli Bielski, partigiani ebrei bielorussi che salvarono dai ghetti centinaia di persone e di cui ha scritto la storica Nechama Tec (Gli ebrei che sfidarono Hitler, uscito nel 1993 per Sperling e Kupfer).
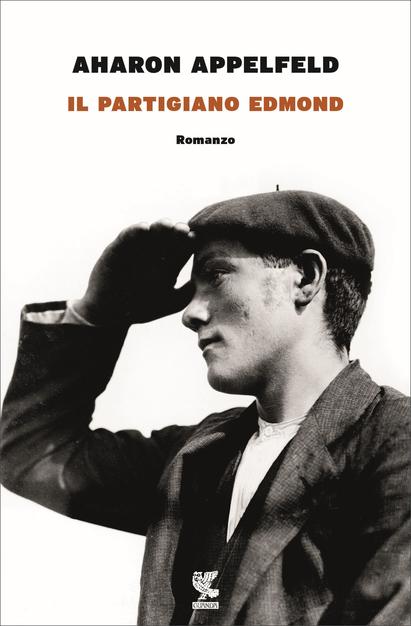 Possiamo ricordare anche Il partigiano Edmond, il romanzo di Aharon Appelfeld (scomparso nel 2018) che prova a correggere, fosse anche di un millimetro, lo stereotipo della passività degli ebrei di fronte al bestiale progetto di sterminio dei nazisti nei loro confronti. I partigiani di Appelfeld non intendono essere condotti alla morte come “pecore al macello”, per usare l’espressione di Abba Kovner, poeta e capo della resistenza ebraica nel ghetto di Vilnius.
Possiamo ricordare anche Il partigiano Edmond, il romanzo di Aharon Appelfeld (scomparso nel 2018) che prova a correggere, fosse anche di un millimetro, lo stereotipo della passività degli ebrei di fronte al bestiale progetto di sterminio dei nazisti nei loro confronti. I partigiani di Appelfeld non intendono essere condotti alla morte come “pecore al macello”, per usare l’espressione di Abba Kovner, poeta e capo della resistenza ebraica nel ghetto di Vilnius.
Adesso c’è a disposizione del lettore anche La resistenza ebraica in Europa di Daniele Susini, un testo che ci fornisce una veduta d’insieme sul tema e che colma un vuoto nella storiografia di lingua italiana sull’argomento.
 La tesi di Susini è che bisogna abbandonare il luogo comune della passività degli ebrei di fronte al nazismo, il quale esercitò, come sappiamo, un potere di morte inedito e irresistibile e tuttavia, come documenta l’autore, sperimenterà svariate forme di opposizione da parte degli ebrei. La tesi sulla sostanziale remissività ebraica è stata sostenuta da storici importanti come Raul Hilberg o da testimoni e poi studiosi come Bruno Bettelheim; quest’ultimo in particolare è quello che ha le parole più dure contro la mancata opposizione ai nazisti da parte degli ebrei: in buona sostanza se la sono voluta, sembra ammettere in un libro come Il cuore vigile.
La tesi di Susini è che bisogna abbandonare il luogo comune della passività degli ebrei di fronte al nazismo, il quale esercitò, come sappiamo, un potere di morte inedito e irresistibile e tuttavia, come documenta l’autore, sperimenterà svariate forme di opposizione da parte degli ebrei. La tesi sulla sostanziale remissività ebraica è stata sostenuta da storici importanti come Raul Hilberg o da testimoni e poi studiosi come Bruno Bettelheim; quest’ultimo in particolare è quello che ha le parole più dure contro la mancata opposizione ai nazisti da parte degli ebrei: in buona sostanza se la sono voluta, sembra ammettere in un libro come Il cuore vigile.

In realtà, come si potrà leggere nelle pagine di Susini, gli ebrei non furono semplicemente tutti un’unica massa passiva disponibile allo sterminio. Si tratta di capovolgere la prospettiva vittimaria, che è poi anche quella condivisa dal carnefice nazista, per documentare atti di coraggio individuale o organizzati. E in un contesto quale quello della violenza tedesca è casomai opportuno chiedersi come mai alcuni ebrei decisero di contrastare un crimine – il genocidio – così organizzato, sistematico e feroce da non lasciare quasi spazio a forme di opposizione.
 Si tratta, dunque, per Susini di registrare come la “soluzione finale” suscitò una vasta fenomenologia di reazioni: dall’accettazione del proprio destino di ebrei, alla negazione del principio di realtà di fronte a quanto stava accadendo, passando per la sottovalutazione delle intenzioni dei tedeschi, spesso dovuta alla mancanza di informazioni certe e alla proliferazione di false notizie – come la morte di Hitler – che lasciavano gli ebrei in una totale indecisione e attesa che alla fine risultò fatale (è sufficiente leggere l’impressionante e doloroso diario di Dawid Sierakowiak dal ghetto di Lodz).
Si tratta, dunque, per Susini di registrare come la “soluzione finale” suscitò una vasta fenomenologia di reazioni: dall’accettazione del proprio destino di ebrei, alla negazione del principio di realtà di fronte a quanto stava accadendo, passando per la sottovalutazione delle intenzioni dei tedeschi, spesso dovuta alla mancanza di informazioni certe e alla proliferazione di false notizie – come la morte di Hitler – che lasciavano gli ebrei in una totale indecisione e attesa che alla fine risultò fatale (è sufficiente leggere l’impressionante e doloroso diario di Dawid Sierakowiak dal ghetto di Lodz).

Susini ricorda che, in particolare, nei campi “la remissività, lungi dal portare alla salvezza, rappresentava garanzia di morte certa”; a questo proposito è decisivo ancora una volta Primo Levi. Infatti che cos’è Se questo è un uomo se non il resoconto di una strenua volontà di resistenza e sopravvivenza di fronte al nemico che ha eliminato, nei tuoi confronti, ogni residuo di umanità? Susini, riprendendo la tesi di uno storico importante come Yehuda Bauer, allarga, ma senza neutralizzarlo estendendolo troppo, il concetto di resistenza, da quella armata ad altre forme di opposizione; si tratta infatti di sottolineare la “dignità in condizione estreme e quindi considerare ‘resistenza’ tutte le azioni, di singoli o collettive, che in qualche modo contrastarono o ritardarono la distruzione del popolo ebraico o che temporaneamente ne migliorarono la qualità della vita o comunque ne evitarono un peggioramento.

In questa categoria si inseriscono, oltre alle azioni armate, il contrabbando di cibo, le attività religiose, culturali, educative, la diffusione o la raccolta di informazioni oppure atti caritatevoli o gesti di solidarietà volti a non perdere la propria intima e personale dignità”. Naturalmente questa definizione di resistenza è stata soggetta a contestazione, per esempio da parte di Raul Hilberg che non riconosce come “resistenti” i tentativi di sopravvivenza, il salvataggio di ebrei o l’aver conservato pratiche religiose pur in condizioni avverse; per questo storico la violenza organizzata contro il nazismo è l’unica attività che legittimamente possiamo definire “resistenza”. Più possibilista, per fare un nome tra tanti, Annette Wieviorka che in Auschwitz spiegata a mia figlia parla di resistenza passiva accanto a quella attiva.

Gran parte del saggio è dedicata al racconto di questa resistenza non armata. Ciò che avveniva nei ghetti, nelle scuole, nella sinagoga, le stesse operazioni di salvataggio di ebrei potrebbero rientrare in questa cornice se, in qualunque modo e in qualsiasi luogo, hanno concorso a opporsi al nazismo. Si potevano mantenere le attività religiose o un residuo di attività didattiche e ludiche nei ghetti: nel ghetto di Varsavia Rosa Simchowicz e Estera Markisz allestivano angoli gioco e preparavano pasti caldi per i bambini.

È interessante anche l’analisi svolta sul funzionamento dei cosiddetti Judenräte, i consigli ebraici, che in alcuni casi, pensando di evitare il peggio, collaborarono con i nazisti, si pensi al caso di Chaim Rumkowski che fornì le liste degli ebrei di Lodz da mandare alle camere a gas, un esempio di carnefice e vittima, di cui Levi scrisse ne I sommersi e i salvati. Sebbene meno conosciuti della rivolta del ghetto di Varsavia, ci sono anche i fatti di quello di Tuczin in Volinia (Ucraina) da dove, nel settembre del 1942, tra 1.000 e 2.000 ebrei, grazie all’aiuto dello Judenrat, riuscirono a fuggire, anche se sopravvissero solo in 13.

Possiamo ricordare inoltre le pagine dedicate da Susini alla resistenza armata organizzata, come l’Armèe juive di Abraham Polonski, alla brigata Bielski, alla figura di Marek Edelmann, alla Resistenza ebraica in Italia. Infine, un’altra forma da valutare attentamente, e senza enfatizzarne la portata, è quella nei campi di sterminio che incarnavano l’essenza genocidaria. Uscirne vivi, a parte l’aiuto del caso e della fortuna, poteva anche interpretarsi come il risultato della propria resistenza personale ma, insegna ancora l’autorità di Primo Levi, per opporsi, nei campi, bisognava essere in forze, rifocillati, vestiti e calzati.

Susini ci ricorda di sommosse collettive nei campi di Treblinka (agosto 1943) o di Sobibór (ottobre 1943), e quella dei Sonderkommando ad Auschwitz (ottobre del 1944). Certo, nella maggioranza dei casi lo sterminio non fu fermato né rallentato, tuttavia si poteva provare almeno a morire con dignità e non come pecore mandate al macello. Nella nota finale a Se non ora quando, Levi riporta una massima rabbinica del II secolo d.C. (da cui aveva preso il titolo del romanzo) che potrebbe essere il punto di partenza per studiare la possibilità e la realtà di una resistenza ebraica: “Egli [il rabbino Hillel] diceva pure: Se non sono per me, chi sarà per me? E quand’anche io pensi a me, che cosa sono io? E se non ora quando?”.
Pubblicato venerdì 11 Giugno 2021
Stampato il 04/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/non-solo-vittime-anche-combattenti/