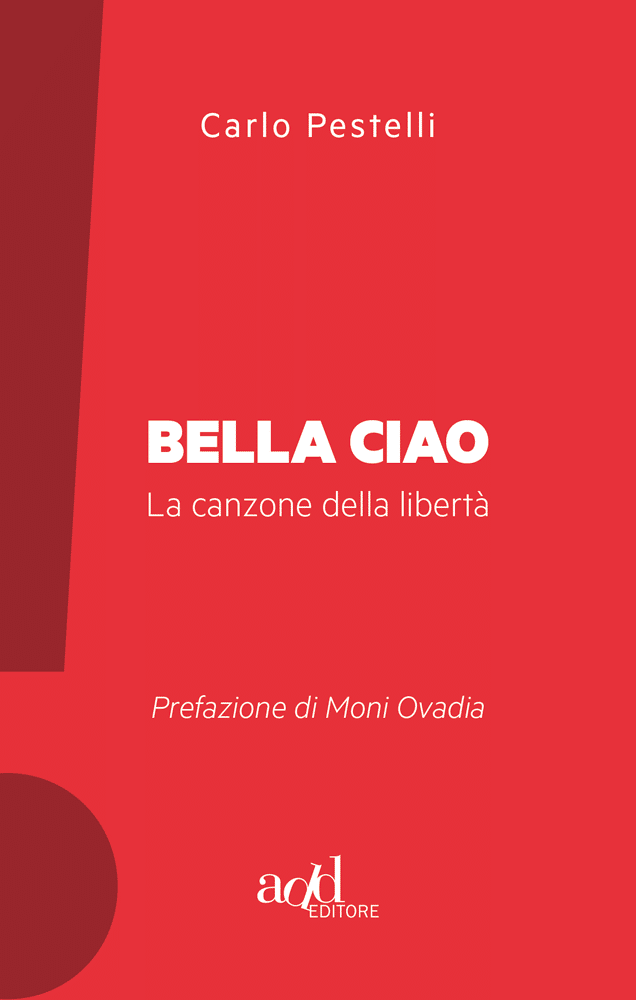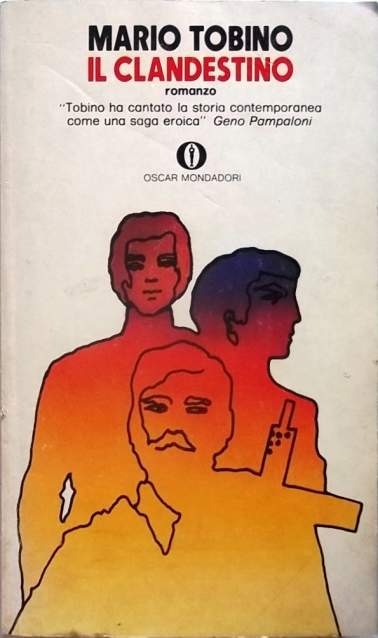Sfoglio tre o quattro antologie di letteratura italiana, più e meno recenti, tra quelle disponibili in sala insegnanti; cerco un breve profilo, il nome almeno di Renata Viganò, lo stralcio di uno dei suoi scritti. Niente, non c’è niente nemmeno nelle sezioni dedicate alla letteratura della Resistenza.
Certo, si tratta di un esperimento non esauriente ma comunque significativo: l’infermiera partigiana, autrice de L’Agnese va a morire (1949), non è nel canone.
Eppure questo romanzo fu accolto con entusiasmo da Natalia Ginzburg, allora redattrice presso Einaudi, che le scrisse: «Magnifico stile misurato, sobrio, magnifici effetti di paesaggio… Da farsi. Da farsi. Da farsi»; le valse il Premio Viareggio e venne tradotto il 14 lingue; il regista Giuliano Montaldo ne trasse l’omonimo film nel 1976, film che la Viganò – classe 1900 – non vide mai perché morì in quello stesso anno.
Sebastiano Vassalli, nella prefazione per l’edizione della collana “Letture per la scuola media”-Einaudi (1974), scrisse:
 «Ciò che a mio parere rende quest’opera così rappresentativa della guerra di liberazione è il fatto che sia così poco epica. Ciò che la rende così interessante alla lettura, così resistente al tempo è la purezza del dettato, la mancanza di ogni enfasi retorica. Ciò che infine la rende un’opera d’arte è la figura della protagonista, della contadina cinquantenne Agnese [… che] si è volontariamente annullata per seguire un’idea».
«Ciò che a mio parere rende quest’opera così rappresentativa della guerra di liberazione è il fatto che sia così poco epica. Ciò che la rende così interessante alla lettura, così resistente al tempo è la purezza del dettato, la mancanza di ogni enfasi retorica. Ciò che infine la rende un’opera d’arte è la figura della protagonista, della contadina cinquantenne Agnese [… che] si è volontariamente annullata per seguire un’idea».
Pare però non sia andata così, che le pagine di Renata non siano resistite al tempo, ed è davvero un peccato non trovarne traccia nei manuali scolastici: la sua scrittura asciutta, semplice e assieme esatta meriterebbe di essere conosciuta e più ancora, forse, le storie che così sono state raccontate. Storie di Resistenza, certo, ma non solo, anche di provincia e campagna, di povera, umanissima gente e di ambizioni spesso stroncate, ancorché modeste. L’esperienza dello scacco subito, del resto, la visse anche Renata, piccola borghese col sogno di diventare medico, costretta poi, dalle traversie economiche famigliari, ad accontentarsi della professione di inserviente e poi infermiera negli ospedali bolognesi: «Ebbi così – scrisse – il mio posto nella classe operaia».
La rete è un po’ più generosa nella ricerca di informazioni sulla nostra autrice. Vanno senz’altro segnalati: il piccolo cammeo sul sito dell’ANPI; la voce “Renata Viganò” nell’enciclopedia delle donne, con numerosi stralci dai suoi racconti e importanti rimandi bibliografici; infine la pagina di storiedimenticate, che riporta uno dei suoi cinque articoli rivolti alle donne e usciti sul foglio clandestino “La Comune” e l’intero resoconto autobiografico La mia guerra partigiana, pubblicato nel volume La Resistenza a Bologna (a cura di L. Bergonzini e L. Arbizzani, ed. Istituto per la storia di Bologna, 1967-89), e poi raccolto in Matrimonio in brigata (R. Viganò, 1976); sempre su questo sito si trova il rimando al “Dizionario biografico online degli antifascisti, partigiani e vittime del fascismo nel bolognese: 1919-1945“, a cura di A. Albertazzi, L. Arbizzani, N.S. Onofri.
Ma è probabilmente l’opera della partigiana-scrittrice la miglior fonte per conoscerla, a partire dalle già citate memorie La mia guerra partigiana: pagine dense eppure essenziali in cui è racchiusa non solo la storia poliedrica di una donna moglie, madre, infermiera e partigiana, ma anche il compendio dell’intera guerra di Liberazione osservata dalla prospettiva “ad altezza uomo” di chi ne prese parte mossa prima dall’istinto e dagli affetti che dall’ideale, pure presente.

In questo senso Renata – e con lei le molte donne che incrociò e con cui collaborò – è come Agnese: «combatte con i partigiani, anzi con partigiani appartenenti a formazioni fortemente politicizzate: ma i suoi moventi non sono politici. La chiamano “compagna”, ed in effetti lo è: ma per scelta istintiva, anzi neppure per scelta, per consapevolezza maturata in lunghi anni di silenzio con un processo più biologico che logico, come il grano di frumento che stando dentro la terra mette radici, e fusto, e spiga» (Vassalli).
Renata racconta che per anni, da giovane lavoratrice, del fascismo e della dittatura non le era importato molto; fu grazie ad una collega, Bianca Fontana, che si accorse davvero delle condizioni in cui versava l’Italia in quegli anni, delle violenze e del carcere per gli oppositori politici: così prese ad odiare «tutto ciò che era fascista, i loro canti, i loro morti, il loro aspetto funereo».
E fu proprio un ex detenuto e confinato politico sorvegliato dalla polizia, il giovane Antonio Meluschi, che conobbe nel ’35 e sposò di lì a poco, dopo avergli dato rifugio e ospitalità in casa. Vivevano in povertà, ebbero guai col regime e un figlio, Agostino; quando scoppiò la guerra e, dentro quella, la Resistenza e Antonio divenne comandante partigiano, lei lo seguì e fu ai suoi ordini, per dar da mangiare, vestire e curare i «ragazzi», come li chiamava confidenzialmente e sempre col suo bambino, che fu con lei quasi ininterrottamente durante il conflitto.
Renata seguì il marito comandante delle brigate Garibaldi come la bisnonna materna, Caterina Mazzetti, aveva seguito il figlio volontario con le camicie rosse di Garibaldi: entrambe mosse da qualcosa di più viscerale dell’ideale politico, che a questo dava sostanza e forza.
Renata Viganò combatté intensamente, talvolta con incosciente coraggio, ma senza forse comprendere davvero il suo ruolo, almeno fino a quando – tornata la pace – non ricevette un pezzo di carta:
«No: davvero non avevo mai pensato che sarei stato un ufficiale.
Mi è venuta invece la comunicazione dal comando partigiano: […]
“Renata Viganò – dirigente del servizio sanitario della Brigata delle Valli. Uomini: partigiani 1400, patrioti 600. Grado: tenente”.
[…] Ricevuta la comunicazione, andai dai carabinieri per una firma. […] il maresciallo levò la faccia, guardò il pezzo di carta, guardò prima il bambino poi me.
– Bisogna che venga lui, – disse restituendomi il foglio. […]
– Chi lui?
– L’ufficiale, – rispose il maresciallo, un po’ offeso dalla mia lentezza nel capire.
– Ma l’ufficiale sono io, – dissi con umiltà.
Ancora guardò il bambino, me, poi la carta. Mise il timbro e la firma. Sorridevano tutti e tre, quello all’altra scrivania e la scorta.
Avevano ragione. È un po’ strano che un tenente sia una donna piuttosto anziana con un bambino per mano. Mi venne in mente Raoul, il suo mantello azzurro, la divisa a doppio petto, la spalla destra leggermente sollevata per il gesto di sostenere la sciabola. Rividi il suo buffo berretto a tubo di stufa, il suo aspetto dolcemente onesto, fiero ed ingenuo. Davvero, era tutta un’altra cosa.
Eppure io la guerra l’ho proprio fatta così: senza sapere di essere un ufficiale, col bambino per mano e il tritolo nella borsa della spesa» (da L’ufficiale sono io, in Arriva la cicogna, 1941).
Ecco, almeno un poco, chi fu Renata Viganò; la speranza è quella che in molti possano ancora conoscerla e apprezzarla, almeno quanto sono noti e apprezzati altri scrittori-partigiani, come Calvino, Fenoglio, Meneghello…
Per dar gambe a simile speranza occorre lavorare su più livelli: innanzitutto nelle scuole, proponendo la sua storia e le sue storie ai più giovani, divulgando quanto già pubblicato; poi nelle università, affidando tesi di laurea o di dottorato; ma occorre anche continuare nella ricerca, per esempio studiando il fondo Viganò-Meluschi, depositato dall’ANPI di Bologna alla biblioteca dell’Archiginnasio nel 2014 e lì in attesa di una rigorosa e attenta lettura.
Pubblicato giovedì 13 Ottobre 2016
Stampato il 02/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/lufficiale-renata-vigano-agnese-le/