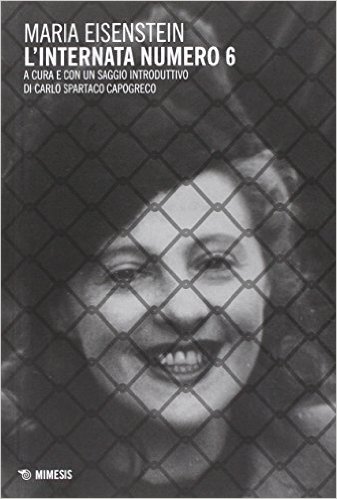Il silenzio della collina a cui Alessandro Perissinotto fa riferimento nel suo ultimo romanzo (Mondadori, pp. 245, €19) è quella forma di omertà, di reticenza, di colpevole oblio che troppo spesso, in passato, ha messo a tacere le violenze di un fazzoletto di terra e degli uomini che la abitano. La vicenda è una di quelle “storie vere”, solo disposta in un quadro d’invenzione narrativa, un po’ per rispetto di chi ne è un autentico reduce, un po’ “perché talvolta, su un fondale di finzione, la realtà spicca più nitida”.
Il silenzio della collina a cui Alessandro Perissinotto fa riferimento nel suo ultimo romanzo (Mondadori, pp. 245, €19) è quella forma di omertà, di reticenza, di colpevole oblio che troppo spesso, in passato, ha messo a tacere le violenze di un fazzoletto di terra e degli uomini che la abitano. La vicenda è una di quelle “storie vere”, solo disposta in un quadro d’invenzione narrativa, un po’ per rispetto di chi ne è un autentico reduce, un po’ “perché talvolta, su un fondale di finzione, la realtà spicca più nitida”.
Partiamo dunque da questo sfondo. Siamo ad Alba, la città di Fenoglio, della Ferrero e dei vini, e nella camera quieta e sterile di un hospice trascorre gli ultimi giorni della propria esistenza un uomo anziano, Bartolomeo Boschis, assistito dalle cure più o meno premurose delle infermiere, finché ad accompagnarlo nella penosa decadenza non giunge da Roma il figlio partito tempo prima per diventare qualcuno. Ora Domenico Boschis è un attore di fiction televisive, interpreta un medico alle prese coi pazienti ma anche con tante vicende amorose, e in passato ha vestito parecchi ruoli, perfino quello del genitore di una bambina rapita e violentata.
Quella che ritrova ad Alba, però, è la vita vera. Nonostante le pareti dell’hospice cerchino di smussare le asprezze della sofferenza, con tenui colori alle pareti, con le stanze marcate dal nome di un fiore, Bartolomeo Boschis, detto Tomé, patisce le doglie delle ultime battute prima che tutto finisca. Domenico, da parte sua, non riesce a provare tenerezza per il vecchio, né un senso di pietà: sotto la cenere del loro distacco cova una fiamma di incomprensioni e di ostilità. Tuttavia quel genitore morente ha un che di strano, qualcosa che attira Domenico in un vortice di domande e di dubbi sempre più angoscianti.

Il vecchio, che per anni è stato un violento e un vigliacco, ora piange spesso, improvvisamente, cambiando le labbra fino a poco prima socchiuse in una “voragine spalancata, l’oscena piaga rossa, beante, da cui sgorga il pianto terrorizzato e muto”. Che cosa nasconde?
La domanda inizia ad assillare Domenico. I gemiti scoppiano fulminei quando l’uomo ricorda qualcosa, una ragazza – s’intuisce dal biascicare contorto – la cui immagine, evidentemente, tormenta la memoria dell’anziano. Ma chi è?
L’attore televisivo intraprende così una quête, un vero e proprio itinerario che sposta il baricentro psicologico del protagonista dall’universo della capitale – in cui ha edificato carriera e provvisori affetti – alla periferia delle Langhe, e che è, ancora, una ricerca del tempo perduto. Alba, infatti, assieme al suo bagaglio di legami di terra, alle storie fenogliane, al vino spremuto con fatica dalle colline, era stata per Domenico una prigione quando, adolescente, prese a odiare quanti davano per scontato che i luoghi ti determinano, sognando, al contrario, un’esistenza da giovane cosmopolita – se vogliamo – affascinato dalle mode: “la mimetica, specie quella che tutti chiamavano ‘la verdona’, era solo una tappa dell’adolescenza come Il Profeta di Gibran e i romanzi di Hesse”.
Così c’era stato l’abbandono e ora è giunto il momento della riconciliazione. Il ritorno ad Alba è prima di tutto una reimmersione nella lingua, nei suoni del dialetto – il nome del padre, “Tomé, con la ‘o’ pronunciata come ‘u’” –, nelle espressioni idiomatiche – l’andare “in” Alba anziché “ad” Alba, oppure lo stare “sul suo”, sulla propria roba, nella proprietà di famiglia. Domenico si riappropria infatti della cascina del padre, la Colombera, del suo cane, Pajun, e della “potenza del dialetto che lasciava macchie, o ricami, anche sull’italiano di chi aveva studiato”. Poi torna l’intesa coi profumi, con le abitudini, con quei meccanismi di godimento primordiali – vissuti nell’infanzia – quali lo scorrazzare per la campagna in motocicletta e il sentire il vento in faccia in una giornata di sole.
Lentamente tornano abitudini dimenticate, che sembrano uscire da un altro mondo (Domenico si trova a ordinare al bar un Biancosarti al posto di un più modaiolo Spritz), tornano – quantunque con fatica e con avversione – i gesti intimi verso quel padre padrone che era stato Tomé; ma soprattutto l’attore di successo riscopre le antiche amicizie, quella con Umberto, il figlio del farmacista, e con Caterina, il primo amore. C’è intesa tra loro; a volte tutti assieme, a volte in coppia, scoprono nuovi tasselli riguardanti la storia della ragazza che tormenta il morente.
 Intanto, mentre assiste il padre, Domenico intreccia una relazione con Gilda, un’infermiera che rappresenta in maniera mirabile la sintesi tra il dolore aleggiante sui letti dei degenti e la leggerezza necessaria per sopravvivere allo strazio, nel cuore del microcosmo dell’hospice in cui dialogano le verità aride dell’esistenza – messe in luce dal cinico dottor Falcini – e la debole ipocrisia delle promesse di guarigione e della speranza di un domani, simboleggiata dalle camere con le tinte pastello.
Intanto, mentre assiste il padre, Domenico intreccia una relazione con Gilda, un’infermiera che rappresenta in maniera mirabile la sintesi tra il dolore aleggiante sui letti dei degenti e la leggerezza necessaria per sopravvivere allo strazio, nel cuore del microcosmo dell’hospice in cui dialogano le verità aride dell’esistenza – messe in luce dal cinico dottor Falcini – e la debole ipocrisia delle promesse di guarigione e della speranza di un domani, simboleggiata dalle camere con le tinte pastello.
Si sente lo sforzo di una nuova vita che deve fare i conti col passato. “L’Altrove ha un cuore longevo”, scriveva qualche anno fa Marisa Fenoglio, tentando di dar voce al sentimento di malinconia e all’impossibilità di un completo ritorno col quale la donna, in quanto emigrante, ha per molto tempo convissuto. E il cuore longevo dell’Altrove è ciò che ritrova anche Domenico, la cui riappropriazione dei luoghi natali sbuccia la patina ossimorica dei tempi recenti (la “rustica raffinatezza”, la “studiata naturalezza”, la “modernissima tradizione” delle cascine ristrutturate per i turisti), così da riaffondare a colpi di vanga nella realtà più schietta: quella terrigna e fenogliana del genius loci, quella che non vuole eludere né la durezza delle condizioni di vita né la violenza che, al contrario, il velo della contemporaneità virtuosamente nasconde, non senza una certa dose d’ipocrisia volontaria. Alla mente del lettore, come a quella di Domenico, tornano la notte tremenda della Gaminella, il corpo di Santa sepolto nella vigna, “la natura profonda di quella terra, all’apparenza così piena di grazia, in realtà selvaggia e feroce”; si ripetono le miserie narrate da Lajolo, Arpino e Revelli, ma soprattutto riaffiorano le violenze antiche che fanno capolino nella Malora di Fenoglio, il gioco d’azzardo, le niagariche rovine di denari e di poderi e, infine, le violenze usate sulle ragazzine.
 Ecco cosa scopre Domenico. Che suo padre non è stato diverso da Agostino Braida, da Tobia, da uno dei fratelli Brusca di Castino. In quel mare d’onde che sono le colline si è annidato il Male, e quello “non era manifestazione di un’anomalia, ma il frutto di una collaborazione razionale tra persone normali”. Persone normali e malvagie. Come Tomé. Gente che aveva trasformato le Langhe in un posto non tanto diverso da Cleveland, dall’Austria o dal Belgio, luoghi dalla tetra fama, abitati da mostri che rapiscono, torturano e violentano bambine innocenti.
Ecco cosa scopre Domenico. Che suo padre non è stato diverso da Agostino Braida, da Tobia, da uno dei fratelli Brusca di Castino. In quel mare d’onde che sono le colline si è annidato il Male, e quello “non era manifestazione di un’anomalia, ma il frutto di una collaborazione razionale tra persone normali”. Persone normali e malvagie. Come Tomé. Gente che aveva trasformato le Langhe in un posto non tanto diverso da Cleveland, dall’Austria o dal Belgio, luoghi dalla tetra fama, abitati da mostri che rapiscono, torturano e violentano bambine innocenti.
Chi è la ragazza, dunque, che fa spalancare le fauci terrorizzate del morente? È Maria Teresa Novara, una tredicenne rapita a Villafranca d’Asti, nel dicembre del 1968, e tenuta segregata per mesi in una cascina di Barbisa, frazione di Canale d’Alba; i rapitori, due maledetti balordi, due ladri che, in mancanza di bottino, pensarono di sfruttare la ragazza, facendo perno sull’ancestrale abitudine, già tratteggiata da Fenoglio, di “usare” le giovani. Maria venne imprigionata in cantina, legata come un cane e violentata dalla “gente per bene” che pagava profumatamente i due carcerieri.
E il ruolo di Bartolomeo Boschis nella vicenda? Si scopre leggendo il libro; che è, perciò, anche un romanzo di denuncia, il tentativo di strappare dalle pieghe sempre più strette del passato una storia vera che non deve essere dimenticata e che, anzi, da tempo aveva bisogno di venir riscritta e sollevata dalla rimozione collettiva per ripulirla dalle brutture con le quali la stampa di allora insudiciò la memoria della ragazza, additata da Famiglia Cristiana come “fanciulla degradata” e dall’onorevole missino Beppe Niccolai come bambina uccisa “dal vizio prima che dalla morte”.
Così, alla fine, ci chiediamo, ribaltando una domanda che Domenico si pone in qualche passo del romanzo: davvero molte parole sono sopravvissute alla scomparsa del loro significato, come ‘malora’ o ‘mezzadria’, o forse è meglio dire che il contenuto del loro significato è lì, vivo e vegeto, soltanto un po’ nascosto dall’ipocrita disinfezione della contemporaneità?
Giacomo Verri, scrittore
Pubblicato giovedì 7 Marzo 2019
Stampato il 31/03/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/lorrido-segreto-della-genteperbene/