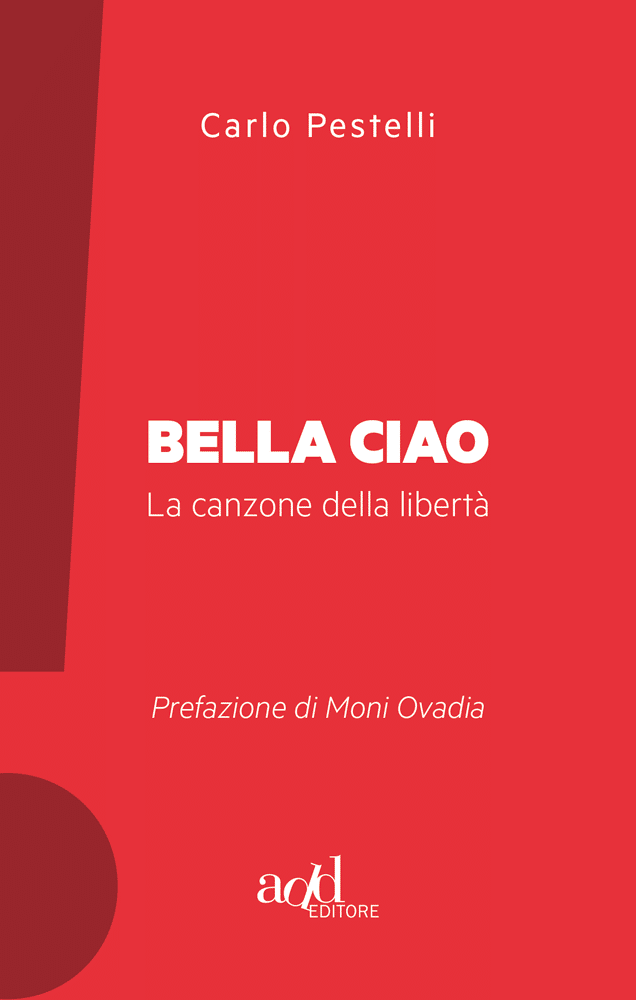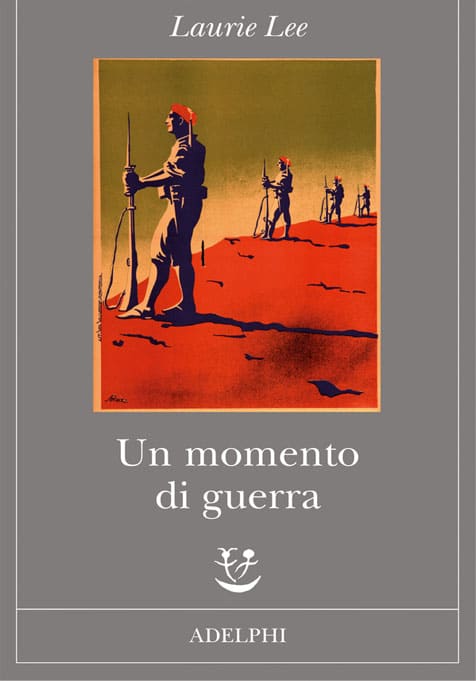Se, giocando con le citazioni, si è detto che Umberto Eco era “l’uomo che sapeva troppo”, possiamo aggiungere che Il nome della rosa è il romanzo di cui si è scritto troppo. Elogiato, criticato, oggetto d’imitazioni, parodie, palinsesti, quella storia medievale – che strizza l’occhio alla contemporaneità – di monaci uccisi per un libro è ormai divenuta un classico su cui schiere di critici si sono succeduti instancabilmente, come le onde sulla battigia, a dire la loro: opera aperta, opera chiusa, testo postmoderno, giallo deduttivo, romanzo storico, filosofico, di formazione, gotico, ecc… Tutto questo insieme, nelle fitte pagine in cui Guglielmo da Baskerville e il novizio Adso da Melk, giunti in un monastero benedettino dell’Italia del nord (di cui si tace il nome) per partecipare a un delicato incontro tra francescani e legati pontifici sul tema della povertà della Chiesa, finiranno per assistere a una serie di omicidi che sembrano seguire il ritmo delle sette trombe dell’Apocalisse e per scoprire che nell’imponente biblioteca dell’abbazia è custodita l’unica copia rimasta del secondo libro della Poetica di Aristotele, dedicato alla commedia e al riso.
Se, giocando con le citazioni, si è detto che Umberto Eco era “l’uomo che sapeva troppo”, possiamo aggiungere che Il nome della rosa è il romanzo di cui si è scritto troppo. Elogiato, criticato, oggetto d’imitazioni, parodie, palinsesti, quella storia medievale – che strizza l’occhio alla contemporaneità – di monaci uccisi per un libro è ormai divenuta un classico su cui schiere di critici si sono succeduti instancabilmente, come le onde sulla battigia, a dire la loro: opera aperta, opera chiusa, testo postmoderno, giallo deduttivo, romanzo storico, filosofico, di formazione, gotico, ecc… Tutto questo insieme, nelle fitte pagine in cui Guglielmo da Baskerville e il novizio Adso da Melk, giunti in un monastero benedettino dell’Italia del nord (di cui si tace il nome) per partecipare a un delicato incontro tra francescani e legati pontifici sul tema della povertà della Chiesa, finiranno per assistere a una serie di omicidi che sembrano seguire il ritmo delle sette trombe dell’Apocalisse e per scoprire che nell’imponente biblioteca dell’abbazia è custodita l’unica copia rimasta del secondo libro della Poetica di Aristotele, dedicato alla commedia e al riso.

Difficile, dunque, trovare qualcosa di nuovo da dare in pasto a lettori e critici.
Tuttavia, in occasione dei suoi quarant’anni, il best, anzi l’ormai long seller di Umberto Eco, transitando da casa Bompiani per soffiare sulle vele spiegate della Nave di Teseo, offre, in appendice, un piccolo tesoro, un vero e proprio valore aggiunto del romanzo che teniamo tra le mani: 21 fogli manoscritti – a tratti si potrebbe parlare di tavole, a tratti di semplici schizzi – che a tutti gli effetti costituiscono parte del lavoro preparatorio che l’autore iniziò ad allestire fin dal 1978.
Si tratta di materiale quasi totalmente inedito (qualcosa già accompagnava l’articolo di Antonio Gnoli, Eco: “Così ho dato il nome alla rosa” apparso nel luglio 2006 nell’inserto domenicale del quotidiano La Repubblica) che rende conto di quella meticolosa costruzione del mondo narrativo di cui Eco stesso parla nelle Postille al Nome della rosa; un’impalcatura che, come avverrà per i successivi romanzi, è tanto scrupolosa da sconfinare nei territori della maniacalità: “Il primo anno di lavoro del mio romanzo – scrive infatti nelle Postille – è stato dedicato alla costruzione del mondo. Lunghi regesti di tutti i libri che si potevano trovare in una biblioteca medievale. Elenchi di nomi e schede anagrafiche per molti personaggi, tanti dei quali sono stati poi esclusi dalla storia. Vale a dire che dovevo sapere anche chi erano gli altri monaci che nel libro non appaiono; e non era necessario che il lettore li conoscesse, ma dovevo conoscerli io”.
E oggi, grazie a questa pubblicazione, li conosciamo anche noi. E chissà se il semiologo l’avrebbe voluto, convinto com’era che l’opera sia sufficiente a produrre senso da sé, senza che il lettore attinga informazioni di là da ciò che essa (così come l’ha concepita l’autore) possa offrire. Intendo che Umberto Eco era perfettamente cosciente di ciò che voleva che i suoi lettori leggessero e vedessero cogli occhi e di ciò che invece voleva restasse tra le sue carte private. Mi piace ricordarne, a questo proposito, la stizza quando un editore straniero – lo narra nel volume Sulla letteratura – gli domandò se valesse la pena di accludere al testo dell’Isola del giorno prima un disegno della nave, come si era fatto per il piano dell’abbazia del Nome della rosa.
 Eco minacciò di andar per avvocati perché, spiegava, “nel Nome della rosa volevo che il lettore capisse alla perfezione come era fatto l’ambiente, nell’Isola volevo che il lettore si confondesse, e non riuscisse più a orientarsi nel piccolo labirinto di quella nave che riservava sempre nuove sorprese” (peraltro, fino a pochi anni fa, era possibile vedere due schizzi dell’imbarcazione su cui naufraga Roberto de la Grive, vergati dallo stesso Eco, consultando il sito della traduttrice russa Elena Kostioukovitch).
Eco minacciò di andar per avvocati perché, spiegava, “nel Nome della rosa volevo che il lettore capisse alla perfezione come era fatto l’ambiente, nell’Isola volevo che il lettore si confondesse, e non riuscisse più a orientarsi nel piccolo labirinto di quella nave che riservava sempre nuove sorprese” (peraltro, fino a pochi anni fa, era possibile vedere due schizzi dell’imbarcazione su cui naufraga Roberto de la Grive, vergati dallo stesso Eco, consultando il sito della traduttrice russa Elena Kostioukovitch).
Eppure, nonostante questa gustosa collusione tra opera e materiale privato, credo che, vista la volontà echiana di consegnare un mondo perfettamente ammobiliato e, in più, del tutto intelligibile, la nostra (di lettori) incursione tra i fogli preparatori non possa che rafforzare il senso d’impeccabile calibratura della strategia testuale, invogliandoci a percorrere, tra i mille possibili sentieri interpretativi, quelli maggiormente connessi all’iconografia e alla semiotica dei personaggi, dei luoghi e degli spazi.
E va subito detto che, similmente a quanto avviene nel romanzo balzachiano, le descrizioni ambientali sembrano determinare i colori dei personaggi o delle circostanze, creando un gioco di corrispondenze tra micro e macrocosmo, tra uomo e universo, tra biblioteca e mondo.
Celeberrima e iconica biblioteca, questa del Nome della rosa, questa che custodisce – ecco la miglior trouvaille – il più celebre tra i libri perduti dell’antichità, il secondo volume della Poetica di Aristotele, il libro dedicato alla Commedia, un libro per cui molti monaci vengono uccisi. Ed è un peccato che oggi il lettore di questa nuova edizione non possa controllare gli spostamenti di Adso e di Guglielmo nel labirinto attraverso la pianta che nell’edizione Bompiani era acclusa nel cuore del testo (a pagina 323); la ritrova però in appendice, come ottava illustrazione (sebbene non sia la medesima che compariva in passato) assieme a tanti altri disegni dedicati ai tre piani dell’Edificio che portano l’occhio curioso a frugare tra gli spazi delle cucine e del refettorio, al pian terreno, dello scriptorium al primo piano (e scopriamo che, rispetto alla trasposizione cinematografica su cui ormai, sbagliando, abbiamo preso le misure, quello echiano è uno scriptorium ove le postazioni dei monaci sono disposte a forma ottagonale), e appunto della biblioteca, all’ultimo piano. Di essa il nuovo volume offre diverse bozze, precedenti alla definitiva, disegni degli armadi per i libri, appunti su possibili volumi lì custoditi, e schemi minuziosi vergati sulla falsariga del Sator Arepo, da una parte, e di Castel del Monte, dall’altra.
Un corredo figurativo che, insomma, interviene a marcare l’eccezionalità dell’Edificio all’interno dell’equilibrato microcosmo abbaziale; i suoi tre livelli mostrano valenze complementari e contraddittorie: la cucina, al piano terreno, è il luogo del primario impulso a sfamarsi, ma è tra le sue mura che si consumano i peccati della carne; più sopra, lo scriptorium è sede del lavoro di conservazione, ma pure delle potenziali e, a detta di Jorge, riprovevoli passioni dell’intelletto (lì si conosce la tentazione della ricerca); infine, nel piano nobile, la biblioteca ospita anche ciò che va evitato, il libro di Aristotele per cui avvengono gli omicidi (e forse le lettere di Dolcino portate dal cellario Remigio), e in genere gli strumenti che offrono il destro per ridere di quella verità e di quell’ordine di cui l’abbazia vuole essere simbolo.
Non solo: se facciamo dialogare i molti disegni ora a nostra disposizione, non possiamo che consolidare l’idea che i luoghi del romanzo abbiano sempre un significato ben preciso. In questo senso, già dall’edizione Bompiani notavamo che sovrapponendo la planimetria abbaziale con quella, più specifica, della biblioteca si scopriva che il torrione custodente il celebre volume della Poetica è quello più interno alle mura. È un segno? Credo di sì. Ciò che Jorge, il cieco vegliardo, teme – e che il progressista Guglielmo auspica – è che il riso possa essere assunto a perfida teologia. Ma quale riso? Non quello dello stolto, del contadino, dell’avvinazzato, che è anzi necessario sfogo al mantenimento dell’ordine; ma il riso dei dotti, quello capace di corrodere l’ordine dall’interno; il riso filosofico, della mente e non (o non solo) del corpo. Ecco perché troviamo il libro di Aristotele nel torrione meridionale, “all’interno” delle mura: è l’elemento che può mettere in crisi l’ordine, riderlo dal di dentro, seguendo la via del comico, dell’ironia, dell’intelligenza dissacratoria. Al contrario, il torrione settentrionale, oltre le mura, rappresenta il riso dei semplici, che in nessun modo può “penetrare” l’ordine turbandolo. In realtà, le dinamiche interno/esterno sono apparenti: nessuno sconvolgimento è possibile dall’esterno, e l’imponenza del torrione settentrionale non fa altro che ribadire il netto e ordinario spartiacque previsto dalla dialettica fuori/dentro le mura. Dei lati settentrionali del complesso parla lo stesso Adso in questi termini: “sembravano crescere dalle falde stesse del monte, su cui s’innervavano a strapiombo. Dico che in certi punti, dal basso, sembrava che la roccia si prolungasse verso il cielo, senza soluzione di tinte e di materia, e diventasse a un certo punto mastio e torrione (opera di giganti che avessero gran familiarità e con la terra e col cielo)”.

Proprio il torrione è allegoria di un ordine prestabilito da sempre (opera ancestrale di creature in contatto col cielo), quasi parto di Dio stesso, non toccata dalla mano dell’uomo (cresceva dalle falde del monte), che a Dio ritorna (sembrava che la roccia si prolungasse verso il cielo). Per questo, il torrione settentrionale è l’unico a non possedere scale, né per accedere allo scriptorium, né tantomeno alla biblioteca. Sul lato riservato ai semplici il percorso di ascesa si ferma al piano terreno, alle cucine, alla corporalità.
Tutti i disegni presenti nel volume illustrano dunque un microcosmo a scatole cinesi, le une inserite nelle altre. E tra tutte, la biblioteca è il “mondo” più complesso: la teoria delle stanze, la loro particolare disposizione, il gioco di pareti cieche e di altre aperte, tutto concorre a creare l’idea di una maggior complicazione. Tuttavia, a ben vedere, la pianta della biblioteca così come si presenta al lettore che, sulle pagine del libro, segue il cammino di Adso e Guglielmo in quei penetrali, appare tutt’altro che ambigua e disordinata: è l’immagine stessa del mondo, microcosmo strutturato molto più accuratamente di quello disegnato dall’intero complesso abbaziale. E la pianta che un tempo era posta a pagina 323, stava proprio lì a significare l’entusiasmo di Guglielmo e la sua illusione di aver scoperto l’ordine del mondo.
Ciò che questa edizione conferma è che Eco nel suo primo romanzo ha fatto un uso “classico” delle illustrazioni, come classica è la presenza della pianta del luogo in cui si consumano i delitti nel romanzo giallo tradizionale. I tanti schizzi sono specchio dell’accurata costruzione del mondo narrativo, sono segno della volontà che il lettore capisca tutto e in maniera ordinata. Così, durante l’incendio finale, il lettore soffrirà della perdita al fianco di Guglielmo, al fianco della sua razionalità sconfitta; e a temperare lo sconforto, rimarrà solo la dolce rimemorazione di Adso, senza ordinate immagini del cosmo, ma con semplici nudi nomi e con le membra sparse di ciò che fu.

Infine, una brevissima nota la meritano anche i ritratti dedicati ai personaggi: sono disegni, quasi vignette in stile jacovittiano, simili, per certi versi, a quelli che accompagnavano la seconda, in ordine cronologico, tra le pubblicazioni echiane, quella delle argute filastrocche dei Filosofi in libertà (1958, sotto lo pseudonimo di Dedalus) e poi confluite nel Secondo diario minimo; o vicine, ancora, ad alcuni schizzi del giovane autore alessandrino, proposti una ventina d’anni fa da Giorgio Calcagno nell’articolo (apparso su Pagine del Piemonte) Umberto, il trapano e la parrucca della prof., divertente ‘traduzione’ visiva delle lezioni di storia al liceo classico Plana.
Ma ciò che producono questi ritratti nel lettore d’oggi è un istintivo confronto coi visi che attribuiamo ai personaggi grazie alla trasposizione cinematografica di Jean-Jacques Annaud. E il paragone ci fa capire quanto, nella fantasia di Eco, fossero altri i riferimenti iconografici. In particolare, come ha notato Luca Pantarotto in una breve e divertita nota facebook, veniamo a scoprire che “nell’immaginazione di Eco, Guglielmo da Baskerville, di Sherlock, aveva anche la faccia. Abituato a pensarlo con il volto di Sean Connery o persino, perché no, dello stesso Eco, scopro così che l’Umbertone se lo immaginava più simile a Basil Rathbone”.
Giacomo Verri, scrittore
Pubblicato giovedì 9 Luglio 2020
Stampato il 20/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/il-nome-della-rosa-compie-40-anni/