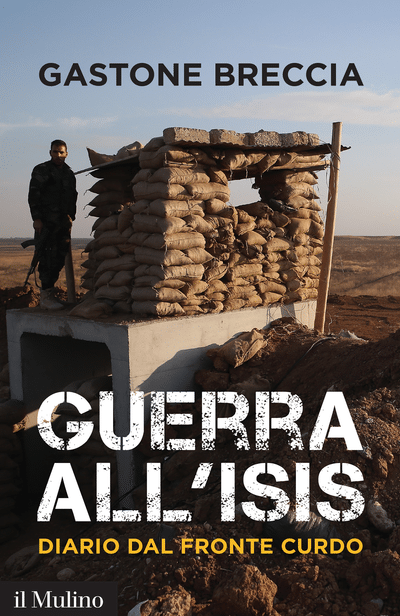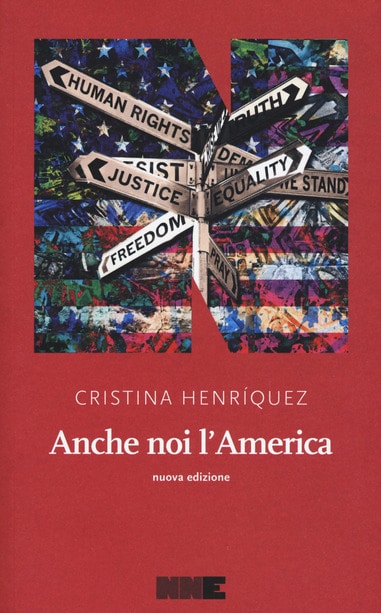 “Noi siamo gli americani invisibili, quelli che a nessuno importa nemmeno di conoscere perché gli hanno detto di avere paura di noi e perché forse, se facessero lo sforzo di conoscerci, si renderebbero conto che non siamo poi così cattivi, e forse addirittura che siamo molto simili a loro. E chi odierebbero, allora?”: queste parole di fuoco appartengono a Micho Alvarez, uno dei tanti personaggi che fanno il coro di voci, poderose, tenaci, a volte arrabbiate, di Anche noi l’America, tra i più interessanti lavori di Cristina Henríquez, portato in Italia da Roberto Serrai per NN editore già nel 2016 e ora riproposto in nuova edizione con alcune pagine introduttive dell’autrice (pp. 318, euro 18) la quale ci spiega che “Anche noi l’America è originariamente apparso in un periodo in cui i minori non accompagnati che attraversavano il confine meridionale degli Stati Uniti erano così tanti che i media parlarono di ‘crisi’. Oggi, quando si discute di migranti, parole come ‘crisi’, ‘emergenza’ e ‘invasione’ sono ancora più comuni, gridate dal pulpito da leader di Paesi le cui storie sono indissolubilmente legate all’arrivo di persone provenienti da altre terre. I migranti sono demonizzati e respinti. Niente di nuovo. Le persone hanno sempre viaggiato verso luoghi lontani, e altre persone hanno sempre opposto resistenza al loro insediamento. In altre parole, tutti i popoli, a un certo livello, sono stati ‘spezzati’; ma ora questo tipo di rottura sembra molto più pericolosa. E non solo per alcuni: la divisione ci deforma, ci rende tutti più deboli. Diminuire alcuni diminuisce tutti”.
“Noi siamo gli americani invisibili, quelli che a nessuno importa nemmeno di conoscere perché gli hanno detto di avere paura di noi e perché forse, se facessero lo sforzo di conoscerci, si renderebbero conto che non siamo poi così cattivi, e forse addirittura che siamo molto simili a loro. E chi odierebbero, allora?”: queste parole di fuoco appartengono a Micho Alvarez, uno dei tanti personaggi che fanno il coro di voci, poderose, tenaci, a volte arrabbiate, di Anche noi l’America, tra i più interessanti lavori di Cristina Henríquez, portato in Italia da Roberto Serrai per NN editore già nel 2016 e ora riproposto in nuova edizione con alcune pagine introduttive dell’autrice (pp. 318, euro 18) la quale ci spiega che “Anche noi l’America è originariamente apparso in un periodo in cui i minori non accompagnati che attraversavano il confine meridionale degli Stati Uniti erano così tanti che i media parlarono di ‘crisi’. Oggi, quando si discute di migranti, parole come ‘crisi’, ‘emergenza’ e ‘invasione’ sono ancora più comuni, gridate dal pulpito da leader di Paesi le cui storie sono indissolubilmente legate all’arrivo di persone provenienti da altre terre. I migranti sono demonizzati e respinti. Niente di nuovo. Le persone hanno sempre viaggiato verso luoghi lontani, e altre persone hanno sempre opposto resistenza al loro insediamento. In altre parole, tutti i popoli, a un certo livello, sono stati ‘spezzati’; ma ora questo tipo di rottura sembra molto più pericolosa. E non solo per alcuni: la divisione ci deforma, ci rende tutti più deboli. Diminuire alcuni diminuisce tutti”.
Ciò nonostante, il romanzo non è un libro inchiesta, né un grido di denuncia, sebbene qua e là siano inchiodate tra le pagine alcune annotazioni molto dure. I racconti di Micho Alvarez, come quelli di José Mercado, Quisqueya Solís o di Nelia Zafón, sono la cornice a una vicenda, quella della famiglia Rivera, che nella carne del fenomeno migratorio dai Paesi del Centramerica affonda la lama, delicata ma inesorabile, di una questione tutta privata. La questione di chi scavalca confini e guadagna la terra straniera degli Stati Uniti d’America per nutrire un sogno: Alma e Arturo Rivera giungono a Newark, nel Delaware, dopo un viaggio di quasi cinquanta ore a bordo di un pick-up, per verificare la tenuta delle loro speranze (“Avevamo appuntato tutti i nostri sogni su questo luogo, con uno spillo sottile e fragile, ed era troppo presto per dire se fosse più forte di quanto sembrava o se alla fine non avrebbe resistito”), per vedere se la vita cambiare di segno, per strappare al destino un futuro migliore. La loro figlia, una nuova bellissima Remedios che fa di nome Maribel, ha subito un grave incidente, a Panamà: per questo è necessario darle la speranza di guarire, una possibilità che il sogno americano sembra promettere.

L’arrivo nel Delawere è, però, per certi aspetti avvilente; la penna di Cristina Henríquez è magica nel rendere il senso di spaesamento di Alma, la mamma di Maribel, e una delle due principali voci narranti del romanzo: il paesaggio è diverso, la lingua è difficile (“Qui era come se fossi sigillata in una scatola insonorizzata”), i volti sono sconosciuti. Per fortuna, il palazzo in cui approdano è, a poco a poco, un fiorire di genti amiche, quasi di compaesani (“Qui ci siamo noi! Venezuela, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Colombia, México, Panamà, Paraguay”). La famiglia Rivera si lega a quella dei Toro: Rafael, Celia e il giovane Mayor che rappresenta l’altra voce narrante e, assieme, un sguardo altro sulla vita degli immigrati, lo sguardo di chi si è sistemato, in qualche maniera, di chi è diventato a tutti gli effetti cittadino americano, e non sente più il legame con le origini al di là del confine. Tutti, comunque, hanno “bisogno di credere di aver fatto la cosa giusta”; e la cosa giusta è stata emigrare, derivare il flusso della propria vita – nata a una certa latitudine – e traslarla più sopra, per immetterla in un altro flusso.
Così Rafael trova faticosamente un lavoro, Maribel può finalmente frequentare una scuola che la aiuterà a risolvere i propri problemi di apprendimento e Alma – toccata dalla benedizione dell’amicizia con Celia – inizia, lentamente, a purgarsi dal dolore, dal castigo e dalla fiacchezza che per troppo tempo ne hanno segnato i pensieri: “all’improvviso ero stanca di sentirmi così sperduta, così alla deriva per la tristezza. Volevo reprimere quella sensazione, allontanarla dalle nostre vite come si spolverano le ragnatele dagli angoli. Volevo cancellare tutta l’angoscia e la distanza, il rimorso e il senso di colpa, e sostituirli con qualcosa di nuovo”. Alma frequenta dei corsi per imparare l’inglese, per abbattere quella barriera linguistica che separa un viso da un altro, per smarcarsi dall’idea di “essere in fondo alla catena alimentare”, per sottrarsi ai pregiudizi di una società che fa sentire lo straniero “invisibile e appariscente insieme, una bizzarria di cui tutti si accorgevano ma sceglievano di ignorare”, per giocarsi una possibilità, forse l’unica, “in questa cosa che chiamiamo vita”.
E così la splendida Maribel, chiusa nell’afasia del proprio apparente torpore, torna piano piano a rinascere, scopre l’amore, e trasforma la sofferenza in un’occasione di vita: Mayor la nota, la coccola, la fa sentire importante, perché è l’unico ad accorgersi che lei è “un uccello in gabbia che nessuno si fidava a lasciar volare”, è l’unico a sentirla tanto vicina da annusarle addosso “la pelle calda” e l’odore di “sapone da bucato e brina”, è l’unico a parlarle senza giudicarla e a difenderla. Difenderla da quel bastardo di Garrett Miller. Quello sì, un americano vero, ma è lui pure uno che sta ai margini, un disadattato, uno che, con la sola sua presenza, piegherà irrimediabilmente la storia della famiglia Rivera.
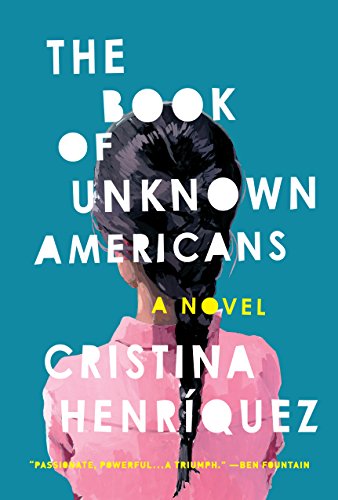 Il libro, ve lo assicuro, si legge con le ali agli occhi, specie i capitoli finali che incalzano a ritmo concitato, tra grandi emozioni, forti e insostituibili, e poi spaventi che precipitano nello stomaco “come un ascensore rotto”. L’epilogo cade nel mese di marzo, in un tardivo giorno di neve. Ovviamente non vi svelo ciò che capita ma dico che a fine lettura si impara qualcosa su tutti i modi in cui si può amare quel Paese, gli Stati Uniti d’America, si impara qualcosa sul dolore ma pure sul diritto, in cui ognuno di noi dovrebbe credere, di poter essere felici.
Il libro, ve lo assicuro, si legge con le ali agli occhi, specie i capitoli finali che incalzano a ritmo concitato, tra grandi emozioni, forti e insostituibili, e poi spaventi che precipitano nello stomaco “come un ascensore rotto”. L’epilogo cade nel mese di marzo, in un tardivo giorno di neve. Ovviamente non vi svelo ciò che capita ma dico che a fine lettura si impara qualcosa su tutti i modi in cui si può amare quel Paese, gli Stati Uniti d’America, si impara qualcosa sul dolore ma pure sul diritto, in cui ognuno di noi dovrebbe credere, di poter essere felici.
Questi americani invisibili e sconosciuti (The Book of Unknown Americans è il titolo originale del romanzo) sono coloro che cercano la possibilità di una vita tra coloro che conducono una vita piena di possibilità. Ognuno di loro, alla fine, fa la radiografia dei propri sogni, e trova la misura dei progressi e delle opportunità (che non per forza fanno rima con felicità) offerte dalla vita È un romanzo drammatico e delicato a un tempo, che mette in scena uno degli amori più belli di cui ho letto negli ultimi anni, e che svela l’esistenza così com’è, senza equilibri definitivi, senza certezze prescritte dal destino. Dietro l’angolo è sempre in agguato l’imprevisto. Lo sentirà il lettore scorrere sulla propria pelle, ce lo indica l’autrice in una piega del testo in cui cita il Poem After Carlos Drummond de Andrade di Marvin Bell, e di quello alcuni versi che accompagnano e chiosano, quasi ne fossero stati la pristina scintilla, tutta la vicenda:
… Oh silenziosi accenni all’inevitabile, mentre
tra i limiti naturali dell’inverno e del buon senso
la vita ti disfa tra le sue braccia.
Giacomo Verri, scrittore
Pubblicato giovedì 31 Ottobre 2019
Stampato il 24/11/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/americani-invisibili/