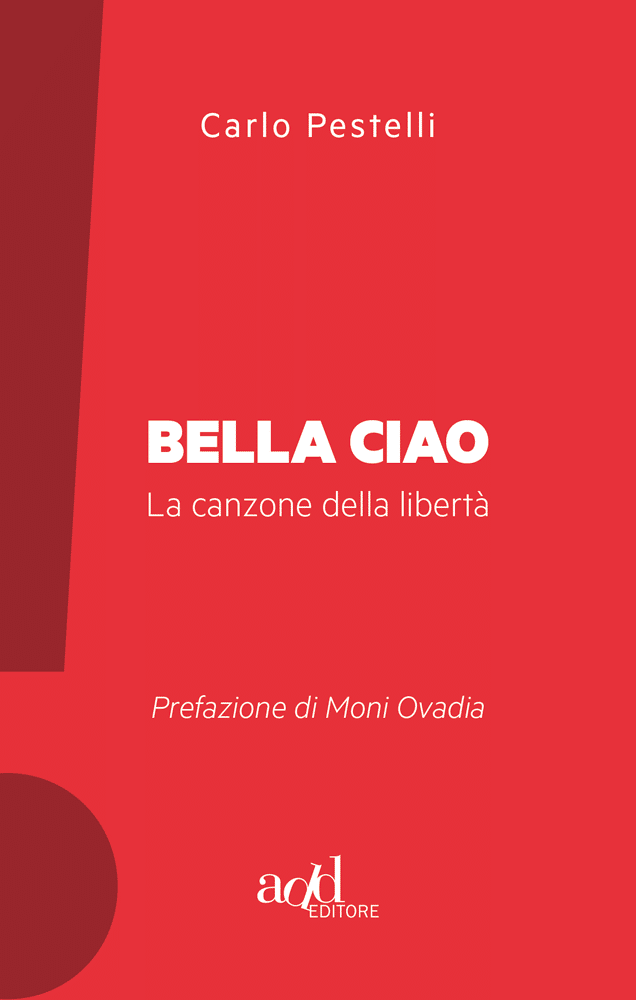Qualche anno fa Cesare Segre, riflettendo, in dialogo con Abraham Yehoshua, sul rapporto tra etica e letteratura, si diceva convinto che, in periodi segnati da una grave crisi di valori, nella valutazione di uno scrittore (o nella definizione di un canone) diventa legittimo ricorrere anche a un criterio morale. Perché ci sono tempi, e i nostri lo sono, in cui alla letteratura si deve chiedere di svolgere una funzione di guida e di denuncia. È certo qualcosa di più di una coincidenza il fatto che in questi ultimi anni scrittori tra loro diversi, e di diverse generazioni, abbiano condiviso l’esigenza di tornare a raccontare il periodo della Seconda Guerra Mondiale – si pensi a libri come Partigiano Inverno di Giacomo Verri, Evelina e le fate di Simona Bandelli, o Mi ricordo di Paola Capriolo – evidentemente mossi dall’esigenza di risvegliare le coscienze, di continuare in una testimonianza ancora necessaria, di richiamare il lettore alla difesa di valori che si stanno sempre più perdendo.
Qualche anno fa Cesare Segre, riflettendo, in dialogo con Abraham Yehoshua, sul rapporto tra etica e letteratura, si diceva convinto che, in periodi segnati da una grave crisi di valori, nella valutazione di uno scrittore (o nella definizione di un canone) diventa legittimo ricorrere anche a un criterio morale. Perché ci sono tempi, e i nostri lo sono, in cui alla letteratura si deve chiedere di svolgere una funzione di guida e di denuncia. È certo qualcosa di più di una coincidenza il fatto che in questi ultimi anni scrittori tra loro diversi, e di diverse generazioni, abbiano condiviso l’esigenza di tornare a raccontare il periodo della Seconda Guerra Mondiale – si pensi a libri come Partigiano Inverno di Giacomo Verri, Evelina e le fate di Simona Bandelli, o Mi ricordo di Paola Capriolo – evidentemente mossi dall’esigenza di risvegliare le coscienze, di continuare in una testimonianza ancora necessaria, di richiamare il lettore alla difesa di valori che si stanno sempre più perdendo.
Anche Micheli sceglie, con lo stesso proposito, di raccontare l’orrore e la ferocia di quel pezzo di Novecento: la narrazione, racchiusa da una cornice che riporta al passato prossimo degli anni Sessanta-Settanta, si concentra su un decennio di storia italiana ed europea seguendo, a partire dal 1937, le vicende di una coppia di intellettuali ebrei, Stefan e Ada Bauer, di origini morave lui, italiane lei, e del loro figlio Bruno, lungo percorsi che da Vienna li porteranno, inizialmente uniti poi separati, in Italia, Ucraina, Polonia, Germania, Egitto, tra persecuzioni, ricatti, complicità e resistenza. La loro storia, certamente eccezionale ma per alcuni aspetti simile a quella di migliaia di altre persone, permette all’autore di disegnare un grande affresco, una mappa che si stende su molta parte dell’Europa, sulle cui strade si incrociano le idee, i pensieri, le azioni dei più importanti personaggi del tempo, protagonisti della storia politica e militare, ma anche di quella culturale: si incontrano così in queste pagine, tra gli altri, Sigmund e Anna Freud, il matematico polacco Hugo Steinhaus e il fisico ungherese Eugene Wigner, Luchino Visconti e Leni Riefenstahl, Angiolo e Laura Orvieto, Bonaventura Tecchi e Concetto Marchesi.
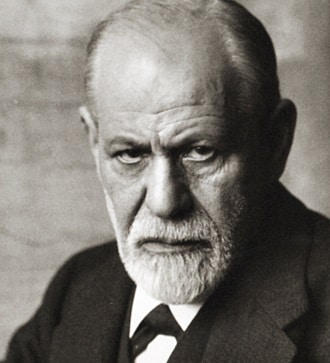
La ricostruzione storica appare sempre molto precisa e, come nel modello manzoniano – ma per un testo ricco di richiami al mondo classico si potrebbe fare anche il nome di Tacito – l’invenzione di gesti quotidiani, di particolari privati, di dialoghi, si colloca dentro la documentata ricostruzione degli avvenimenti.
Ritornano nel romanzo episodi già “raccontati” nella tradizione letteraria, per i quali Micheli sa trovare accenti nuovi (da antologia, per esempio, la pagina sul primo esperimento di gassificazione), ma vi sono anche vicende meno rappresentate (come l’assedio di Leopoli). Ciò che però soprattutto colpisce è lo sguardo “grandangolare” con cui Micheli, dopo aver messo a fuoco singoli eventi e personaggi, riesce a legarli in un complesso gioco di relazioni, costruendo un arazzo i cui fili si annodano in una trama complessa. Punto di forza è inoltre la capacità di far emergere nella filigrana del presente i segni del passato, e così, per fare un solo esempio, la vicenda di due donne tedesche prigioniere a Ravensbruck in quanto comuniste, caparbie nell’impegno di danneggiare la catena di produzione del campo, riaffiora nei boicottaggi praticati nelle fabbriche milanesi negli anni Settanta.
Il legame tra il passato e il presente si incarna nel giovane Bruno che, una volta diventato adulto, ripercorre la dolorosa vicenda dei genitori, con l’aiuto delle lettere che il padre gli aveva scritto, nella convinzione che il figlio avrebbe potuto completare il percorso di individuazione di sé solo attraverso il racconto in prima persona di quanto lui e la moglie stavano vivendo. Per Bruno, siamo ormai negli anni della “lotta armata”, l’incontro con la verità si traduce, inizialmente, nella decisione di aderire al terrorismo, per punire i responsabili delle sofferenze dei genitori, ma presto cambierà idea. Abbandonata la P38, sceglierà, proprio come suo padre, la scrittura: il suo obiettivo diventa denunciare i crimini nazisti in un racconto «composto secondo lo spirito della giustizia ed affidato alla buona volontà delle donne e degli uomini a venire, e di cui tu, lettore, tieni adesso, tra le mani e la coscienza, il possibile reperto».
Questo è anche quanto si prefigge Micheli: Romanzo per la mano sinistra vuole essere un reperto che smuova la coscienza del lettore di oggi, cui spesso la voce narrante si rivolge, chiamandolo in causa, provocandolo, costringendolo ad affrontare grandi questioni. Molti sono i temi affrontati: tra i più importanti la responsabilità dell’individuo nella società di massa, a partire da una riflessione su quei “miti carnefici” di montaliana memoria – il negoziante sotto casa, i vicini, le «brave persone, timorate di Dio» – pronti a trasformarsi in una «massa indistinta di fanatici». Forte la denuncia contro chi, pur senza compiere il male, si astiene dal bene e si fa così complice della comune infelicità e sventura. Decisa e argomentata la polemica contro il capitalismo. E poi ci sono la questione femminile, i limiti del progresso, il ruolo dell’arte. Non mancano veloci incursioni nell’attualità (come accade col riferimento al direttore di “Repubblica”).

Nel panorama letterario di oggi Romanzo per la mano sinistra appare un’opera decisamente spiazzante: già a partire dal titolo, evidente citazione del Concerto per pianoforte per la mano sinistra scritto da Ravel per Paul Wittgenstein (che aveva perso un braccio durante la Prima guerra mondiale), e insieme scoperta indicazione di una precisa prospettiva ideologica da cui l’autore guarda e giudica il mondo. Ma soprattutto perché è un libro impegnativo, che richiede una lettura lenta e meditata: il respiro è quello delle narrazioni ottocentesche; l’andamento, lo sottolinea Ferroni nella quarta di copertina, è quello epico.
Spesso la voce del narratore esterno – che per lo più rivela, anche attraverso il frequente ricorso al discorso indiretto libero, il punto di vista del figlio-testimone – e quella del narratore interno – che prende la parola nelle lettere – si intrecciano e, volutamente, si confondono. Lo stile è accuratissimo. Il modello è la concinnitas ciceroniana: la complessità del reale richiede un periodare fortemente ipotattico, rallentato talora da un alto numero di incisi che costringono l’autore a riprendere, con andamento anaforico, la reggente d’apertura. Il lettore più volte deve tornare indietro, mettere dei pezzi tra parentesi per ritrovare il filo, deve ripercorrere le righe, con pazienza, come quando, per comprendere il reale, si devono rivalutare eventi e pensieri. Ma alla fine tutto, sintassi e riflessione, risulta perfettamente calibrato.
Le parole sono sempre esatte, precise, spesso difficili, perché la complessità può solo essere rappresentata e interpretata da una lingua ricca, capace di dire con precisione e di modulare diversi registri (suggestivo è il contrasto tra lo stile alto della maggior parte delle pagine e l’autenticità popolare dei proverbi e delle espressioni idiomatiche poste in testa ai capitoli): perché, ammonisce lo scrittore in un passaggio del libro, la povertà linguistica è uno degli strumenti utilizzati dal potere per soffocare le coscienze, insieme alla promozione della superficialità, che fa «apparire la sapienza, invece che nello sviluppo del pensiero, piuttosto nell’osservazione immediata e nell’immaginazione accidentale».
È per combattere l’uno e l’altra che si scrivono, e si leggono, libri come questo.
Anna Longoni, insegnante e saggista, docente a contratto presso l’Università di Pavia
Pubblicato venerdì 8 Settembre 2017
Stampato il 03/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/affresco-sul-dramma-del-900/