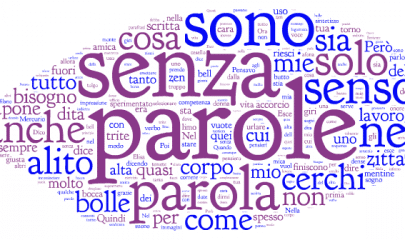Il rapporto strettissimo che intercorre tra stile e potere fa delle donne in politica delle pedine di primaria importanza sullo scacchiere del marketing e della comunicazione: il trucco, un accessorio o il colore di un capo indossato diventano espressione di idee politiche ben precise, spesso esternate in modo più incisivo rispetto ai colleghi uomini.
Perché da una parte, quello che viene definito come power dressing si fa carico innanzitutto di affermare l’autorità della donna attraverso le sue scelte estetiche. Dall’altra, l’abbigliamento favorisce la costruzione di un solido storytelling politico, capace di affermare – ad esempio – l’indipendenza e l’unicità di un’idea politica mediante un vestiario eccentrico, o farsi alfiere di un repulisti attraverso un completo castigato e un trucco leggero.
Fino a qualche tempo fa, l’etichetta prevedeva che una donna, per essere autorevole e bossy, non dovesse fare altro che imitare gli uomini (anche nel guardaroba): in effetti, la schiera di donne sobrie ai limiti del trasandato è lunga, e Angela Merkel è forse la più devota sostenitrice di quello stile “austerity” aspramente criticato da Karl Lagerfeld, il direttore creativo di Chanel recentemente scomparso. Il tailleur è sempre stato, in molteplici forme, imparentato con i palazzi del potere, anche nella sua versione composta da giacca e gonna. Basti pensare al Regno Unito: Margaret Thatcher lo indossava in abbinamento a gioielli e bluse in grado di addolcire l’estetica dura della Iron Lady e la monarca Elisabetta II ne ha in tutte le tinte, rigorosamente en pendant con cappello e borsetta.
E oggi, qual è lo stile del Regno Unito nell’era Brexit-non-Brexit? Certamente la premier Theresa May è riuscita a dare una sferzata di modernità – nell’abbigliamento istituzionale molto più che nelle politiche del suo governo – in un panorama monocromatico, introducendo colori vivaci, fantasie geometriche e quel dettaglio che diventa un biglietto da visita estremamente eloquente: le scarpe. Maculate, con applicazioni vistose o ricami, con il tacco glitter o la punta metallica: la scarpiera della premier britannica le permette, a suo dire, di rompere il ghiaccio anche durante gli incontri politici più tesi, suggerendo una nuova accezione di “politica dal basso”.

Tuttavia, la comunicazione politica non si affievolisce neppure quando la prospettiva si ribalta e, da primo ministro, si passa a… “prima donna”. Essere first lady è, in modo più latente, un’accezione di fare politica, incarnando quella citazione (un po’ troppo stigmatizzata e stantia) che vuole una grande donna dietro ogni grande uomo. Per molti aspetti, si tratta di un campo minato: basti ricordare l’ex première dame Carla Bruni, costretta a una vita senza più tacchi alti per non sottolineare il divario di statura con il marito Nicolas Sarkozy, o la signora Macron, attenta a non mettere in evidenza la differenza di età con il presidente francese, un tema sempre succulento per le chiacchiere scandalistiche. Così come al centro di una polemica sono state anche le sneakers Louis Vuitton che l’attuale prémiere dame ha indossato durante un viaggio in Egitto, contestate dagli indignati d’Oltralpe per via del loro valore, pari allo stipendio di un operaio. Chi, invece, ha saputo portare una ventata democratica anche nelle scelte di vestiario è stata, senza dubbio, Michelle Obama. Con i suoi colori sgargianti ha interrotto quella tradizione di tinte pastello suggellata da Jacqueline Kennedy, dando grande lustro a brand emergenti statunitensi e creando un vero e proprio “effetto first lady” secondo cui, ad ogni apparizione in pubblico con un determinato capo o accessorio, la maison che lo aveva realizzato beneficiava di un sensibile aumento nelle vendite. Una figura, quella di Michelle Obama, strettamente legata al concetto di empowerment: un’attrice politica di primaria importanza, solida perché indipendente dal marito, e che ha veicolato attraverso il suo abbigliamento messaggi di emancipazione, rottura con il passato, ribaltamento delle regole, inclusione e apertura.

E così, la fine dell’era Obama ha inevitabilmente portato a un azzeramento di questa narrazione e a una brusca inversione di rotta: l’amministrazione Trump ha, di fatto, imposto una sorta di “restaurazione” nell’abbigliamento. L’insediamento dell’ancient régime – veicolato da un Presidente che indossa sempre la cravatta – ha portato con sé una first lady impeccabile nel suo essere distante dalla realtà e più simile al personaggio di una soap opera, tra abiti fascianti e acconciature inscalfibili che, però, quando dismette i panni della diva per concedersi un abbigliamento più pratico e comune, rischia di incappare in volgari cadute di stile. Che è ciò che è accaduto lo scorso giugno, quando si è recata in visita in un centro di detenzione per immigrati minorenni: Melania Trump ha optato per un look con scarpe basse, pantaloni bianchi e giacca di un brand popolare. Il problema è stato il retro di quella giacca, su cui compariva la scritta ben visibile «I really don’t care, do you?» che ha monopolizzato l’attenzione mediatica e sollevato polemiche. Più di qualcuno ha inteso quella frase come un messaggio a sostegno delle politiche di Trump, il quale ha addirittura ritenuto opportuno intervenire nella questione con un tweet dal tono aggressivo, come è nel suo stile, scagliandosi contro gli accusatori, additati come “untori” di fake news.

Collateralmente, però, accanto alle figure impomatate di Trump e consorte, l’opposizione statunitense ha un astro nascente: Alexandria Ocasio-Cortez, la parlamentare quasi trentenne, esponente del partito democratico (dei millennials). Una personalità politica forte e determinata, una presenza costante sui social e un look fresco fanno di Ocasio-Cortez la nemesi del presidente-tycoon: se i tratti somatici e il cognome lasciano immediatamente intuire le sue origini portoricane, tutta la sua comunicazione politica veicola messaggi ben precisi anche attraverso dettagli apparentemente secondari. A partire dallo stile scelto per il suo debutto al Congresso: completo bianco, rossetto rosso e vistosi cerchi dorati ai lobi sono state vere e proprie citazioni di stile, per manifestare la sua gratitudine verso le donne di potere che l’hanno preceduta, dal giudice della Corte Suprema Sonia Sotomayor alla prima deputata di colore eletta nel 1968, Shirley Chisholm, a Hillary Clinton.
E proprio per quest’ultima, pare quasi che la scelta di abiti bianchi sia un elemento ricorsivo e per nulla casuale. Alla cerimonia di insediamento di Trump, il look total white sfoggiato da Hillary Clinton sembrava disseminare tracce e indizi, già partendo dallo stilista che l’aveva disegnato, Ralph Lauren, lo stesso che veste Melania Trump. Ma non è tutto qui: il bianco era il colore utilizzato provocatoriamente dalle suffragette dei movimenti di inizi Novecento come vessillo di purezza. Proprio il giorno dopo l’insediamento di Trump, Washington si riempì dei cortei, dei cori e delle proteste della Women’s March, in cui migliaia di “nuove” suffragette protestavano contro l’elezione di un presidente misogino. Il completo di Hillary Clinton poteva, dunque, assurgere a fil… blanc del sostegno ai diritti delle donne di ieri e di oggi. E che dire, allora, della stessa scelta cromatica in occasione dell’accettazione della sua candidatura alle primarie? Anche lì, un completo bianco. Potrebbe trattarsi semplicemente di una coincidenza o di una preferenza meramente estetica, ma la casualità si ridimensiona e torna il gioco il marketing politico quando si pensa che un (altro) completo bianco Clinton l’ha indossato durante il suo ultimo dibattito presidenziale contro Trump, nell’ottobre 2016, anticipato, nei due incontri precedenti, da un completo rosso e da uno blu. Proprio i colori della stars and stripes, la bandiera statunitense, per calare gli assi con una mossa a metà strada tra la dichiarazione accorata di patriottismo e una studiatissima captatio benevolentiae nei confronti dell’elettorato.

La grande forza della comunicazione giocata attraverso l’abbigliamento assume sfumature diverse, quando entrano in gioco le figure politiche femminili. La complessità storica e di costume che questo fenomeno rappresenta è attribuibile proprio a due fattori: il primo è l’ingresso relativamente recente delle donne in politica e il fatto che – per quel retaggio maschilista da cui non potremo mai dirci veramente assolti, purtroppo – rappresentino comunque una novità e questo, nel bene o nel male, tende ad attirare maggiormente l’attenzione. Il secondo fattore scaturisce da una considerazione vanesia e puramente estetica: il guardaroba femminile, anche in contesti estremamente formali, può beneficiare di una quantità di capi, accessori e colori impensabili per un uomo e, quindi, comunicare un più ampio ventaglio di messaggi. Ma, visto che su ogni medaglia ci sono sempre due facce, amaramente bisogna considerare che, più che a fornire spunti di riflessione concreti sull’efficacia della comunicazione politica, spesso parlare dell’abbigliamento delle esponenti politiche equivale a riempire le pagine di cronaca rosa, perdendosi nella futilità dei merletti, nelle pagelle di stile e nell’utilizzo dell’estetica femminile come cartina al tornasole di un dibattito che si rivela per sua natura sessista e autofagocitante.
Letizia Annamaria Dabramo
Pubblicato giovedì 28 Marzo 2019
Stampato il 28/01/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/costume/donne-potere-e-stile/