In Val Saviore e nell’alta Val Camonica, tra la primavera e l’estate 1944, operò un reparto fascista denominato Banda Marta con funzioni repressive nei confronti dei partigiani. I suoi membri erano ex detenuti, liberati a patto di arruolarsi nell’esercito repubblichino. Dalla fama funesta, che ancora aleggia in quelle zone, raggiravano la popolazione per avere informazioni utili, compivano furti, incendi e omicidi.
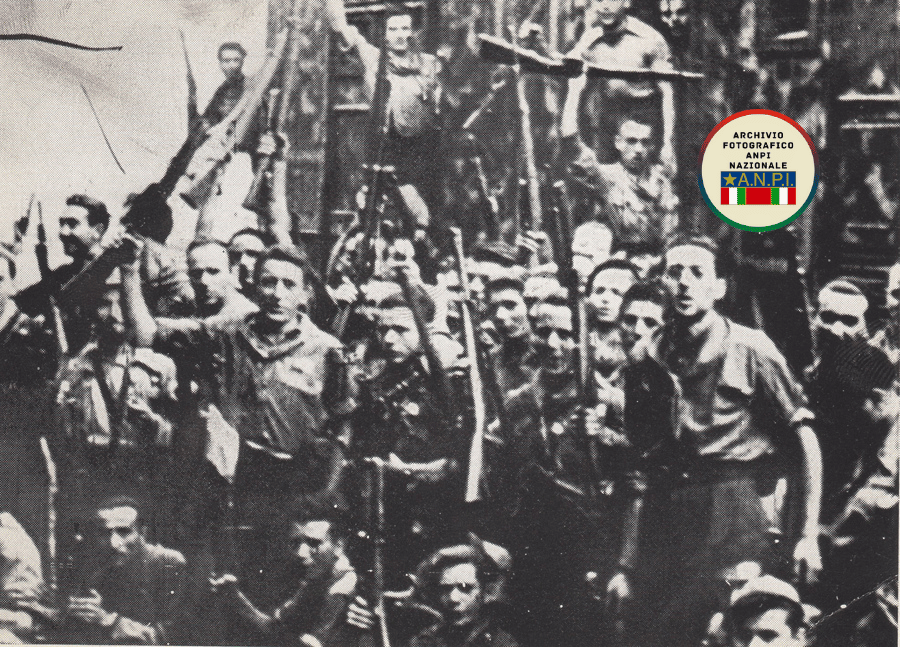
Il 30 giugno i partigiani della 54° Brigata Garibaldi occupano Cevo e, nella notte, la centrale elettrica di Isola di Cedegolo. Nel duro combattimento perde la vita il partigiano Luigi Monella ma nello scontro che si conclude con l’eliminazione del presidio nemico i fascisti contano quattro militi morti.
 La reazione arriva nel giro di poche ore. La mattina del 3 luglio duemila nazifascisti, partiti dal fondovalle, raggiungono Cevo mentre si celebrano i funerali di Monella e appiccano il fuoco al paese. Il bilancio è pesantissimo: quattro vittime civili, due partigiani, centocinquantuno case distrutte, ottocento senzatetto, centosessantacinque famiglie senza più nulla.
La reazione arriva nel giro di poche ore. La mattina del 3 luglio duemila nazifascisti, partiti dal fondovalle, raggiungono Cevo mentre si celebrano i funerali di Monella e appiccano il fuoco al paese. Il bilancio è pesantissimo: quattro vittime civili, due partigiani, centocinquantuno case distrutte, ottocento senzatetto, centosessantacinque famiglie senza più nulla.
Sapevo ben poco di questa storia, finché, al bancone di un’osteria in penombra ho incontrato per caso Enrichetta Gozzi, staffetta partigiana e ultima testimone del rogo. L’ultranovantenne ingoia tagliatelle al ragù e, non soddisfatta, ordina un caffè d’orzo con quattro gocce di vino rosso mescolate dentro. Un po’ di pane e burro, un bicchierino di limoncino per dar sfogo ai ricordi intonando un canto generazionale. Nella taverna addormentata del dopo pranzo, smettono di parlare anche le carte da gioco.
 “La mattina dell’incendio era in corso il funerale del partigiano Luigi Monella. Mentre stavamo andando alla cerimonia, sentimmo degli spari e da una stradina vicina scesero quattro, cinque tedeschi con le mitragliatrici e ra-ta-ta-ta, si misero a sparare a casaccio. Lanciarono una bomba incendiaria nella casa del defunto che divampò in un istante. Chi poté salvarsi lo fece, ma Luigi bruciò nella bara senza pietà. Il paese bruciava e ci rifugiammo in una stalla. Neanche mezz’ora e arrivarono altri due tedeschi armati che spararono in aria urlando: «Fuori da questa stalla!». Salimmo su per una stradina, poco più avanti un ragazzo correva tenendo per mano la sorella. Saltavano i muretti in pietra come fossero camosci, ma a lui lo ammazzarono come un cane… Lei corse fino a Cedegolo. «Quello che abbiamo fatto a lui lo facciamo anche a voi» disse rabbioso il tedesco.
“La mattina dell’incendio era in corso il funerale del partigiano Luigi Monella. Mentre stavamo andando alla cerimonia, sentimmo degli spari e da una stradina vicina scesero quattro, cinque tedeschi con le mitragliatrici e ra-ta-ta-ta, si misero a sparare a casaccio. Lanciarono una bomba incendiaria nella casa del defunto che divampò in un istante. Chi poté salvarsi lo fece, ma Luigi bruciò nella bara senza pietà. Il paese bruciava e ci rifugiammo in una stalla. Neanche mezz’ora e arrivarono altri due tedeschi armati che spararono in aria urlando: «Fuori da questa stalla!». Salimmo su per una stradina, poco più avanti un ragazzo correva tenendo per mano la sorella. Saltavano i muretti in pietra come fossero camosci, ma a lui lo ammazzarono come un cane… Lei corse fino a Cedegolo. «Quello che abbiamo fatto a lui lo facciamo anche a voi» disse rabbioso il tedesco.

Continua Enrichetta: “La vita di un tedesco equivaleva a quella di dieci civili. Era una regola. Quel giorno al muro della chiesa ci finii pure io, assieme a mia madre. La tenevo per mano perché, poverina, tra lo sforzo fisico e la paura non aveva fiato. Scelsero dieci persone da fucilare. Uno, due, tre, quattro… La decima fu proprio lei. Avendo già perso mio padre non avrei retto, così ho preso il posto di mia madre mentre il comandante proseguiva l’allineamento. Muoio io che è più facile, pensai. Nel momento in cui finì di contare arrivò un gesuita della chiesa di Sant’Antonio e urlò: «Alt! Si fermi, questa è tutta gente mia non può ammazzarla» disse. Nel tentennamento che seguì, scappammo nelle stanze interne della chiesa e fummo risparmiati”.
Dopo l’incendio le famiglie del paese si aiutarono l’un l’altra e, una trave alla volta, ricostruirono qualche casetta e fienile.

Già nei giorni antecedenti al rogo, Cevo era immersa in un silenzio attonito, rotto dal martello che batte il chiodo duro. Il 2 luglio Enrichetta aveva visto una mamma vestire il figlio di sette anni con tre giacconi, spedendolo al pascolo. Intuiva già quel che sarebbe accaduto.
 L’osteria intanto si è svuotata, solo un uomo è rimasto ai tavolini e vaga in un’ala di fumo denso. Il cameriere asciuga i bicchieri; farà orario continuato e non ha fretta.
L’osteria intanto si è svuotata, solo un uomo è rimasto ai tavolini e vaga in un’ala di fumo denso. Il cameriere asciuga i bicchieri; farà orario continuato e non ha fretta.
“Come procedeva la vita prima del rogo?” chiedo a Enrichetta. “Prima della guerra si andava a legna e patate, mangiavamo ciò che coltivavamo, scrutavamo il cielo per prevedere il meteo. Poi arrivò questa maledetta guerra. Dico maledetta perché, come avrai capito, mi toccò da vicino e scelsi di unirmi ai partigiani. Nell’autunno del 1943 si costituirono in Val Camonica i primi nuclei d’opposizione armata al regime fascista. Durante il mese di settembre si svolsero alcune riunioni clandestine e sorsero in poco tempo due centri di coordinamento per tutti i partigiani camuni: uno tra Darfo e Cividate e l’altro in Val Saviore, a Cevo.
 Ma vivevamo nella paura anche prima del rogo, questo è certo. Mia sorella, per esempio, aveva il fidanzato partigiano e un giorno tre tedeschi si misero a cercarla, ma non trovandola presero me. Mi spinsero contro un muro, in fondo al paese. «Dove sono i partigiani?». Non risposi. Sciaf, sciaf, due schiaffi così forti che gli orecchini mi volarono a terra e non li ritrovai più. Un orecchio sanguinava. Dopo due giorni tornarono e presero mia sorella, la portarono al cimitero, la fecero inginocchiare davanti alle lapidi e pensammo al peggio. Invece poi la rinchiusero in carcere per una settimana. Chiesi aiuto a un parroco per liberarla e ci riuscimmo. Ma era come una maledizione, lo scarpone nazifascista. Tornarono di nuovo e presero mio padre, Innocenzo Gozzi, mugnaio del paese. Lo arrestarono mentre col mulo stava portando la legna a casa. Lo picchiarono per sapere dove fossero i partigiani. Lui sapeva, ma non fiatò. Ecco cosa significa avere forza. Non vidi più mio padre: fu deportato in Germania transitando per il campo di Fossoli. Scoprimmo poi che morì di fatica a sessantasette anni e fu cremato assieme ad altri due cevesi nel campo di concentramento di Mauthausen”.
Ma vivevamo nella paura anche prima del rogo, questo è certo. Mia sorella, per esempio, aveva il fidanzato partigiano e un giorno tre tedeschi si misero a cercarla, ma non trovandola presero me. Mi spinsero contro un muro, in fondo al paese. «Dove sono i partigiani?». Non risposi. Sciaf, sciaf, due schiaffi così forti che gli orecchini mi volarono a terra e non li ritrovai più. Un orecchio sanguinava. Dopo due giorni tornarono e presero mia sorella, la portarono al cimitero, la fecero inginocchiare davanti alle lapidi e pensammo al peggio. Invece poi la rinchiusero in carcere per una settimana. Chiesi aiuto a un parroco per liberarla e ci riuscimmo. Ma era come una maledizione, lo scarpone nazifascista. Tornarono di nuovo e presero mio padre, Innocenzo Gozzi, mugnaio del paese. Lo arrestarono mentre col mulo stava portando la legna a casa. Lo picchiarono per sapere dove fossero i partigiani. Lui sapeva, ma non fiatò. Ecco cosa significa avere forza. Non vidi più mio padre: fu deportato in Germania transitando per il campo di Fossoli. Scoprimmo poi che morì di fatica a sessantasette anni e fu cremato assieme ad altri due cevesi nel campo di concentramento di Mauthausen”.

Innocenzo lavorò sette mesi in una cava. I prigionieri dovevano martellare pietre tutto il giorno, una gradinata li divideva dalle camerate. Chi non aveva abbastanza forza nelle cosce, con quel peso immane sulla schiena, veniva buttato giù. Gli scalini che conducevano ai dormitori erano ottantadue, li contò personalmente la figlia Enrichetta durante la visita al campo, a guerra conclusa.
“Mia sorella rimase in montagna, non si avvicinò più al paese e dunque diventai una staffetta per scelta, ma soprattutto per esigenza. Su e giù, portavo di tutto: farina, vestiti, pane, sigarette, zucchero, informazioni. In un’ora scarsa scaricavo tutto il gerlo di viveri e lo riempivo di legna. Era un alibi perfetto. Mi presero pure, un pomeriggio, ma non avendo nulla con me, né foglietti né messaggi, mi andò bene. A piedi, sul monte Musna, una mattina incontrai un gruppo di partigiani che mi insegnarono a innescare una bomba e volevano che la portassi con me per difesa. Ne avevo troppa paura. Una donna più anziana, che aveva un figlio sulle montagne e più dimestichezza con le armi, si era cucita appositamente un grembiule per nascondere una pistola. Di notte andava spesso a portare cibo alla Brigata. Sapeva usare la rivoltella, io no. Mi impegnai come staffetta e dissi a me stessa: se va, va. Se va male, pazienza. Sono contenta di aver fatto la mia parte perché meritavamo di essere liberati”.
 Rammenta ancora Enrichetta: “I partigiani nel frattempo si nascondevano nei vecchi fenili o in grotte ricoperte di terra e letame. Le condizioni erano precarie e la salute cagionevole. Come il mio futuro marito Pietro, che si ammalò di broncopolmonite e stava per morire. Per questo quando canto oh partigiano, portami via, che mi sento di morir sento ancora un magone dentro, perché Pietro stava davvero per morire. Ho fatto quella vita per tutta l’estate, poi rimasi a casa con mia nonna fino al giorno della Liberazione. Malgrado la morte di mio padre siamo tornati liberi. Liberi di parlare e discutere”.
Rammenta ancora Enrichetta: “I partigiani nel frattempo si nascondevano nei vecchi fenili o in grotte ricoperte di terra e letame. Le condizioni erano precarie e la salute cagionevole. Come il mio futuro marito Pietro, che si ammalò di broncopolmonite e stava per morire. Per questo quando canto oh partigiano, portami via, che mi sento di morir sento ancora un magone dentro, perché Pietro stava davvero per morire. Ho fatto quella vita per tutta l’estate, poi rimasi a casa con mia nonna fino al giorno della Liberazione. Malgrado la morte di mio padre siamo tornati liberi. Liberi di parlare e discutere”.
Libertà negata al cugino di Enrichetta, un pastore di diciassette anni estraneo alla Resistenza. Catturato, legato a una sedia e gettato in fondo a una scarpata. Enrichetta e la madre andarono a prenderlo. Quando adagiarono il corpo sul tavolo di un’osteria, contarono i buchi delle pallottole: diciassette. Come gli anni che aveva.
Libertà negata anche per Rosy Romelli, partigiana a quattordici anni. I questurini di Brescia l’arrestarono insieme ai genitori e, oltre alle botte e la mandibola guasta, le tirarono così forte le trecce che “sentivo mi avrebbero strappato il cervello”.

Enrichetta, nata nel 1925, è scomparsa nel giugno 2019. Pochi mesi fa, se n’è andata un’altra Enrichetta, classe 1923. Deportata nel campo di Ravensbrück, a ventisei anni non aveva più denti, a ventotto i capelli erano bianchi come la neve. Di certo per le violenze provate e gli orrori visti, dicevano i concittadini vedendola passeggiare sotto casa.
Quel giorno del 2016 passeggiamo anche noi, oltrepassando le tracce striate delle lumache infilatesi sotto al ginepraio. Guardando la facciata della scuola comunale, Enrichetta riprende il filo del discorso: “Io ero fidanzata con un alpino che è partito per la Russia e non è più tornato. Avevo sedici anni, lui diciannove. Dopo la guerra, nel 1949, ho conosciuto Pietro, con cui ho avuto sette figli. Ma anche lui è morto giovane, a cinquantasei anni. Pochi, ma sufficienti per tirare su casa e allevare la prole. Sono stati anni duri. Andavo a lavorare nei campi con tre figli al seguito. Gli altri li lasciavo a casa. Solitamente le gemelline le infilavo nel gerlo o nelle ceste di vimini legate ai fianchi del ciuchino. Un giorno una delle due gemelle, otto mesi, cadde dalla cesta e pensai che fosse fritta. Invece la trovai intatta, senza un graffio; a pochi passi c’era il santino della Madonna e l’icona di mio cugino ucciso dai tedeschi. Fu una grazia”.

Mi dice Enrichetta: “Chi non ha provato certe cose non può sapere; si possono immaginare ma non comprendere. Quelli che idealizzano la storia spesso non sanno. Come quell’uomo che tre settimane fa, ironizzando, mi disse che Cevo fu incendiata con un cerino, come per ridicolizzare l’evento. Quel giorno non vidi cerini ma lanciafiamme e bombe incendiarie. Sembravano tante bestie, scendevano con un balzo dai camion per scatenare il parapiglia. Il 3 luglio pensai che volessero ucciderci tutti… Non erano umani, erano bestie”.
Rincasando, squilla il telefono fisso. La stufa ha mantenuto nelle ultime ore un tepore piacevole. La porta non era inchiavata, è bastato girare la maniglia per entrare nella casetta vecchio stile di Enrichetta.
“È una storia che mi rende triste. A novantuno anni la ricordo come fosse ieri ed è una storia da non lasciar passare, perché io so che girano ancora certe idee e non vorrei che tornassero a fare quello che hanno fatto… Per l’amor del cielo… No! Era tempo di scegliere: chi andava da una parte, chi dall’altra. Io posso dire di aver scelto la parte migliore. Sono diventata staffetta per non vivere sottomessa, fin da bambina ero così. Ma non bastava il coraggio, dovevi credere nell’ideale, nell’attaccamento ai fratelli, nell’amore per la causa. Combattere per la libertà, perché può andare persa da un momento all’altro”.
 La notte, a Cevo, regna un silenzio assordante. Ed è così anche a Isola, borgo disabitato celebre per la centrale idroelettrica attiva fino al 1973. Il paese sorge come uno scoglio alla confluenza tra il fiume Poia e il rio Piz ed è il luogo dove sono avvenuti gli antefatti che portarono al rogo di Cevo. Il 19 maggio 1944 i nazifascisti trucidarono una famiglia di contadini. La risposta dei garibaldini arrivò il 30 giugno: con un attacco furibondo annientarono il presidio fascista. Due militi vennero uccisi e altri due feriti. Il comandante fu fucilato. Tra i partigiani vi furono un morto e due feriti.
La notte, a Cevo, regna un silenzio assordante. Ed è così anche a Isola, borgo disabitato celebre per la centrale idroelettrica attiva fino al 1973. Il paese sorge come uno scoglio alla confluenza tra il fiume Poia e il rio Piz ed è il luogo dove sono avvenuti gli antefatti che portarono al rogo di Cevo. Il 19 maggio 1944 i nazifascisti trucidarono una famiglia di contadini. La risposta dei garibaldini arrivò il 30 giugno: con un attacco furibondo annientarono il presidio fascista. Due militi vennero uccisi e altri due feriti. Il comandante fu fucilato. Tra i partigiani vi furono un morto e due feriti.
Chissà se gli echi della battaglia arrivarono fino all’ex cimitero militare nel quale vennero sepolti gli ottantacinque soldati che il 3 aprile 1916 morirono nella valanga che travolse la caserma Campelio, al lago d’Arno?
Ciò che rimane, insieme ai ricordi di Enrichetta, è quella casetta presidiata dai fascisti e una falce, unita al martello, incisa sul muro in pietra.
Pubblicato mercoledì 31 Luglio 2024
Stampato il 28/01/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/tra-le-case-bruciate-di-cevo-lamore-per-la-liberta-non-mori/











