 La configurazione del Senato ed i compiti ad esso assegnati, nonché la revisione del Titolo V della Costituzione, sono due delle tre questioni più importanti che la riforma Renzi-Boschi pone (l’altra è il così definito “superamento del bicameralismo paritario“, che in realtà include anch’esso la “questione Senato”), e sono strettamente connesse l’una all’altra. Una dimostrazione immediata sta nel fatto che, come recita l’art. 55 comma 5, «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali» (anche se poi c’è molto da discutere, a partire da questa definizione), ed il Titolo V della Costituzione regola i rapporti fra Stato ed istituzioni locali, quelle appunto la cui rappresentanza (insieme ad una quantità di altre funzioni, di natura del tutto diversa) il testo costituzionale attribuisce al Senato.
La configurazione del Senato ed i compiti ad esso assegnati, nonché la revisione del Titolo V della Costituzione, sono due delle tre questioni più importanti che la riforma Renzi-Boschi pone (l’altra è il così definito “superamento del bicameralismo paritario“, che in realtà include anch’esso la “questione Senato”), e sono strettamente connesse l’una all’altra. Una dimostrazione immediata sta nel fatto che, come recita l’art. 55 comma 5, «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali» (anche se poi c’è molto da discutere, a partire da questa definizione), ed il Titolo V della Costituzione regola i rapporti fra Stato ed istituzioni locali, quelle appunto la cui rappresentanza (insieme ad una quantità di altre funzioni, di natura del tutto diversa) il testo costituzionale attribuisce al Senato.
Nel leggere gli articoli della riforma costituzionale dedicati all’uno ed all’altro tema si rileva che c’è un intento comune, una sorta di fil rouge che sembra aver ispirato questo “nuovo Costituente” nel disegnare da un lato il Senato – in modo così diverso da quello che la Costituzione del ’48 ci ha tramandato (quella dei “padri costituenti”, spesso citati ma, in realtà, ben poco rispettati, perfino nei termini usati) – e dall’altro la trama dei rapporti fra Stato centrale ed Istituzioni locali: questo “intento comune”, sembra di poter dire – naturalmente dovendolo argomentare, come sempre –, è la volontà manifesta di sottrarre sovranità ai cittadini, riducendo la quantità e la qualità della loro partecipazione, e di accentrare il potere nello Stato centrale, le cui prerogative sono saldamente nelle mani della maggioranza della Camera dei Deputati (anche senza considerare gli effetti nefasti dell’Italicum, la legge elettorale attualmente vigente, che è un’arma potente per agevolare la realizzazione di questo disegno), con ben pochi “contrappesi”, che è una delle critiche più severe che vengono (giustamente) espresse a carico dell’impianto complessivo che deriva dalla riforma; e si ha un bel dire che essa non interviene sui vari “poteri”, perché questo è vero solo formalmente (e l’Italicum dà una buona mano, in questo senso), ma c’è tutta una catena di conseguenze che discendono – in punto di fatto – dalla detenzione della maggioranza assoluta alla Camera dei Deputati, che è l’unica “Camera politica” che questa “Riforma” consegna ai cittadini.

Ricordiamo, anche se ormai lo abbiamo letto innumerevoli volte, che il Senato (come da art. 57 comma 1) si compone di «95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica»; i senatori non percepiscono indennità, e sono composti da 74 consiglieri regionali e 21 sindaci – che, si badi, da nessuna parte è scritto che debbano essere quelli delle città capoluogo – (sulle modalità di elezione, che suscitano grandi e polemiche discussioni, non ci soffermiamo in questa sede), tutti eletti dai Consigli regionali (quindi con “elezione di secondo grado“, come tecnicamente viene definita, non con elezione diretta da parte dei cittadini) secondo una ripartizione stabilita – in modo per la verità discutibile – in funzione dell’estensione e della popolazione delle regioni (accenniamo, senza ulteriori commenti, al fatto che le due Province autonome di Trento e Bolzano – le uniche “superstiti” – eleggono ciascuna un consigliere ed un sindaco: ben quattro senatori, per una Regione con circa un milione di abitanti. Strana disproporzione).
Però il Senato resta una delle due Camere di cui si compone il Parlamento: infatti l’art. 55 comma 1 della “Costituzione riformata” recita «Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica». Ma, viene da osservare, visto che il Parlamento – il luogo centrale dello Stato democratico rappresentativo – si compone di due Camere, la sovranità che l’art. 1 dichiara “appartenere al popolo” dovrebbe essere esercitata (esercitata, non soltanto dichiarata) su entrambe: lascia molto dubbiosi che un Senato non direttamente eletto dal popolo rispecchi compiutamente la sovranità che a questo appartiene, perché abbiamo imparato da sempre che il momento elettorale è una delle massime espressioni (benché non l’unica) della “sovranità popolare” (lo scriveva Norberto Bobbio già nel 1984). Quindi, comunque essa venga motivata (ma le motivazioni che vengono date, di vario tipo, sono tutte fortemente discutibili: e nessuna di esse ha la forza dei princìpi), la decisione di istituire un Senato “non-elettivo” costituisce, nei fatti, una grave riduzione di sovranità, alterando ed indebolendo così uno dei principi fondamentali delle democrazie rappresentative (è arduo sostenere la “rappresentatività indiretta”, o per interposta elezione, per giunta di altro tipo e per altro scopo, come quella di un consigliere regionale o di un sindaco che poi, et voilà, va a fare – a part time, con tutte le perplessità che questo suscita – il senatore della Repubblica).

I rapporti fra lo Stato e le “istituzioni territoriali”, la cui “rappresentanza” il testo costituzionale attribuisce al Senato, sono regolati dal Titolo V, composto dagli articoli 114-133: la cui lettura rivela che non solo il “morbo” riscontrato per il Senato – la riduzione di sovranità – si è propagato anche a questa parte, ma che esso si è anche ingigantito, producendo altri e non meno gravi guasti.
Guardiamo il caso delle Province: l’art. 114 comma 1 della Costituzione vigente recita «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato», quello della riforma è stato modificato in «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato»: vale a dire che è stata semplicemente eliminata la parola “Province”, e così è stato fatto con tutti gli articoli in cui essa compariva. In questo consiste la tanto decantata – dai sostenitori del Sì – “abolizione delle Province“: con un tratto di penna, si cancella il nome e si fa sparire la cosa. In effetti non c’è stato alcun atto legislativo che abbia decretato la soppressione di questo “corpo dello Stato”. Ma la verità è che, pur senza più il nome, “la cosa” continua ad esistere: infatti, il Consiglio provinciale viene eletto non più direttamente dai cittadini ma solo (in numero dipendente dalla quantità di abitanti) dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia (elezione perciò di secondo grado, come si dice), «con una ripartizione dei seggi provinciali in base alla consistenza delle forze politiche, nell‘indifferenza generale dei cittadini» (Andrea Pertici, costituzionalista). Ma c’è addirittura di più: nella legge che contiene la riforma (n° 88/2016) vengono previste, al loro posto, nuove entità territoriali, dette “enti di area vasta“, un livello intermedio fra quello comunale e quello regionale, a cui probabilmente saranno affidati i compiti amministrativi che si ritiene i Comuni non siano in grado di svolgere in modo adeguato. Fra l’altro, si deve osservare che le Città metropolitane (che sono solo 9), mantenute in Costituzione, costituiscono sì “enti di area vasta”, ma lasciano scoperti altri Comuni che non sono inseriti in quell’area vasta metropolitana e avranno anch’essi necessità di un ente intermedio rispetto al livello regionale, altrimenti sarebbero gravemente svantaggiati rispetto ai Comuni “metropolitani”. Al posto di una Provincia avremo perciò una pluralità di “enti di area vasta”, ciascuno dotato di vertici decisionali e di struttura amministrativa (Gustavo Zagrebelsky, costituzionalista). E quindi quello che realmente è stato fatto è l’abolizione dei consiglieri provinciali eletti dai cittadini: un altro livello di sovranità popolare che viene meno.
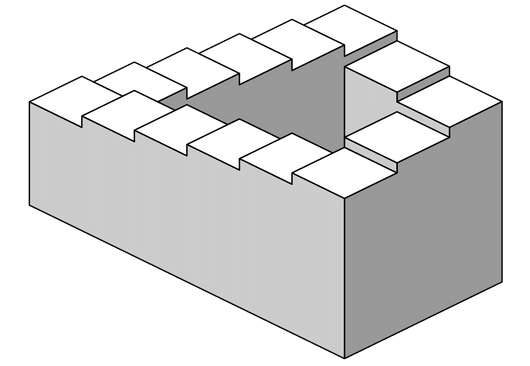
Quanto al contenuto generale della Revisione del Titolo V – che è una modifica delle molte modifiche che furono apportate nel 2001, ed approvate con Referendum: prova che non c’è nulla di nuovo sotto il cielo, benché qualcuno dica il contrario –, il suo “cuore” è nell’art. 117: esso interviene sul riparto delle competenze legislative e regolamentari, con uno “sterminato elenco” (Ugo De Siervo, costituzionalista) che effettua una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale, queste ultime individuate solo in via residuale, nel senso che compete alle Regioni tutto ciò che non compete allo Stato.
Compaiono però molte materie per le quali è riservata allo Stato stesso la facoltà di emettere disposizioni generali e comuni valide su tutto il territorio nazionale, anche se lo Stato non ne ha competenza esclusiva: il che, evidentemente, indebolisce i poteri delle Regioni (Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, costituzionalisti). Viene inoltre fissata una “clausola di supremazia“, in forza della quale «Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale».
Tutto questo configura, con solare evidenza, un forte accentramento dei poteri, dalle Regioni allo Stato centrale: esattamente il contrario di quello che il momento storico richiede (il passato Referendum sulle “trivelle”, le molte agitazioni locali per vari motivi ambientali, la specificità delle situazioni economico-sociali, e mille altre ragioni lo dimostrano), e malgrado l’art. 5 della Costituzione (non modificato), detti che «La Repubblica […] adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento»: tanto che in un suo articolo il costituzionalista Annibale Marini ha scritto che «La riforma della potestà legislativa nel rapporto Stato-Regioni è talmente sbilanciata a favore del potere centrale da potersi addirittura prospettare la violazione del precitato articolo 5 della Costituzione».
A questo si aggiunge il fatto che le cinque Regioni “a statuto speciale” (Val d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, in tutto 9 milioni di abitanti, non soltanto sono state mantenute -– e conservano perciò i loro privilegi in campo legislativo, amministrativo e fiscale –, ma possono dormire sonni tranquilli sia per il presente, perché ad esse non si applicano le modifiche oggetto del Capo IV della Revisione del Titolo V – che riguardano (riporto da “lavoce.info” del 25.11) la soppressione delle Province, l’individuazione delle materie di competenza esclusiva dello stato e delle regioni, l’inserimento dei principi di semplificazione e trasparenza nell’esercizio delle funzioni amministrative, l’aggiornamento delle disposizioni sul federalismo fiscale, l’inserimento di limiti agli emolumenti degli organi regionali e l’introduzione dell’equilibrio di genere nella rappresentanza (Michele Ainis, costituzionalista, le ha perciò definite “Cinque SuperStati“) –, ma anche per il futuro, in quanto l’art. 39 comma 13 della legge di Riforma stabilisce che le modifiche non si applicano «fino alla revisione dei rispettivi statuti [che richiederebbe, si noti, un procedimento costituzionale] sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome…», intese che non vi saranno mai; una vera “fidejussione perpetua”, l’ha perciò definita Michele Ainis.
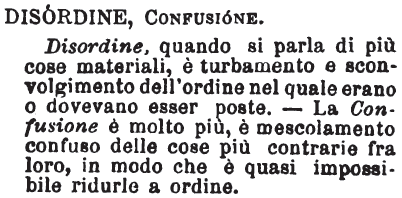 Per tutte queste ragioni il Presidente emerito della Corte Ugo De Siervo scrive, a conclusione del suo saggio La brutta fine del nostro regionalismo: «Mi sembra quindi necessario considerare criticamente anche questa importante parte della riforma costituzionale che è stata deliberata, che ci porta non solo alla fine del nostro regionalismo, ma anche ad uno sgangherato riaccentramento ed a un paradossale aumento di privilegi delle Regioni speciali».
Per tutte queste ragioni il Presidente emerito della Corte Ugo De Siervo scrive, a conclusione del suo saggio La brutta fine del nostro regionalismo: «Mi sembra quindi necessario considerare criticamente anche questa importante parte della riforma costituzionale che è stata deliberata, che ci porta non solo alla fine del nostro regionalismo, ma anche ad uno sgangherato riaccentramento ed a un paradossale aumento di privilegi delle Regioni speciali».
Dunque, in conclusione: riduzione della sovranità popolare, forte accentramento dei poteri, ingiustificata persistenza di privilegi per le cinque “Regioni speciali”: sono ragioni talmente forti, in negativo, da non consentire la discussione su alcuni punti che pur sarebbero accettabili, e sul fatto che il Titolo V necessiti certamente di modifiche, ma purtroppo non queste, non tutte queste: lo hanno scritto anche 56 costituzionalisti, in un appello del giugno scorso: gli «aspetti positivi non sono tali da compensare gli aspetti critici»; il professor Emanuele Rossi, costituzionalista della scuola Sant’Anna di Pisa, ha scritto che «il testo uscito dal Parlamento è assai deficitario»; il professor Cheli ha parlato di «veri e propri errori di sintassi costituzionale». Per tutto questo, insieme a molte altre ragioni, non si può che votare No.
Franco Bianco – Ricercatore in scienze economiche e sociali
Pubblicato venerdì 2 Dicembre 2016
Stampato il 24/11/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/senato-e-autonomie-una-ferita-democratica-comune/








