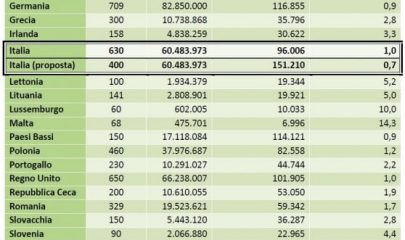Ormai da alcuni mesi la cronaca politica registra con allarmante frequenza le diatribe interminabili tra il governo e le regioni sulle modalità di applicazione delle misure di contenimento del contagio da covid-19 dettate dai più recenti Dpcm. I motivi del contendere sono i più diversi, e, come spesso accade, hanno diversi livelli di fondatezza e anche diversi gradi di strumentalità politica (considerato anche che la maggior parte delle regioni sono governate da maggioranze differenti da quella che sostiene il governo in carica) ma, nel loro complesso, si può dire che riflettano lo stato di tensione di un Paese snervato dall’incerta convivenza con una pandemia che non accenna ad esaurirsi e dalle paure che ne derivano. Le misure adottate sono via via definite troppo permissive o troppo rigide, viene invocata alternativamente dai presidenti delle regioni maggiore severità o, viceversa, minor rigore dei divieti e elle limitazioni, mentre dal canto suo, l’esecutivo si trova spesso a rincorrere ordinanze regionali difformi dai vincoli posti con i Dpcm, a stigmatizzare alcune condotte delle istituzioni locali e a ricorrere con frequenza all’impugnazione dei relativi atti davanti al giudice amministrativo.

Lo sconcerto determinato da questa conflittualità ha fatto parlare di una vera e propria crisi del sistema regionale, al quale non pochi osservatori imputano un esercizio delle competenze in materia sanitaria che ha condotto, nel corso degli anni, ad accentuare le difformità tra i territori, le inefficienze e gli sprechi che hanno pregiudicato l’efficacia dell’azione di contenimento del contagio da covid-19 e che sono state spesso compensate solo dall’abnegazione e dalla competenza del personale sanitario. Una critica forse eccessiva, ma non priva di fondamento, e alla quale non si tratta tanto di replicare o meno, quanto di raccoglierne le sollecitazioni per tentare di abbozzare un quadro dei problemi e delle possibili soluzione della vexata quaestio del rapporto tra Stato e Regioni, nel suo concreto svolgimento storico, a partire dall’Assemblea Costituente.

Un regionalismo debole
Al momento dell’approvazione della Costituzione, il regionalismo delineato nel Titolo V lasciò ampiamente insoddisfatti i non molti fautori dell’ordinamento federale in seno all’Assemblea Costituente: secondo una felice definizione di uno dei più autorevoli di essi, Emilio Lussu, le norme in materia erano tali che le regioni avrebbero potuto considerarsi appartenenti alla famiglia politica del federalismo allo stesso modo in cui un gatto avrebbe potuto definirsi appartenente alla stessa famiglia di un leone.

Lussu coglieva in effetti una parte non piccola di verità: il sistema regionale definito dalla Carta fondamentale nasceva da un compromesso tra diversi orientamenti politici e da non pochi ripensamenti.
Tutte le forze antifasciste avevano convenuto, in origine, che occorresse non solo ripristinare ma rafforzare il sistema delle autonomie locali che il fascismo aveva liquidato, nel presupposto che costituisse uno dei principali ostacoli all’affermazione del regime totalitario, e non erano mancate prese di posizione in senso fortemente autonomistico durante la Resistenza. Ma dopo la Liberazione, si era passati da un generico consenso di principio a una più approfondita riconsiderazione dell’intera problematica: la Democrazia cristiana – pur erede del regionalismo dal Partito popolare, che aveva declinato in questa formula la propensione della Santa Sede a considerare il pluralismo istituzionale un fattore di garanzia nei confronti delle pretese egemoniche avanzate dallo Stato usurpatore del potere temporale – non era indifferente alle resistenze a un assetto istituzionale decentrato provenienti dai vertici dell’amministrazione pubblica e della magistratura nonché da settori consistenti della vecchia classe dirigente liberale, ceti dei quali aspirava di assumere la rappresentanza in nome del principio della continuità dello Stato, mentre comunisti e socialisti si erano attestati su una posizione di affermazione del primato della rappresentanza parlamentare nazionale tale da escludere l’eventualità che la funzione di indirizzo politico potesse essere condivisa con organismi sub statali, e ritenevano pertanto che alle regioni dovessero essere affidate funzioni amministrative e non la potestà legislativa, se non adeguatamente limitata dal potere centrale.

Il compromesso costituzionale che ne era scaturito aveva delineato un regionalismo limitato, caratterizzato da poteri circoscritti e presidiati da una serie di controlli che ne condizionavano ulteriormente il raggio d’azione; anche con questa connotazione, peraltro, il Titolo V rimase lettera morta per oltre vent’anni e solo nel 1970 furono eletti i consigli regionali che affiancavano così i già esistenti organi di governo delle Regioni a statuto speciale attivate tra il 1945 e il 1948, alle quali si era aggiunta, nel 1963, il Friuli Venezia Giulia.
La crisi degli anni 90 e la nascita dei partiti regionali
Pur debole e contraddittorio e attuato con straordinaria lentezza anche dopo l’insediamento dei primi consigli regionali, il sistema definito dal Titolo V visse tra il 1970 e la fine del secolo una stagione tutto sommato poco agitata, dando vita anche a esperienze di governo interessanti e innovative, ma pur sempre in un contesto di relativo equilibrio rispetto al contesto politico e istituzionale nazionale.
 Il quadro si rimise in moto con la crisi della cosiddetta prima Repubblica e soprattutto in relazione a due circostanze: la nascita di partiti regionali a vocazione separatista e la svolta maggioritaria sancita dal referendum del 1993. Si tratta di due fenomeni distinti, ma destinati a una confluenza che, alla fine del secolo avrebbero contribuito a modificare profondamente il regime delle autonomie locali.
Il quadro si rimise in moto con la crisi della cosiddetta prima Repubblica e soprattutto in relazione a due circostanze: la nascita di partiti regionali a vocazione separatista e la svolta maggioritaria sancita dal referendum del 1993. Si tratta di due fenomeni distinti, ma destinati a una confluenza che, alla fine del secolo avrebbero contribuito a modificare profondamente il regime delle autonomie locali.
Con la nascita e l’affermazione della Lega lombarda e poi di altre analoghe formazioni nel nord Italia, si assiste a un processo inedito: il consenso attorno ai partiti separatisti si forma sull’onda del crescente malessere nei confronti del degrado della vita pubblica, ma si rafforza soprattutto grazie a un’insistente campagna propagandistica tesa a dimostrare che il potere centrale dello Stato aveva promosso negli anni e in modo sistematico, avvalendosi soprattutto della leva fiscale, un trasferimento di risorse dalle aree economicamente più attive a quelle più svantaggiate, in funzione di politiche clientelari e assistenzialistiche, volano di una spesa pubblica improduttiva.
 In base a queste premesse, il recupero dell’antico pregiudizio del Mezzogiorno come “palla al piede” coniugato con il nuovo slogan “Roma ladrona” legittimava il separatismo come programma massimo, e la trasformazione in senso federale dell’ordinamento come obiettivo intermedio, obiettivo destinato a diventare parte integrante, anche se controversa, del programma dell’alleanza di centro destra guidata da Silvio Berlusconi.
In base a queste premesse, il recupero dell’antico pregiudizio del Mezzogiorno come “palla al piede” coniugato con il nuovo slogan “Roma ladrona” legittimava il separatismo come programma massimo, e la trasformazione in senso federale dell’ordinamento come obiettivo intermedio, obiettivo destinato a diventare parte integrante, anche se controversa, del programma dell’alleanza di centro destra guidata da Silvio Berlusconi.
 Si verificava così quella che si può definire una “inversione ideologica”: il federalismo, tradizionale appannaggio della sinistra repubblicana e azionista, oltre che di una parte del pensiero cattolico progressista, nella polemica contro il centralismo dello stato monarchico, diventava una bandiera della destra, con un significativo riallineamento dei contenuti: mentre il federalismo “storico” aveva puntato soprattutto a una democratizzazione del sistema politico attraverso una più intensa partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale, il federalismo della destra si presentava come una declinazione sul piano istituzionale del pensiero unico neoliberista, con la riconduzione della sfera pubblica alla dimensione della competizione di mercato, nella quale i soggetti più forti devono essere messi nelle condizioni di prevalere nel controllo e nella gestione dei beni della collettività, lasciando ai meccanismi spontanei del mercato il compito di riassorbire gli squilibri territoriali.
Si verificava così quella che si può definire una “inversione ideologica”: il federalismo, tradizionale appannaggio della sinistra repubblicana e azionista, oltre che di una parte del pensiero cattolico progressista, nella polemica contro il centralismo dello stato monarchico, diventava una bandiera della destra, con un significativo riallineamento dei contenuti: mentre il federalismo “storico” aveva puntato soprattutto a una democratizzazione del sistema politico attraverso una più intensa partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale, il federalismo della destra si presentava come una declinazione sul piano istituzionale del pensiero unico neoliberista, con la riconduzione della sfera pubblica alla dimensione della competizione di mercato, nella quale i soggetti più forti devono essere messi nelle condizioni di prevalere nel controllo e nella gestione dei beni della collettività, lasciando ai meccanismi spontanei del mercato il compito di riassorbire gli squilibri territoriali.
 Questo progetto postulava due passaggi fondamentali: un ampliamento della sfera di competenza dei poteri locali, soprattutto in materia fiscale, e un sistema di governo locale connotato in senso fortemente decisionista, proprio al fine di agire con maggiore incisività nella contesa interistituzionale per il controllo delle risorse pubbliche. Malgrado la pandemia abbia dimostrato ampiamente l’insostenibilità di un simile progetto istituzionale, per la verità piuttosto rozzo e comunque rimasto, per fortuna, in larga misura inattuato, alcuni postulati di esso vengono riproposti nell’attuale progetto di autonomia differenziata che, al di là di qualche buona intenzione di alcuni dei proponenti, riproduce l’impostazione che si è cercato fin qui di illustrare e che, malgrado le dure lezioni del presente, continua a perseguire obiettivi che privilegiano gli interessi locali, senza alcun bilanciamento rispetto agli interessi generali del Paese – in un quadro che, tra l’altro non può prescindere dalla dimensione europea – e quello degli altri territori.
Questo progetto postulava due passaggi fondamentali: un ampliamento della sfera di competenza dei poteri locali, soprattutto in materia fiscale, e un sistema di governo locale connotato in senso fortemente decisionista, proprio al fine di agire con maggiore incisività nella contesa interistituzionale per il controllo delle risorse pubbliche. Malgrado la pandemia abbia dimostrato ampiamente l’insostenibilità di un simile progetto istituzionale, per la verità piuttosto rozzo e comunque rimasto, per fortuna, in larga misura inattuato, alcuni postulati di esso vengono riproposti nell’attuale progetto di autonomia differenziata che, al di là di qualche buona intenzione di alcuni dei proponenti, riproduce l’impostazione che si è cercato fin qui di illustrare e che, malgrado le dure lezioni del presente, continua a perseguire obiettivi che privilegiano gli interessi locali, senza alcun bilanciamento rispetto agli interessi generali del Paese – in un quadro che, tra l’altro non può prescindere dalla dimensione europea – e quello degli altri territori.
I parziali successi conseguiti dal federalismo di destra sono da ricondurre al fatto che quest’ultimo si è intrecciato con l’opzione maggioritaria che è prevalsa in Italia dopo il referendum del 1993: un’opzione, va detto, che aveva al fondo motivazioni di non poco momento, a partire dalla prospettiva, venuto meno l’assetto bipolare degli equilibri mondiali, di porre fine al sistema di democrazia bloccata durato per quasi un cinquantennio e di mettere mano a regole elettorali che favorissero la polarizzazione del sistema politico e la formazione di maggioranza politiche omogenee, e con esse l’alternanza al governo di forze politiche di diversa ispirazione.

Ma questo orientamento si svolse, come è noto, in un contesto di grave e profonda crisi del sistema politico, per cui in seno all’opzione maggioritaria si fece strada e alla fine prevalse una visione leaderistica e plebiscitaria della democrazia, basata, tra l’altro, su una idea di primato del principio di governabilità che sacrificava non solo il pluralismo della rappresentanza, ma la stessa dialettica tra organi rappresentativi e organi di governo, oltre che tra maggioranza e opposizione, per non parlare dell’insofferenza nei confronti delle funzioni di garanzia esercitata dalla magistratura e dalla Corte costituzionale.
 Il vero laboratorio politico entro il quale si è portato avanti in modo coerente il progetto maggioritario è costituito dai poteri locali: Comuni (e Province, fin quando hanno avuto una vita propria) e Regioni. Mentre a livello nazionale, la legge elettorale del 1993 portava a un sistema misto, con prevalenza del maggioritario, una più decisa torsione in questa direzione si avviava con la normativa del 1993 per l’elezione diretta dei sindaci, dei presidenti delle Province (allora ancora funzionanti) e successivamente (1999) dei presidenti delle Regioni. Queste riforme hanno dato vita a un sistema monocratico, fortemente squilibrato sul versante della governabilità e privo di effettivi contrappesi, garantito da un sistema premiale finalizzato ad assicurare la stabilità di una maggioranza sempre più confinata in un funzione di ratifica delle decisioni assunte da organi di governo, nei quali la preminenza del capo dell’esecutivo risultava assicurata dal modo dell’investitura (viene riconosciuto il potere di nomina e revoca degli assessori). In questo contesto, tra l’altro, all’opposizione spesso e volentieri non resta che rifugiarsi nel sottogoverno locale per esercitare una parvenza di prerogative che leggi, statuti e regolamenti non hanno mai definito.
Il vero laboratorio politico entro il quale si è portato avanti in modo coerente il progetto maggioritario è costituito dai poteri locali: Comuni (e Province, fin quando hanno avuto una vita propria) e Regioni. Mentre a livello nazionale, la legge elettorale del 1993 portava a un sistema misto, con prevalenza del maggioritario, una più decisa torsione in questa direzione si avviava con la normativa del 1993 per l’elezione diretta dei sindaci, dei presidenti delle Province (allora ancora funzionanti) e successivamente (1999) dei presidenti delle Regioni. Queste riforme hanno dato vita a un sistema monocratico, fortemente squilibrato sul versante della governabilità e privo di effettivi contrappesi, garantito da un sistema premiale finalizzato ad assicurare la stabilità di una maggioranza sempre più confinata in un funzione di ratifica delle decisioni assunte da organi di governo, nei quali la preminenza del capo dell’esecutivo risultava assicurata dal modo dell’investitura (viene riconosciuto il potere di nomina e revoca degli assessori). In questo contesto, tra l’altro, all’opposizione spesso e volentieri non resta che rifugiarsi nel sottogoverno locale per esercitare una parvenza di prerogative che leggi, statuti e regolamenti non hanno mai definito.

Pur essendo stata attuata con leggi ordinarie, la riforma del sistema elettorale locale ha comunque prodotto l’effetto di una vera e propria riforma costituzionale, ridisegnando una porzione importante del nostro ordinamento secondo principi e modalità di investitura degli organi di governo differenti da quelli adottati al centro, nel quale l’auspicata polarizzazione del sistema politico è stata più apparente che reale. Il che, tra l’altro, ha fatto sì che le opzioni più propense alla valorizzazione del premierato – tradottesi in due riforme costituzionali del 2006 e del 2016, entrambe bocciate dall’elettorato – si presentassero come quelle rivolte a favorire un sistema basato sull’elezione “del sindaco d’Italia”, ovvero su una legittimazione diretta del potere esecutivo finalizzata, in ultima analisi, a rimettere in discussione il carattere parlamentare della forma di governo.
Sul mutamento della forma di governo locale, si è poi innestata la riforma del Titolo V della Costituzione, frettolosamente approvata al termine della XIII Legislatura: una riforma figlia di un dibattito sull’indirizzo federalista estremamente confuso e appeso al filo di un compromesso tra una destra intenzionata soprattutto a fare valere le rivendicazioni di territori economicamente forti e a depotenziare il principio della solidarietà interterritoriale e una sinistra disponibile a fare concessioni nel senso di un ridimensionamento dei poteri dello Stato centrale, anche a rischio di aprire dei varchi a un regime differenziato anche nell’esercizio dei diritti fondamentali.

Non è questa la sede per entrare nel merito degli aspetti specifici di una riforma che, nel complesso, ha mostrato notevoli limiti. Basterà qui soffermarsi su un aspetto che, rimasto sottotraccia, ha assunto un grande rilievo con le vicende della pandemia, per la conflittualità che si è venuta a determinare tra le Regioni e il Governo centrale, e che appare agli occhi di una parte non piccola dell’opinione pubblica la manifestazione di una grave patologia dell’ordinamento.
Ora, in linea di principio, occorre premettere che nei moderni sistemi costituzionali, connotati da un pluralismo istituzionale più o meno marcato, i conflitti di attribuzioni tra diversi soggetti dell’ordinamento, sono fisiologici e, in una certa misura necessari, soprattutto laddove agiscono da contrappeso e quindi da limite rispetto al governo centrale e alla maggioranza politica che lo sostiene: tanto più in contesti come quello attuale, nei quali lo stato di eccezione comporta, non solo in Italia ma anche negli altri paesi europei, una temporanea espansione dei poteri posti in capo all’organo esecutivo, a scapito della rappresentanza parlamentare.

È innegabile, tuttavia, che lo stillicidio di polemiche tra centro e periferia a cui hanno dato luogo i diversi Dpcm varati dall’inizio della pandemia ad oggi hanno creato una diffusa irritazione e una insofferenza che spinge molti osservatori a ritenere necessario giungere a un “regolamento dei conti” tra i contendenti, magari con un netto ridimensionamento dei poteri delle Regioni. Ma il punto è proprio questo, ossia il fatto che non esistono modi codificati di “regolare i conti”, ovvero procedure e soggetti per la composizione dei conflitti e tanto meno sedi formali di concertazione Stato-Regioni-autonomie locali legittimati a prendere decisioni vincolanti per tutti coloro che siedono allo stesso tavolo (tale non è stata, nella crisi sanitaria, l’attuale Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano). Un compito del genere, forse, avrebbe potuto spettare a una camera delle regioni, in un contesto di bicameralismo differenziato.

Se si confronta il testo originario del Titolo V della Costituzione con la riforma varata nel 2003, non sfugge un dato: il testo attualmente vigente ha eliminato le figure istituzionali che, certamente in modo manchevole e derivante da una persistente diffidenza nei confronti del principio stesso del decentramento istituzionale, rappresentavano comunque, nella formulazione originaria, una forma di raccordo tra Stato e Regioni: il Commissario di Governo, con funzioni di coordinamento delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e dalla Regioni e con potere di rinviare al Consiglio regionale le leggi per motivi di competenza o per contrasto con gli interessi dello Stato di altre Regioni; e gli organi statali di controllo sulla legittimità (e di merito in casi limitati da riserva di legge) degli atti amministrativi regionali. Soppressi questi organismi con la legge costituzionale del 2003, l’unica via di composizione dei conflitti è rimasta quella giudiziaria, di fronte al giudice amministrativo o alla Corte costituzionale, con la conseguenza di una crescita esponenziale del contenzioso statale e regionale, che ha a sua volta accentuato quell’incertezza sui tempi e sui contenuti delle decisione politica che proprio la svolta in senso maggioritario del sistema politico avrebbe dovuto invece rimuovere.
Proprio per l’assenza di raccordi istituzionali adeguati, si può affermare che quello a cui si è assistito in questi ultimi mesi non è il fisiologico svolgimento della necessaria dialettica tra Stato e Regioni, ma una guerriglia condotta prevalentemente sul terreno mediatico, in assenza di un sistema di regolazione e composizione dei conflitti, di sedi deputati e risolverli e di procedure ad hoc: il che, ovviamente, segna una delle maggiori limiti della riforma costituzionale del 2003, anche se non l’unico.
Nei primi anni del secolo, si è parlato molto, e anche molto a sproposito di federalismo: oggi il rischio è che si reagisca ai fallimenti della riforma costituzionale del Titolo V con un neo centralismo che aggraverebbe i problemi senza risolverli. Il pluralismo istituzionale è una ricchezza, alla quale non si deve rinunciare in base a reazioni non adeguatamente meditate, anche se comprensibili quando si considerino le poco edificanti liti tra il Governo e le Regioni a cui si assiste da alcuni mesi a questa parte.
Quel che è certo è che la pandemia ha accelerato tutti i processi già in atto, e ha messo brutalmente i governi e i cittadini di fronte al dato incontrovertibile del fallimento prodotto, non solo in Italia ma in tutta l’Unione europea e anche al di là dei confini del Vecchio continente, dalle politiche di contenimento della spesa pubblica e di ridimensionamento dello stato sociale: i dogmi del neo liberismo si sono rivelati inservibili per fare fronte a una crisi di proporzioni inedite e le politiche espansive sono state frettolosamente riesumate da un letargo pluridecennale, spesso in virtù di un tardivo ripensamento di molti governanti.

In situazioni complesse, di riaggiustamento delle politiche e anche di ricerca di soluzioni innovative a fronte di situazioni drammatiche quanto impreviste, una certa fluidità dei rapporti interistituzionali è inevitabile, ma richiede di essere regolata secondo criteri di trasparenza e di garanzia del pluralismo e delle prerogative della maggioranza e dell’opposizione: lo sta verificando anche l’Unione europea, nel caso del veto posto dai governi reazionari da Polonia e Ungheria al Recovery Fund (ora forse in via di superamento), proprio perché il sistema dei veti è tradizionalmente lo strumento tipico di ordinamenti nei quali un livello insoddisfacente di legittimazione democratica degli organi di vertice comporta anche una difficoltà obiettiva ad attivare efficaci procedure di decisione (e di accertamento della legittimità delle decisioni stesse) proprie delle moderne democrazie parlamentari.
Il problema di fondo, dunque, non consiste nel riequilibrio, a favore dell’uno o dell’altro contendente, del rapporto tra diversi livelli di governo, ma nella capacità di scongiurare il rischio che una conflittualità priva di regole finisca con il perpetrare se stessa e tradursi in inefficacia quando non in paralisi dell’azione di governo. Alla lamentata eterogeneità dell’intervento pubblico è possibile fare fronte quando vi sia chiarezza sul regime delle competenze e delle rispettive responsabilità: se si guarda alle materie disciplinate dal Titolo V, ciò è possibile già oggi, nel limite delle vigenti disposizioni costituzionali, poiché nell’ambito dell’ordinamento regionale della Repubblica, è prerogativa del Governo centrale e della maggioranza politica che lo sostiene esercitare tutte le funzioni di indirizzo e coordinamento finalizzate a garantire l’uniforme esercizio dei diritti fondamentali e ad assicurare quella che l’art. 120 della Costituzione definisce “la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”. Occorre forse un maggiore impegno d riflessione e di approfondimento su quelle che Costantino Mortati definiva le “cerniere” dell’ordinamento, ovvero le procedure e i soggetti ai quali affidare il compito di definire modi certi di attuazione del principio di leale collaborazione tra le istituzioni e di composizione degli inevitabili conflitti tra centro e periferia, per rendere più fluido e trasparente il processo decisionale e soprattutto per scongiurare il rischio che la pur legittima dialettica tra i diversi livelli di governo degeneri in una rissa il cui unico esito consiste nell’incremento della sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche.
Pubblicato sabato 28 Novembre 2020
Stampato il 25/11/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/pandemia-e-guerriglie-istituzionali/