

“Non vi riprenderete mai il nostro Paese con la debolezza. Dovete esibire forza e dovete essere forti. Siamo giunti qui per chiedere che il Congresso faccia la cosa giusta e che conti solo gli elettori che sono stati nominati legalmente. So che ognuno di voi presto marcerà sul Campidoglio per far sì che oggi la vostra voce, pacificamente e patriotticamente, venga ascoltata. (…) Combattete. Combattiamo come dannati. E se non combatterete come dannati, per voi non vi sarà più un Paese (…)”.
Con queste incendiarie parole Donald Trump, dietro uno schermo di vetro, il 6 gennaio 2021 si rivolgeva alla variopinta platea dei suoi seguaci a Washington. Nel discorso, volto a impedire la conferma, per mano del Congresso, dell’elezione del democratico Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti, chiedeva esplicitamente al vicepresidente Mike Pence di vanificare l’esito delle urne del novembre 2020. Avrebbe dovuto essere quest’ultimo – secondo quanto ha ammesso l’ex capo di Gabinetto dell’amministrazione Trump, Mark Meadows – uno dei passaggi del piano che avrebbe portato a un vero e proprio colpo di Stato, finalizzato a mantenere ancora alla Casa Bianca “The Donald”.

Tuttavia, il disegno eversivo non è andato in porto, anche se si è trattato di un tentativo senza precedenti nella storia degli Usa, così come non ha riscontri nel passato della Repubblica nordamericana il clamoroso assalto a Capitol Hill condotto dai sostenitori del tycoon newyorchese, accorsi in migliaia alla “Marcia per salvare l’America” (Save America March) e infervorati dalle invettive di Trump, del suo consigliere e avvocato Rudolph Giuliani, nonché dei deputati Mo Brooks e Madison Cawthorn.

Espressione della galassia dell’estrema destra interna, razzista e xenofoba, militanti e simpatizzanti dei “Proud Boys”, dei “Libertarians”, dei “Groypers”, di “Qanon”, tra cui il pittoresco sciamano Jake Angeli, si sono riversati tumultuosamente nel palazzo del Congresso, mettendo seriamente in pericolo, per alcune ore, la tenuta delle istituzioni democratiche statunitensi. Sconcerto e scalpore hanno suscitato dappertutto le immagini provenienti da Oltreoceano, sequenze di un film che è stato riproposto, secondo modalità per certi versi non dissimili, in occasione dell’irruzione violenta orchestrata dai neofascisti di Forza Nuova nella sede nazionale della Cgil a Roma il 9 ottobre 2021.

Quanto è accaduto a Washington un anno fa è destinato certamente a restare scolpito nell’immaginario degli statunitensi, come altri drammatici momenti: l’inizio della guerra di Secessione, nell’aprile 1861, il micidiale attacco sferrato dai giapponesi contro la base di Pearl Harbor nelle Hawaii, il 7 dicembre 1941, l’assassinio a Dallas del presidente John Fitzgerald Kennedy, il 22 novembre 1963, l’attacco alle Torri Gemelle a New York a opera del terrorismo jihadista, l’11 settembre 2001.

A Washington il giorno dell’epifania 2021 è andato in scena un evento che ha dimostrato, in maniera inequivocabile, le profonde fratture che da tempo solcano gli Stati Uniti. Ascrivibili all’emergere di purulente lacerazioni – è il caso di rammentarlo – sono tanto l’assassinio a Minneapolis, il 25 maggio 2020, dell’afro-americano George Floyd, soffocato dall’agente di polizia Derek Chauvin, quanto i fatti di Charlottesville del 12 agosto 2017, quando un’auto si lanciò su un corteo antirazzista, uccidendo una manifestante scesa in piazza per contrastare la protesta dei suprematisti bianchi contro la rimozione di una statua del generale sudista Robert E. Lee.

I due gravi episodi hanno segnalato, una volta di più, il diffondersi di pratiche e comportamenti riconducibili all’orizzonte politico-ideologico dell’estrema destra e il perdurare dell’odio e dei pregiudizi razzistici, contro i quali si è vigorosamente attivato il movimento Black Lives Matter.

Donald Trump non ha fatto altro che esasperare conflitti e tensioni, assecondando e solleticando gli umori più retrivi allignanti nella società statunitense. Già nella campagna elettorale per le presidenziali del 2016, nel corso della quale ha ripetuto ossessivamente lo slogan (rivelatosi poi vincente) Make America Great Again, si è distinto per gli insulti a ispanici e musulmani, per la sua netta opposizione all’immigrazione e al multiculturalismo, per la richiesta di blindare il confine con il Messico, per l’esibizione in atteggiamenti machisti e per il rifiuto di mostrare la propria dichiarazione dei redditi.

Grazie a uno stile ben lontano dal politically correct, all’abile uso dei social network e alla capacità di attrarre attenzione mediatica sfruttando la sua notorietà di popolare personaggio televisivo, Trump ha sedotto ampie fasce dell’elettorato statunitense, riuscendo a fare breccia tra i “perdenti della globalizzazione”, tra i “bianchi poveri” (whites poor), oltremodo penalizzati dai processi di deindustrializzazione e di decentramento produttivo che, nel giro di qualche decennio, hanno ridotto il Midwest a una rust belt, la “cintura della ruggine”.

Ricorrendo sistematicamente all’armamentario della retorica populista e anti-establishment, il magnate newyorchese si è imposto nel 2016, battendo una figura politica di lungo corso come la democratica Hillary Clinton e diventando il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti.

La sua affermazione, che pure ha sorpreso molti osservatori in America e nel mondo, non costituiva – a ben guardare – una novità. Altri miliardari, affidandosi alle medesime risorse e “armi”, avevano già conquistato il potere politico: dall’apripista di questo filone, l’italiano Silvio Berlusconi, allo svizzero Christoph Blocher, all’argentino Mauricio Macri, al cileno Sebastián Piñera, per arrivare al thailandese Thaksin Shinawatra. La loro ascesa ha provato quanto sia precario lo stato di salute della democrazia rappresentativa nell’età del capitalismo globale, caratterizzata dalla subordinazione della politica all’economia, dalla crescente disillusione degli elettori, dalla pervasività del web e dalla crisi del giornalismo di qualità.

Al vertice della superpotenza nordamericana, Trump per quattro anni è stato un’icona e un perno del populismo di destra, che ha trionfato in Gran Bretagna con Boris Johnson, in Brasile con Jair Bolsonaro e ha avuto un punto di riferimento politico-ideologico nel suprematista bianco Steve Bannon, ripetutamente omaggiato anche dai leader della destra italiana, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Certo, il consenso di cui godeva Trump è stato non poco eroso dalla sua scellerata gestione della pandemia da covid-19 esplosa nei primi mesi del 2020. Eppure “The Donald” ha saputo risalire la china, ottenendo nel novembre di quell’anno molti più voti del 2016, anche se ciò non gli è bastato per rimanere alla Casa Bianca. Forse pochi ricordano che, già in occasione della sfida con Hillary Clinton, aveva manifestato il proposito di non voler riconoscere la vittoria del proprio avversario.
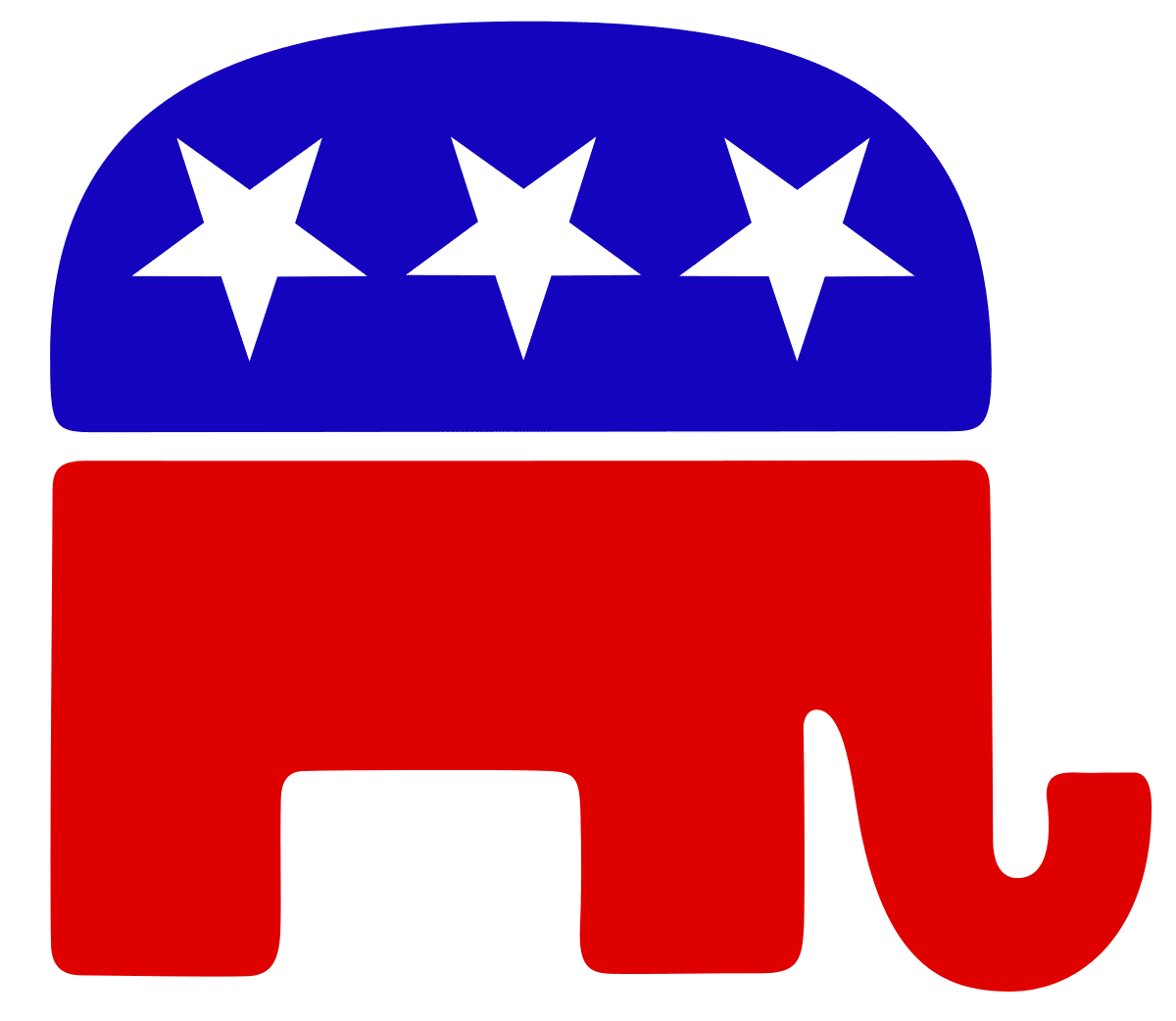
Comunque, la mancata rielezione alla presidenza degli Stati Uniti e il fallimentare tentativo di golpe dell’epifania 2021 non hanno decretato l’uscita di scena di Trump, intenzionato a ricandidarsi nel 2024, pronto ad approfittare delle difficoltà cui sta andando incontro l’amministrazione Biden e a egemonizzare il Partito repubblicano, portandone a termine il processo di ricollocazione a destra, avviato negli anni Novanta da Newt Gingrich e proseguito in qualche modo da Sarah Palin del Tea Party.

Tuttavia, l’inedita, vasta mobilitazione a favore del socialista Bernie Sanders in ben due importanti campagne presidenziali e la combattività mostrata da un gruppo di deputate democratiche, tra cui la radicale Alexandria Ocasio-Cortez, rendono meno fosco il quadro politico statunitense, su cui incombono gravi incognite, destinate inevitabilmente a ricadere sul resto del mondo.
Francesco Soverina, storico dell’Età contemporanea, componente comitato provinciale Anpi Napoli
Pubblicato venerdì 7 Gennaio 2022
Stampato il 19/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/capitol-hill-londa-nera-un-anno-dopo/







