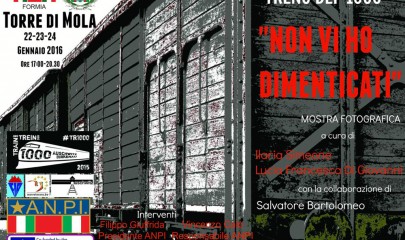«Sorprende sentir dire, ancora oggi, da qualche parte, che il fascismo ebbe alcuni meriti, ma fece due gravi errori: le leggi razziali e l’entrata in guerra. Si tratta di un’affermazione gravemente sbagliata e inaccettabile, da respingere con determinazione. Perché razzismo e guerra non furono deviazioni o episodi rispetto al suo modo di pensare, ma diretta e inevitabile conseguenza. Volontà di dominio e di conquista, esaltazione della violenza, retorica bellicistica, sopraffazione e autoritarismo, supremazia razziale, intervento in guerra contro uno schieramento che sembrava prossimo alla sconfitta, furono diverse facce dello stesso prisma».
Occorre essere grati al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per queste parole, che sintetizzano il significato del discorso teso e appassionato pronunciato in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria, a pochi giorni dalla nomina di Liliana Segre a senatrice a vita: con questi atti, il Capo dello Stato ha esemplarmente esercitato la sua funzione di supremo rappresentante dell’unità nazionale e di custode e garante dei valori della Costituzione, richiamando tutti i cittadini al dovere morale della memoria e al dovere di “respingere con determinazione”, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’emanazione delle leggi razziali, le banalizzazioni auto assolutorie sul fascismo come “dittatura mite”, che hanno popolato e continuano a popolare alcune ricostruzioni pseudo storiche e, soprattutto, i discorsi di alcuni leader politici, particolarmente abili nell’arte di ricavare vantaggiosi dividendi elettorali da un’irresponsabile ostentazione di qualunquismo, razzismo e sessismo.
Può sembrare un paradosso, ma è così: a fronte della palese e ingiustificabile infamia costituita dalle le leggi razziali e della evidente consequenzialità logica e storica del nesso tra discriminazione, persecuzione e sterminio degli ebrei, nel corso degli anni sono state divulgate con un certo successo letture tranquillizzanti del razzismo fascista, che hanno distorto apertamente la verità, e, blandendo il mai sopito desiderio degli italiani di aggirare il fastidioso dovere civile di ricordare, hanno accreditato l’idea che le leggi razziali siano state un “errore” imputabile al solo Mussolini, che le misure persecutorie siano state adottate per compiacere il più potente alleato tedesco e che siano state applicate in modo blando da un regime che, fino a quel momento, si era manifestato nella forma di un autoritarismo bonario che mandava, come ricordava alcuni anni or sono un Presidente del Consiglio, gli oppositori a “villeggiare” al confino.

Questa sistematica e diffusa falsificazione del passato – amplificate con solerzia dai media e via web, come ogni fake news che si rispetti – si è progressivamente sovrapposta alla semplice, piana, documentata verità storica, producendo conseguenze deleterie, prolungatesi fino nel cuore del nostro presente: perché se si afferma l’idea di un razzismo all’italiana sostanzialmente innocuo già ottant’anni or sono, si finisce per legittimare, o quanto meno per tollerare, chi pensa che sia lecito oggi fare campagna elettorale presentandosi come protettore della “razza bianca”, e che si possano riproporre senza particolari remore le stesse fandonie di allora, agitando, per alimentare la paura e l’odio contro immigrati e rifugiati, il vessillo della sostituzione etnica, traduzione padana della difesa della “pura razza italiana”, indicata nel 1938 dal Gran Consiglio del fascismo come primario dovere del regime. Le conseguenze si sono viste a Macerata, alcuni giorni or sono.
In realtà, il fascismo coltivò sin dalle sue origini i germi del razzismo come elemento costitutivo di un’ideologia fondata sull’esaltazione della gerarchia, sul primato della forza e sulla repressione della diversità, oltre che del dissenso politico; un razzismo che si sarebbe pienamente dispiegato a metà degli anni Trenta, con l’aggressione all’Etiopia, quando, il regime, ispirato dal suo capo, si impegnò a fondo affinché una “mentalità imperiale” si radicasse nel popolo italiano, e ne plasmasse il carattere. Con affermazioni di questo tipo, si apriva la Dichiarazione sulla razza adottata il 6 agosto 1938 dal Gran Consiglio del fascismo: vi si richiamava “l’attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale” e del rafforzamento delle “misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell’Impero”. Precisato il quadro generale, l’organo di vertice del regime passava dall’Africa al territorio metropolitano e si dedicava a una puntigliosa definizione dei criteri per l’individuazione dei “cittadini italiani di razza ebraica” e delle regole restrittive da adottare in materia matrimoniale, per vietare le unioni “miste”. Non era peraltro la prima volta che l’argomento veniva affrontato. Già prima della “dichiarazione” era in vigore una legge con un contenuto esplicitamente razzista: si trattava del Regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 880, nel quale si punivano con la reclusione fino a cinque anni le “relazioni di indole coniugale” (definite “madamato” dalla stampa del regime) tra cittadini italiani (ovviamente al maschile) e persone suddite dell’Africa Orientale italiana. Il Gran Consiglio si era spinto oltre, esplicitando l’intenzione di vietare non solo le “relazioni di indole coniugale” ma anche le unioni legali cosiddette “miste”, fino a quel momento escluse dalla disciplina razzista per tenere conto delle riserve espresse dal Vaticano, che eccepiva l’inderogabilità delle disposizioni concordatarie in materia matrimoniale.

Le disposizioni adottate all’indomani dell’aggressione all’Etiopia attestano dunque la crescente attenzione del regime verso le politiche di segregazione e persecuzione razziale: dopo la proclamazione dell’impero, l’adozione del citato decreto n. 880 era stata accompagnata da un’intensa campagna contro il “meticciato” nel quale una pubblicazione ufficiale individuava “una categoria di individui biologicamente tarati e socialmente pericolosi, destinati a divenire dei reietti, degli spostati o dei ribelli”; a ciò vanno aggiunti i coevi decreti dei governatori delle singole colonie, che vietavano agli italiani di frequentare i quartieri e gli esercizi pubblici indigeni, e ponevano i presupposti di un vero e proprio apartheid all’italiana.
Si è sostenuto in passato che la virata razzista del regime dovesse essere attribuita soprattutto all’avvicinamento dell’Italia alla Germania dopo la guerra contro l’Etiopia e le sanzioni: in realtà, tale avvicinamento non ebbe alcun ruolo specifico nella decisione di Mussolini di varare la politica razzista, che, in quanto tale, fu una scelta maturata in autonomia, anche se indubbiamente il dittatore, nelle sue visite in Germania, ebbe modo di verificare di persona l’efficacia del razzismo, e in particolare dell’antisemitismo, come veicolo di consenso e come strumento di mobilitazione e unificazione totalitaria della società.
Anche da qui, e dall’ossessiva volontà di radicare la cultura della violenza e dell’intolleranza nella società italiana, deriva l’impegno diretto che il duce profuse nella messa a punto della politica razziale, dettando di persona i principi del cosiddetto Manifesto della razza, redatto poi da un giovane antropologo, Guido Landra, e pubblicato il 15 luglio 1938.
 Mussolini stesso, peraltro, volle ammantare la prima sortita pubblica dell’antisemitismo fascista con un velo di obiettività, facendo sottoscrivere il Manifesto non da un organismo politico ma da dieci sedicenti “scienziati”, che peraltro non ebbero alcun ritegno a prestarsi all’intera operazione, senza fare valere, se non privatamente, le riserve che pure alcuni di loro avevano manifestato per la palese inconsistenza e contraddittorietà del testo. Il Manifesto sosteneva, tra l’altro, l’origine ariana della popolazione italiana, l’esistenza di una “pura razza” italiana, la non appartenenza ad essa degli ebrei e il dovere di non alterare in alcun modo “i caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani”, per concludere apoditticamente: “È tempo che gli italiani si dichiarino francamente razzisti”. I dieci firmatari erano: Lino Businco (medico); Lidio Cipriani (antropologo); Arturo Donaggio (psichiatra); Leone Franzi (pediatra); Guido Landra (antropologo); Nicola Pende (medico); Marcello Ricci (zoologo); Franco Savorgnan (demografo); Sabato Visco (medico); Edoardo Zavattari (zoologo). Alla loro biografie dedicheremo un prossimo articolo.
Mussolini stesso, peraltro, volle ammantare la prima sortita pubblica dell’antisemitismo fascista con un velo di obiettività, facendo sottoscrivere il Manifesto non da un organismo politico ma da dieci sedicenti “scienziati”, che peraltro non ebbero alcun ritegno a prestarsi all’intera operazione, senza fare valere, se non privatamente, le riserve che pure alcuni di loro avevano manifestato per la palese inconsistenza e contraddittorietà del testo. Il Manifesto sosteneva, tra l’altro, l’origine ariana della popolazione italiana, l’esistenza di una “pura razza” italiana, la non appartenenza ad essa degli ebrei e il dovere di non alterare in alcun modo “i caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani”, per concludere apoditticamente: “È tempo che gli italiani si dichiarino francamente razzisti”. I dieci firmatari erano: Lino Businco (medico); Lidio Cipriani (antropologo); Arturo Donaggio (psichiatra); Leone Franzi (pediatra); Guido Landra (antropologo); Nicola Pende (medico); Marcello Ricci (zoologo); Franco Savorgnan (demografo); Sabato Visco (medico); Edoardo Zavattari (zoologo). Alla loro biografie dedicheremo un prossimo articolo.
Il Manifesto e la Dichiarazione del Gran Consiglio del Fascismo fornirono dunque i presupposti “teorici” all’adozione delle leggi razziste del 1938. Nel dare conto del loro contenuto, occorre precisare preliminarmente che esse costituiscono la punta dell’iceberg di un nutrito corpo di disposizioni regolamentari, circolari, direttive, oltre che di leggi adottate successivamente, fino agli ultimi mesi della guerra fascista, che, da sole, testimoniano dell’impegno e della solerzia con cui, in tutti i rami dell’amministrazione, si diede attuazione alle regole della persecuzione. Una prova generale di tale impegno era stata data in agosto, con il censimento dei “cittadini italiani di razza ebraica”, che, oltre a rappresentare la prima forma di discriminazione, avrebbe anche costituito, nel biennio 43-45, un efficace strumento utilizzato dai fascisti di Salò e dai nazisti per la cattura e la deportazione degli ebrei.
La legislazione razzista si concretizzò in una rete di divieti e di esclusioni che vanificarono il principio dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, creando una cittadinanza di serie B per una comunità che, anche per la sua esiguità numerica (il censimento razzista dell’agosto 138 aveva portato a individuare 58.412 “cittadini di razza ebraica”, poco più dell’1 per mille della popolazione totale), si prestava perfettamente alla realizzazione del progetto totalitario di creare nel Paese un clima di mobilitazione, discriminazione e persecuzione contro una minoranza inerme. Si iniziò con la scuola, a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del Manifesto: con il RDL 5 settembre 1938, n. 1390, venivano allontanati da tutti gli istituti di istruzione gli insegnati ebrei e coloro che vi esercitavano funzioni direttive e ispettive, poi definitivamente esclusi con il RDL 15 novembre 1938, n. 1179; veniva decretata l’espulsione e proibita l’iscrizione di ragazze e ragazzi di religione israelitica nelle scuole di ogni ordine e grado e si procedeva all’epurazione delle Accademie e degli istituti di cultura: decine di studiosi, alcuni dei quali di fama mondiale, dovettero abbandonare i loro incarichi accademici, prontamente occupati dai loro interessati persecutori.
Due giorni dopo l’emanazione delle disposizioni sulla scuola, il RDL 7 settembre 1938, n. 1381 vietava agli “stranieri ebrei” (molti dei quali in fuga dalla persecuzione nella Germania hitleriana) di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nelle isole dell’Egeo; revocava “le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919” e imponeva a chi vi avesse soggiornato dopo tale data, di lasciare il territorio del Regno, della Libia e delle isole dell’Egeo, entro sei mesi, a pena di espulsione.
Con il RDL 15 novembre 1938, n. 1728, “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”, venivano collocate le ultime pietre angolari della costruzione razzista del regime: la prima parte del decreto disciplinava il divieto dei matrimoni “misti” secondo i criteri definiti dal Gran Consiglio del fascismo e dettava i criteri per l’individuazione degli “appartenenti alla razza ebraica”; la seconda elencava divieti e restrizioni ad essi imposti. In particolare, era vietato: prestare servizio militare; essere tutori o curatori di persone non ebree; possedere o gestire aziende interessate alla difesa nazionale, nonché aziende di qualsiasi tipo con più di 100 dipendenti; possedere terreni o immobili al di sopra di un certo valore catastale (una norma successiva sanzionava la spoliazione legale dei beni eccedenti tali limiti con l’istituzione dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare, incaricato della vendita coatta dei beni predetti); avere personale domestico di “razza ariana”. Inoltre, non potevano avere dipendenti “di razza ebraica” le pubbliche amministrazioni e le aziende ad esse collegate; il Partito fascista (che peraltro provvide immediatamente a espellere i circa 6.900 ebrei iscritti) e gli enti collegati; le banche di interesse nazionale; le imprese private di assicurazione.
La fertile inventiva dei legislatori fascisti diede vita a una categoria intermedia, quella dei “discriminati”: contrariamente al Partito nazionalsocialista tedesco, antisemita sin dalle origini, il fascismo, al potere da 16 anni, aveva avuto molti ebrei iscritti al PNF e alcuni di essi, come Guido Jung, ministro delle Finanze dal 1932 al 1935, erano stati titolari di importanti cariche pubbliche. Pertanto, il RDL n. 1728 disponeva che non fossero sottoposti ad alcune delle restrizioni previste dalla legge, fermo restando l’esclusione dalle pubbliche amministrazioni, i “cittadini italiani di razza ebraica” che potessero vantare benemerenze belliche o politiche (la iscrizione al PNF prima della marcia su Roma o nel secondo semestre del 1924, cioè subito dopo il delitto Matteotti) o altri meriti da sottoporre al vaglio di una commissione ministeriale; una deroga che servì a burocrati e gerarchi per fare mercimonio di “benemerenze” e che si andò progressivamente ridimensionando con il consolidamento e l’estensione della politica razzista dopo il 1938.

Nessuno dei soggetti che avrebbero potuto farlo legalmente si oppose all’avvio della persecuzione: non lo fece il sovrano, che firmò le leggi del 1938 e quelle successive senza alcuna particolare obiezione, malgrado la tradizionale devozione che i cittadini italiani di religione israelitica nutrivano verso la casata che rappresentava la fine delle discriminazioni antiebraiche successivamente all’unificazione; non si oppose il Vaticano, dove l’opposizione dell’anziano e malato Pio XI alla politica razzista del regime fu sopravanzata dalla presenza di una forte componente antisemitica, nella quale si iscrivevano, tra gli altri, due autorevoli esponenti della cultura cattolica come padre Tacchi Venturi, attivo intermediario tra la Chiesa e il regime, e padre Agostino Gemelli, entrambi tra i numerosi sottoscrittori del Manifesto della razza.
Con il 1938 la persecuzione ebbe dunque inizio ma non raggiunse certo l’apice; altre norme restrittive si aggiunsero nel corso degli anni, altri apparati amministrativi e propagandistici furono creati per darvi attuazione, e non pochi funzionari, “scienziati” e divulgatori si impegnarono per dare più solide basi all’antisemitismo di regime: così che, dopo l’8 settembre 1943, costituitosi lo stato fantoccio di Salò, il passaggio dalla persecuzione all’eliminazione fisica apparve quasi naturale agli uomini di governo e ai militari repubblichini, che coadiuvarono con solerzia i nazisti nella deportazione e nello sterminio.
Pubblicato giovedì 22 Febbraio 2018
Stampato il 17/01/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/nascita-avvento-del-razzismo-fascista/