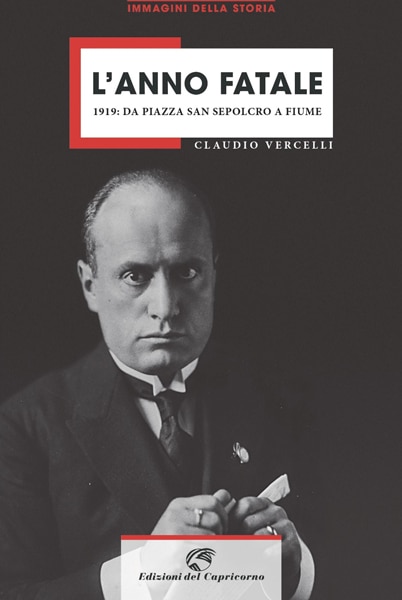A un secolo di distanza dal Biennio rosso, la grande mobilitazione operaia e contadina del 1919-20 conserva ancora un significato, che parla ai lavoratori e alle lavoratrici dei nostri giorni.
La società italiana, come quelle di molti altri Paesi, era da poco uscita dall’immane massacro della Prima guerra mondiale, che con la sua mobilitazione totale aveva gettato masse enormi sulla scena della storia, chiamandole a giganteschi sacrifici e causando una altrettanto gigantesca perdita di vite umane. All’indomani del conflitto, lavoratori e lavoratrici pretendevano di avere anche in tempo di pace quel ruolo determinante di cui, obtorto collo, avevano dovuto farsi carico al fronte o nelle retrovie.

La Rivoluzione d’Ottobre, dal canto suo, aveva acceso nuove speranze. Rovesciare le classi dominanti e conquistare il potere da parte di operai e contadini appariva ora possibile. D’altra parte, anche in Italia gli anni di guerra avevano visto moti popolari ed esplosioni di protesta, a partire dalla rivolta per il pane scoppiata a Torino nell’agosto 1917.
La guerra aveva comportato una intensa mobilitazione produttiva e una crescente concentrazione industriale. Nel 1918, nella sola Torino, gli operai erano arrivati a costituire il 30% della popolazione: un esercito di 150.000 persone, con una presenza di donne giunta al 35%; la sola Fiat occupava ormai 40.000 operai [1]. Nel novembre di quell’anno, all’indomani dell’armistizio, mentre in Germania scoppia la rivoluzione spartachista, nel capoluogo piemontese le manifestazioni dei lavoratori sono represse dalla forza pubblica; ne segue uno sciopero generale con le parole d’ordine “Giù le mani dalla Russia! Amnistia generale” [2].

Il 1919 inizia con una serie di mobilitazioni per ridurre l’orario di lavoro quotidiano a 8 ore. I primi accordi in tal senso arrivano proprio nelle fabbriche di automobili torinesi; a marzo la conquista, di portata storica, assume una dimensione nazionale. Al tempo stesso, un concordato tra industriali e Fiom riconosce il ruolo delle commissioni interne che gli operai hanno costituito nelle fabbriche. La forza di Confederazione generale del lavoro e Partito socialista cresce a vista d’occhio: nella sola Torino l’Avanti vende circa 50.000 copie, mentre quattro giovani socialisti – Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Angelo Tasca e Umberto Terracini – danno vita alla rivista L’Ordine Nuovo, che già nel titolo allude alla prospettiva di una trasformazione radicale [3].
 Così Paolo Spriano descriverà quei mesi: “L’aprile del 1919. La voglia di fare. La sensazione dell’imminenza di un cataclisma. […] Sono la classe operaia e gran parte delle masse contadine della penisola, a vivere profondamente più che la speranza, la certezza di un arrovesciamento imminente, ad avvertirne l’avvicinarsi sia dai clamori di una rivoluzione che da Pietroburgo pare espandersi per tutta l’Europa […] sia dall’impulso che parte dalle fabbriche e dai campi italiani per un nuovo potere operaio e contadino” [4].
Così Paolo Spriano descriverà quei mesi: “L’aprile del 1919. La voglia di fare. La sensazione dell’imminenza di un cataclisma. […] Sono la classe operaia e gran parte delle masse contadine della penisola, a vivere profondamente più che la speranza, la certezza di un arrovesciamento imminente, ad avvertirne l’avvicinarsi sia dai clamori di una rivoluzione che da Pietroburgo pare espandersi per tutta l’Europa […] sia dall’impulso che parte dalle fabbriche e dai campi italiani per un nuovo potere operaio e contadino” [4].
A luglio la mobilitazione contro il caroviveri vede il sorgere di comitati per il controllo dei prezzi; in varie località la distribuzione delle derrate alimentari è presa in carico dalle Camere del lavoro.

Lo sciopero generale – organizzato in comune coi sindacati francesi e inglesi contro l’intervento militare a danno di Russia e Ungheria rivoluzionarie – fa temere alle classi dominanti un esito insurrezionale; il governo Nitti fa appello ai “partiti d’ordine” nei quali include i neonati Fasci di combattimento: nonostante il programma socialisteggiante, la collocazione di classe anti-proletaria del movimento di Mussolini è dunque ben definita [5]. Del resto, già poche settimane prima, l’incendio della sede milanese dell’Avanti! ad opera dei fascisti ha sciolto ogni possibile equivoco.
Intanto, su impulso del gruppo dell’Ordine Nuovo, a Torino si cerca di impostare il ruolo delle commissioni interne come “futuri organi del potere proletario” e “scuola di esperienza politica e amministrativa”. L’elezione di “commissari di reparto”, che vadano a costituire il consiglio di fabbrica, rappresentante di tutti i lavoratori (anche di quelli non sindacalizzati) è l’“idea-forza della rivista”.

È necessario – scrive Gramsci nell’articolo “Democrazia operaia” – che la rivoluzione “si incorpori in un potere già esistente”. Gli fa eco Togliatti: gli operai devono “impadronirsi del meccanismo dell’azienda per prepararsi a dirigerla”, creando “un sistema di fiduciari, di commissione […] di reparto e di squadra”. Quello che si delinea è dunque un sistema piramidale, simile a quello dei soviet russi, e a fine ottobre una prima riunione dei comitati esecutivi dei consigli di fabbrica vede riuniti i rappresentanti di oltre 30.000 operai [6]. A essere posto è insomma il problema del potere, di un potere nuovo, creato dai lavoratori a partire dai luoghi della produzione. Per la prima volta, osserva ancora Spriano, essi si sentono “soggetti e non oggetti del loro destino”; un cambiamento radicale appare finalmente possibile, e ciò fa crescere quello che l’Ordine Nuovo definisce “il senso della responsabilità rivoluzionaria” [7].
In ottobre il congresso di Bologna del Psi vede prevalere la sinistra massimalista, ma di fatto nessuna preparazione concreta per un esito rivoluzionario viene avviata. Le elezioni che si tengono a novembre, le prime col sistema proporzionale, rendono il Psi il primo partito italiano, con oltre il 32% dei voti, seguito dal Partito popolare, la cui affermazione segna l’ingresso definitivo delle masse cattoliche sulla scena politica.
La mobilitazione operaia però non si ferma. Nella sola Fiat Centro di Torino, tra l’ottobre 1919 e il marzo 1920 sono oltre 800 le vertenze guidate dai commissari di reparto: la mezza giornata lavorativa il sabato, la gestione del cottimo, i ritmi di lavoro sono i punti ricorrenti, che Stefano Musso riconduce “a un’unica dimensione: il desiderio degli operai di ampliare il tempo libero dal lavoro, da spendere fuori dello stabilimento ma anche dentro la fabbrica, nella socialità delle pause”, soprattutto a fronte di quel diffondersi dei nuovi sistemi di cottimo, ossia dei metodi tayloristici, che è stata la contropartita ottenuta dal padronato per la giornata di otto ore. Sullo sfondo c’è sempre la questione del controllo del processo produttivo, che è poi il controllo sul/del lavoratore, e dunque ancora una volta, la questione del potere: l’unica su cui gli imprenditori non sono disposti a transigere [8].

Il 1920 vede l’ulteriore estendersi della mobilitazione. A Milano il 1° maggio scioperano anche ferrovieri, postelegrafonici e tranvieri; la banda dei pompieri intona “Bandiera Rossa”, e l’impressione è quella di completo controllo della città da parte dei lavoratori [9]. A Napoli, due mesi prima, vi è stato uno sciopero generale contro i licenziamenti, col tentativo di occupazione degli stabilimenti Miani & Silvestri represso nel sangue dalla guardia regia, seguito da uno sciopero di 64 giorni alle Manifatture Cotoniere Meridionali [10].
A Torino invece, operaie e operai hanno occupato per quasi quattro mesi i Cotonifici Mazzonis; intanto le elezioni delle commissioni interne hanno portato alla costituzione di un loro commissariato centrale, mentre l’Ordine Nuovo lancia l’idea di un congresso nazionale dei consigli di fabbrica.

Ma soprattutto, a partire dal 28 marzo, è iniziato quello “sciopero delle lancette” che rappresenta un momento emblematico dell’intero biennio. La lotta era iniziata per un motivo apparentemente secondario – l’adeguamento dell’orario di lavoro all’ora legale appena istituita, rifiutato dal padronato, ciò a cui gli operai avevano reagito spostando le lancette dell’orologio della fabbrica: ne era seguito il licenziamento di tre lavoratori, componenti della commissione interna, e dunque uno sciopero che dura un mese circa, dilagando in tutto il Piemonte, affiancandosi all’agitazione dei braccianti e coinvolgendo complessivamente mezzo milione di salariati. La “posta in gioco” è sempre la stessa: “la legittimità del consiglio di fabbrica, e in prospettiva il controllo operaio sulla produzione”.
Dinanzi allo sciopero, i padroni attuano la serrata, e per riaprire le fabbriche pretendono la rinuncia al nuovo sistema di elezione delle commissioni interne: è questo che fa scattare lo sciopero generale nel capoluogo piemontese. La vertenza si chiude a fine aprile, con un compromesso che lascia immutato il nuovo sistema elettorale ma ristabilisce l’autorità dell’impresa nelle officine [11].
Diffidenze e responsabilità dei vertici di Partito socialista e sindacato e isolamento della classe operaia torinese sono già ora evidenti. Ricorderà Terracini, che assieme a Tasca e Boero cercò invano la solidarietà di Psi e Cgdl nella seduta comune dei rispettivi consigli generali che si tenne a Milano: lo sciopero delle lancette e la mobilitazione di quei mesi “investivano un grosso problema politico di classe, il potere nella fabbrica. Non averlo compreso fu la colpa delle dirigenze delle grandi organizzazioni unitarie dei lavoratori” [12]. E non a caso anche da quelle vicende prenderà le mosse la scissione di Livorno che darà vita nel gennaio 1921 al Partito comunista.

Prima di questa, vi sono però gli ultimi drammatici episodi del Biennio rosso. Il primo è la rivolta dei bersaglieri, che scoppia ad Ancona a giugno, a seguito del rifiuto di un gruppo di soldati di partire per l’Albania, occupata dall’esercito italiano. La rivolta trova un sostegno di massa nella popolazione, anche grazie alla tradizione anarchica, repubblicana e socialista della città, diffondendosi poi in diversi centri delle Marche, per essere infine repressa dall’esercito [13].
Il secondo, decisivo episodio, è l’occupazione delle fabbriche che avviene a settembre. La causa scatenante è la nuova ondata di rincari di generi essenziali che colpisce duramente gli operai. Alla richiesta di un adeguamento salariale avanzata a livello nazionale dai sindacati dei metallurgici, gli industriali non solo rispondono negativamente ma, per iniziativa del loro capo-delegazione, il nazionalista e poi fascista Rutigliano, rompono ogni trattativa.
La Fiom reagisce decretando l’ostruzionismo, ossia il rallentamento della produzione, nelle fabbriche e nei cantieri navali; in caso di serrata da parte del padronato – afferma il segretario generale Bruno Buozzi – si procederà all’occupazione degli impianti. È una linea a cui si acconciano anche gli anarchici dell’Unione sindacale italiana, e poiché la serrata viene effettivamente attuata dagli industriali, già il 30 agosto la Fiom di Milano, sostenuta dai vertici nazionali, ordina ai propri iscritti di prendere possesso delle fabbriche. Nei primi giorni di settembre l’occupazione degli impianti si estende a tutto il Paese, fatta eccezione per la Venezia Giulia che comunque vede lo sciopero generale dei lavoratori triestini. Alla Fiat di Torino tutti i poteri sono assunti dal consiglio di fabbrica e l’ordine pubblico nei pressi degli stabilimenti è garantito dalle “guardie rosse” [14].
Ricorderà Antonio Roasio: “Ogni fabbrica era una repubblica a sé, anche se non si mancava di stabilire contatti con quelle vicine per coordinare la nostra difesa […]. La combattività era alle stelle […]. Per circa un mese più di 600 fabbriche che occupavano un milione di lavoratori divennero la fortezza del movimento operaio italiano. […] gli operai dimostravano per la prima volta che era possibile […] assicurare la produzione e la disciplina anche senza il padrone.
I limiti di quella lotta ci apparvero dopo alcuni giorni: eravamo isolati […]. Anche se nel paese erano notevoli la simpatia popolare e la solidarietà delle altre categorie, ci sentivamo soli, chiusi nelle nostre fortezze [15]”.
Gli “aspetti rivoluzionari” della mobilitazione sono evidenti, e tuttavia la riunione nazionale di Psi e Cgdl, che si tiene alla metà del mese, vede prevalere la mozione riformista: la lotta viene letta in termini esclusivamente sindacali e indirizzata verso obiettivi meramente rivendicativi, ossia verso un accordo che prevederà aumenti salariali e l’impegno a discutere in Parlamento una proposta di legge sul controllo operaio, che non sarà mai presentata. La tattica attendista di Giolitti, che mira a logorare il movimento e a prepararne il riflusso, si rivelerà dunque vincente [16]. Certo, la Cgdl giunge nel 1920 a 2.300.000 iscritti; e tuttavia il biennio si chiude con una sconfitta, la quale apre le porte alla violenta controffensiva fascista, quella “tremenda reazione” che Gramsci paventava se l’ipotesi rivoluzionaria non si fosse affermata [17] .
Alexander Hobel, Università di Napoli “Federico II”
[1] S. Musso, Biennio rosso e autunno caldo a Torino: i conflitti sociali nella città fabbrica, in I due bienni rossi del Novecento: 1919-20 e 1968-69, Roma, Ediesse, 2006, pp. 276-277.
[2] P. Robotti, Scelto dalla vita, Roma, Napoleone, 1980, p. 62.
[3] P. Spriano, “L’Ordine Nuovo” e i Consigli di fabbrica, Torino, Einaudi, 1971, pp. 16-18.
[4] Ivi, p. 14.
[5] A. Roasio, Figlio della classe operaia, Milano, Vangelista, 1977, pp. 19-21; R. Vivarelli, Storia delle origini del fascismo, vol. I, Bologna, il Mulino, 2012, p. 623.
[6] Spriano, “L’Ordine Nuovo” e i Consigli di fabbrica, cit., pp. 46-54.
[7] Ivi, p. 83.
[8] Musso, Biennio rosso e autunno caldo a Torino, cit., pp. 283-284.
[9] A. Riosa, Il caso di Milano: simboli e liturgie operaie nei due bienni, in I due bienni rossi del Novecento, cit., p. 298.
[10] G. Chianese, Il caso di Napoli nei due bienni, ivi, p. 266.
[11] Spriano, “L’Ordine Nuovo” e i Consigli di fabbrica, cit., pp. 93-100.
[12] U. Terracini, Intervista sul comunismo difficile, a cura di A. Gismondi, Roma-Bari, Latera, 1978, pp. 16-17.
[13] R. Giacomini, La rivolta dei bersaglieri e le Giornate Rosse. I moti di Ancona dell’estate del 1920 e l’indipendenza dell’Albania, Ancona, Assemblea legislativa delle Marche, 2010.
[14] P. Spriano, L’occupazione delle fabbriche. Settembre 1920, Torino, Einaudi, 1964, pp. 42-45, 54, 63-69.
[15] Roasio, Figlio della classe operaia, cit., p. 25.
[16] Ivi, pp. 26-27.
[17] Per un rinnovamento del Partito socialista, in “L’Ordine Nuovo”, 8 maggio 1920.
Pubblicato domenica 29 Marzo 2020
Stampato il 13/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/longform/un-secolo-dopo-il-biennio-rosso/