
“Il berlusconismo appare […] sempre di più, in una maniera che si potrebbe dire orgiastica, il nome che la democrazia deformata ha assunto in Italia. […] Qual è l’aspetto della vicenda che mostra il punto di non ritorno a cui è arrivata la politica italiana? Semplicemente questo: la soglia della sessualizzazione del dibattito pubblico […] ma senza che ciò produca gli effetti che si hanno altrove. Al contrario: non soltanto l’uomo pubblico in questione non è spinto alle dimissioni, ma le rilevazioni in un certo senso lo rafforzano perché ne mostrano, una volta di più. l’inossidabilità, la ‘faccia tosta’ che tanto piace ai suoi sostenitori. È il ‘me ne frego’ riproposto nelle mutate condizioni agli italiani” (Rino Genovese, filosofo, 2011).

Di chi stiamo quindi concretamente parlando? Di un solo uomo o, piuttosto, di qualcosa d’altro? Troppo facile, a tale riguardo, liquidare il primo con poche parole di circostanza. Se si fosse trattato di un fenomeno temporaneo, allora potremmo da subito andare oltre, pensando al tempo a venire e archiviando tutto il resto. Mentre invece il berlusconismo, ideologia dominante dell’età che viviamo, in assenza del suo medesimo protagonista e demiurgo, ossia lo stesso Silvio Berlusconi – morto nel mentre – sarà a lungo lo spirito comune, quello che dovremo comunque condividere, e con il quale confrontarci, di qui in avanti. Che ci piaccia o meno. Soprattutto nel secondo caso, si intende.

Beninteso: esegeti, apologeti come anche nipoti e pronipoti, si riferiranno alla sua persona con quella dovuta obbedienza che si conviene solo per un calcolo di ipocrita circostanza. Quello che deriva dalla lotta per il suo patrimonio, la sua eredità, la rendita legata alla sua mortale figura, cristallizzata da subito in una sorta di icona pagana. Al pari delle immagini di certi dittatori (Berlusconi non lo è stato, ma ne ha carpito alcuni tratti di natura essenzialmente simbolica), dove quel che conta non è mai ciò che per davvero essi furono ma l’impronta che di se stessi, e del loro “regno”, sono riusciti a lasciare tra quelle collettività con le quali hanno interagito nel tempo. Mussolini e Berlusconi sono interfacciati non perché omologhi bensì in quanto capaci di capire quali fossero, nei loro rispettivi tempi di vita, le emozioni, le insoddisfazioni, gli irrisolti desideri – come anche le velleità – di una Italia in crisi di identità. Vellicando e istigando il tutto, salvo poi rivelare, a cose compiute, che dietro l’impalcatura che avevano costruito a proprio beneficio, c’era solo un esclusivo tornaconto personale.

Non a caso, quindi, figli e figliocci avevano già superato nei fatti Berlusconi, ben prima della sua dipartita, pur beneficiando appieno di tutti gli “sdoganamenti” di cui è stato protagonista, dall’inizio degli anni Novanta in poi. Forse, quando faremo i conti con lui una volta per sempre, dovremo riconoscere che importa più quello è riuscito a concedere agli “altri” (neofascisti, destra reazionaria, qualunquisti e così via) di quanto abbia raccolto per sé. Se ha salvato e ingrassato le sue aziende, ha tuttavia permesso alla destra illiberale di legittimarsi come soggetto di governo per i tempi a venire. Si soppesino le cose e si giudichi di conseguenza: la politica è stata completamente assorbita dentro la cornice populista di cui, al netto della Lega Nord, altrimenti ancora legata ad un insediamento perlopiù regionale, avrebbe avuto scarse opportunità di espansione e definitivo consolidamento. Nel 1993 un Silvio Berlusconi in serie difficoltà, dinanzi al combinato disposto tra la crisi delle sue aziende e la consapevolezza che il padrinaggio politico di cui aveva usufruito nel tempo, si era completamente liquefatto, assunse su di sé l’onere di autorappresentarsi. Simulando che gli interessi suoi propri potessero corrispondere appieno con quelli degli italiani.

Ma tutto ciò, da solo, non riveste un’esclusiva e definitiva importanza dinanzi a quello che rimane, invece, un fenomeno altrimenti epocale, destinato quindi a sopravvive al suo stesso demiurgo. Poiché oggi si è “di destra”, intesa come quella illiberale e post-costituzionale, anche per quanto si è appena raccontato. Poiché conta non tanto ciò in cui ci si identifica (molto spesso mitologie di circostanza, passioni occasionali, infatuazioni transitorie) bensì in certe costruzioni ideologiche cristallizzate, ovvero quelle condizioni mentali – prima ancora che politiche – per le quali si copre, come si fa con il tappeto sotto il quale si nasconde la cenere, il proprio brutale calcolo d’interessi. Era già successo con il mussolinismo. Si è ripetuto con Silvio Berlusconi. Salvo, si intende, le dovute differenze storiche. Che non sono poche.

In Italia è berlusconismo quella persistente “ideologia della fine delle ideologie” che, predicando la non essenzialità di una cultura politica di riferimento, di fatto cementifica il blocco di potere del quale ne è a modo suo garante nonché – anche e soprattutto – immediato beneficiario. Capiamoci, quindi: il berlusconismo, da almeno trent’anni, coniuga populismo (l’appello a un popolo indistinto, inteso come improbabile protagonista del suo tempo) al cinismo, in quanto atteggiamento prevalente nei pensieri dei singoli individui (nulla conta se non il proprio interesse personale, inteso come una sorta di assoluto, di contro al disprezzo verso gli “altri”), al liberismo economico (bando ad ogni forma di mediazione e intermediazione, quindi di condivisione e solidarismo; spazio alla creatura immaginaria che porta il nome di mercato, l’unica, autentica organizzazione collettiva, quella in cui ognuno conta comunque per sé) nonché all’avversione individualista per ogni sistema di regole. Soprattutto quelle che tutelano i diritti della parte più fragile della società, quella che nei fatti rimane sempre e comunque maggioritaria. È come se il Cavaliere avesse detto che il secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione (“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”), costituisse una panzana.

Abilmente, Silvio Berlusconi ha saputo separare la dimensione individuale e liberale della Costituzione (ogni individuo è titolare di diritti inalienabili, che sorgono nel momento stesso in cui nasce) dall’elemento sociale (si possono esercitare e realizzare tali diritti solo se si creano le condizioni condivise per una tale libertà, strettamente interconnessa alla giustizia sociale). Ha quindi enfatizzato la prima, sbeffeggiando e dileggiando la seconda. Quand’anche degli individui, come tali, gli interessasse poco se non nulla. Un capolavoro liberista, in ordine con lo spirito dei tempi che stiamo vivendo. Non solo in Italia. Altri ci hanno preceduti, così come altri ci seguiranno.

Andiamo al dunque. Berlusconi è riuscito a dare corpo e sostanza, nel nostro Paese, al pari di una sorta di asso pigliatutto, a ciò che è conosciuto come “individualismo proprietario” (Pietro Barcellona), la vera ideologia di questi ultimi quattro decenni: dagli anni Ottanta in poi, quindi da Margaret Thatcher e Ronald Reagan in avanti, per arrivare fino a noi. Tempo lungo, a ben pensarci. Non importa, in tutta franchezza, se nel nostro Paese ciò ha assunto, nei fatti concreti, le sembianze di un richiamo a bislacche mitologie (per esempio, le tre I: impresa, internet e inglese, pantomima di una modernizzazione inesistente). Poiché una tale concezione del mondo possa affermarsi, necessita semmai di dichiarare come fondamentale, nelle relazioni sociali, il desiderio di affermarsi individualmente, anche e soprattutto, a scapito degli altri. Alla cooperazione – che è invece uno dei fulcri essenziali dell’essere non tanto di sinistra quanto, soprattutto, solidali – si sostituisce quindi la competizione: non conta quello che si è come comunità ma quanto si può imporre di se stessi; non è importante il lavorare bensì il guadagnare; non è essenziale il sentirsi parte di una società ma il coltivare la propria individualità; non è significativa la condivisione collettiva bensì l’appropriarsi della ricchezza comune a titolo strettamente personale.

In fondo, a ben guardare, si tratta del richiamo a “istinti” primordiali, quasi cavernicoli: a conti fatti, quindi, dietro la finzione di una società in via di evoluzione, c’è invece una collettività in totale regressione. Che tutto ciò, ed altro ancora, possano rivelarsi, ben presto, non solo antisociali ma concretamente insostenibili, poco o nulla importa agli apologeti del cosiddetto “liberismo”. Il resto, ovvero coloro che continuano a credere in un’idea di società solidale, sarebbero solo delle “anime belle”, degli illusi, degli anacronistici rappresentanti di un passato che è trascorso una volta per sempre. Non è infatti rilevante ciò che potrebbe costruirsi, ovvero un orizzonte di eguaglianze, bensì quello che già si finge che possa essere, ossia un’accumulazione individuale, rivendicata come senza limiti. È di quegli anni, non a caso, la progressiva espansione ed esplosione del mercato borsistico. La prima grande crisi data quindi al 1987. Altre ne sarebbero poi derivate, fino ad oggi. Altre ancora ne seguiranno, se ne può stare certi.

Anche per una tale ragione Berlusconi è presente sulla scena pubblica dalla fine degli anni Settanta, quando inizia il declino della Repubblica costituzionale e antifascista, per poi affermarsi nel decennio successivo, in quanto incarnazione individuale dell’Italia imprenditoriale e, quindi, come tale capace di essere in sé autosufficiente, ovvero in grado di sostituire i partiti quand’essi dovessero sparire dalla scena pubblica. Già questo, di per sé, è un indizio da non sottovalutare: Berlusconi, al pari di altri, nei suoi anni, non anticipa e non propone nulla che non sia ciò che si va a sostituire autonomamente, senza nessuna progettazione ideologica, a quanto sta venendo a mancare. Quest’ultimo, del tutto, a partire da una società industriale in via di completo declino. Il cavaliere non genera nulla da sé; piuttosto, lo piega a proprio beneficio. Così come nel caso eclatante dei missini, che si trasformano in una destra che si candida al governo della società italiana. Non è artefice di qualcosa, così come invece si rappresenta personalmente: semmai è la figura che meglio incarna la capacità di fruire, quasi passivamente, della crisi dei vecchi ordinamenti. Non impegnandosi a generarne di nuovi ma secondando gli slittamenti che sono in corso. Nonché fingendo di esserne il vero promotore.

A questo punto della riflessione, dobbiamo quindi formulare una richiesta che è anche un appello, al medesimo tempo di merito (cosa pensare) e soprattutto di metodo (come pensarlo). Veniamo pertanto al dunque: per cortesia, quando dobbiamo valutare i nostri trascorsi quarant’anni, quelli che dall’ultimo decennio del secolo passato ad oggi ci hanno accompagnato, e di cui siamo stati protagonisti, in sé volenti o nolenti (sia pure – molto spesso – in forma passiva), evitiamo i moralismi di circostanza così come le semplificazioni. Per capirci, nessuna retorica del “tradimento dei valori costituzionali”. Nulla di ciò si è, infatti, consumato.
 Semmai abbiamo scoperto che è storia quel che trascorre, a rischio di dirci che, in fondo, noi stessi potremmo arrivare a contare poco se non nulla. Anche per questo è concretamente moralistico quell’atteggiamento per il quale, dinanzi alla propria (personale e collettiva) incapacità di cambiare qualcosa, ci si trincera nel giudizio acritico contro gli “altri” da sé: la destra, i propri avversari, il capitalismo e così via: tutti spettri, se in tale modo pronunciati, dell’impossibilità di transitare, tanto personalmente come collettivamente, da un atteggiamento di mero dissenso, connotato da una sostanziale impotenza, a uno di attiva lotta politica. Poiché i primi sono definiti esclusivamente come “nemici” privi di moralità. Può anche essere vero ma, in politica, ossia nei fatti concreti, tutto ciò conta poco se non nulla. In quanto una parte dei nostri contemporanei non cercano un nocciolo etico al quale ispirarsi bensì la protezione e la sicurezza che un potere sovraordinato (“lo Stato”) dovrebbe invece garantire loro. Delegando quindi a esso le proprie libertà e l’autonomia conquistate nel tempo. A prescindere, va ribadito, da valutazioni morali: si può anche rapinare, a patto che ciò garantisca il proprio benessere. Berlusconi, del suo, si è impegnato per occupare quest’ultimo ambito, dichiarandosi come colui che ne avrebbe soddisfatto le esigenze, sedando qualsiasi residuo ritegno: esibire le cosiddette “olgettine”, come simbolo non solo di sé ma di un antico potere maschile, esente da qualsiasi valutazione che non sia quella del potere di possedere per il proprio esclusivo godimento personale. Le donne, in questo caso, come oggetto. Al pari di quanto il capitalismo ha sempre detto dei lavoratori: il loro corpo come strumento della propria auto-valorizzazione.
Semmai abbiamo scoperto che è storia quel che trascorre, a rischio di dirci che, in fondo, noi stessi potremmo arrivare a contare poco se non nulla. Anche per questo è concretamente moralistico quell’atteggiamento per il quale, dinanzi alla propria (personale e collettiva) incapacità di cambiare qualcosa, ci si trincera nel giudizio acritico contro gli “altri” da sé: la destra, i propri avversari, il capitalismo e così via: tutti spettri, se in tale modo pronunciati, dell’impossibilità di transitare, tanto personalmente come collettivamente, da un atteggiamento di mero dissenso, connotato da una sostanziale impotenza, a uno di attiva lotta politica. Poiché i primi sono definiti esclusivamente come “nemici” privi di moralità. Può anche essere vero ma, in politica, ossia nei fatti concreti, tutto ciò conta poco se non nulla. In quanto una parte dei nostri contemporanei non cercano un nocciolo etico al quale ispirarsi bensì la protezione e la sicurezza che un potere sovraordinato (“lo Stato”) dovrebbe invece garantire loro. Delegando quindi a esso le proprie libertà e l’autonomia conquistate nel tempo. A prescindere, va ribadito, da valutazioni morali: si può anche rapinare, a patto che ciò garantisca il proprio benessere. Berlusconi, del suo, si è impegnato per occupare quest’ultimo ambito, dichiarandosi come colui che ne avrebbe soddisfatto le esigenze, sedando qualsiasi residuo ritegno: esibire le cosiddette “olgettine”, come simbolo non solo di sé ma di un antico potere maschile, esente da qualsiasi valutazione che non sia quella del potere di possedere per il proprio esclusivo godimento personale. Le donne, in questo caso, come oggetto. Al pari di quanto il capitalismo ha sempre detto dei lavoratori: il loro corpo come strumento della propria auto-valorizzazione.
 C’è del metodo in tutto ciò. In un tale ordine di considerazioni, dovrebbe oramai essere chiaro che il campo del “panico morale” (“c’è troppo disordine nella società, d’ora in poi bisogna ricostituire un ordine; di ciò se ne incaricheranno le autorità costituite, ponendo limiti ai pericoli che derivano dall’insicurezza collettiva generata dalle altrui condotte”) è esattamente l’ambito ideologico nel quale la destra reazionaria di massa, dall’Ottocento in poi, ha costruito le sue fortune. Ancora una volta, allora e, quindi, oggi.
C’è del metodo in tutto ciò. In un tale ordine di considerazioni, dovrebbe oramai essere chiaro che il campo del “panico morale” (“c’è troppo disordine nella società, d’ora in poi bisogna ricostituire un ordine; di ciò se ne incaricheranno le autorità costituite, ponendo limiti ai pericoli che derivano dall’insicurezza collettiva generata dalle altrui condotte”) è esattamente l’ambito ideologico nel quale la destra reazionaria di massa, dall’Ottocento in poi, ha costruito le sue fortune. Ancora una volta, allora e, quindi, oggi.
 Detto tutto ciò, rimane il resto, ossia la concreta e definitiva eredità politica di Silvio Berlusconi. Che della destra post-costituzionale, tale poiché nata, cresciuta e fortificatasi all’ombra di una sostanziale allergia rispetto agli ordinamenti costituzionali in quanto tali, registra oggi le sue concrete fortune. Non è in sé un caso. La destra che vince, in Italia così come in altri Paesi europei, celebra la consunzione dei patti costituzionali che, invece, si definirono dal 1945 in poi. È vittoriosa non per quello che propone (pressoché nulla d’altro che non sia lo smantellare i sistemi di garanzie a tutt’oggi esistenti) ma in quanto è il recipiente del disagio che da almeno un ventennio attraversa non solo le periferie bensì gli stessi centri urbani, laddove si ha a che fare con un ceto medio in via di declassamento.
Detto tutto ciò, rimane il resto, ossia la concreta e definitiva eredità politica di Silvio Berlusconi. Che della destra post-costituzionale, tale poiché nata, cresciuta e fortificatasi all’ombra di una sostanziale allergia rispetto agli ordinamenti costituzionali in quanto tali, registra oggi le sue concrete fortune. Non è in sé un caso. La destra che vince, in Italia così come in altri Paesi europei, celebra la consunzione dei patti costituzionali che, invece, si definirono dal 1945 in poi. È vittoriosa non per quello che propone (pressoché nulla d’altro che non sia lo smantellare i sistemi di garanzie a tutt’oggi esistenti) ma in quanto è il recipiente del disagio che da almeno un ventennio attraversa non solo le periferie bensì gli stessi centri urbani, laddove si ha a che fare con un ceto medio in via di declassamento.

L’impoverimento collettivo, non generato tanto da una “cattiva politica” bensì dall’esondazione dell’economia digitale, che come tale non guarda in faccia niente e nessuno, sta accompagnando, come una sorta di brivido collettivo, non solo coloro che già ne sono stati marginali ma anche quanti, da adesso in poi, si pensano come marginalizzabili.

Si tratta di un fenomeno non esclusivamente italiano, e neanche continentale, bensì planetario. La saldatura d’interessi tra i disagi di una middle class in via di consunzione e la racaille (così Nicolas Sarkozy, negli anni della sua presidenza francese), ossia ciò che è intesa come la suburra, la marmaglia, la feccia delle periferie, potrebbe rivelarsi, ancora una volta, esplosiva. In sé ha una portata solo in parte “rivoluzionaria”, essendo semmai eversiva. Di istituzioni e ordinamenti, quelli vigenti, che sempre più spesso si rivelano incapaci di accogliere e filtrare l’onda montante del disagio dei tanti. Delle rivoluzioni del passato non ha in alcun modo la progettualità: si tratta infatti, perlopiù, di sollevazioni popolari che, simulando un inesistente obiettivo collettivo, urlano invece il dolore della propria esclusione dai mercati dei consumi così come dalle reti dell’integrazione. Non cercano alternative allo stato di cose esistenti bensì benefici dai quali sono invece stati estromessi.
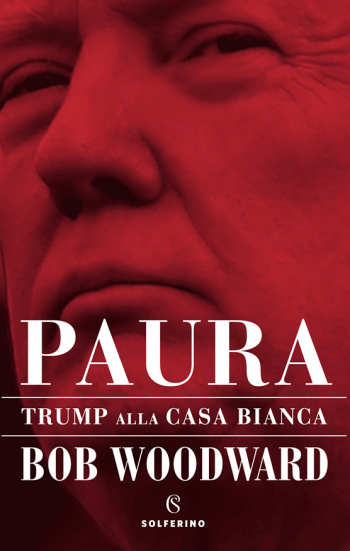 Forse, in parte, fu anche così nei secoli trascorsi. E tuttavia ciò che è plebe non sarà mai una forza di cambiamento. Semmai di smottamento dei fragili ordinamenti di tutela e garanzia già esistenti. Anche questo, in fondo, costituisce cosa nota ai cosiddetti “imprenditori politici della paura” (coloro che usano a proprio beneficio sia il disagio sia la risposta repressiva che ne può da esso derivare). Il talento di questi ultimi, in fondo, è proprio quello di sapere rappresentare, coniugare, mischiare e trattenere, nella loro medesima proposta politica – al medesimo tempo – la rivendicazione e i lamenti degli ultimi, e dei nuovi penultimi (i certi medi declassati), insieme alla domanda di irrisione (e poi soppressione) di tutte le forme di opposizione e di dissidenza. Le quali, come tali, sono presentate in quanto fattori di distruzione del nuovo ordine di sicurezze a venire, quelle che dovrebbero garantire la restaurazione di un nuovo “patriottismo nazionalistico”.
Forse, in parte, fu anche così nei secoli trascorsi. E tuttavia ciò che è plebe non sarà mai una forza di cambiamento. Semmai di smottamento dei fragili ordinamenti di tutela e garanzia già esistenti. Anche questo, in fondo, costituisce cosa nota ai cosiddetti “imprenditori politici della paura” (coloro che usano a proprio beneficio sia il disagio sia la risposta repressiva che ne può da esso derivare). Il talento di questi ultimi, in fondo, è proprio quello di sapere rappresentare, coniugare, mischiare e trattenere, nella loro medesima proposta politica – al medesimo tempo – la rivendicazione e i lamenti degli ultimi, e dei nuovi penultimi (i certi medi declassati), insieme alla domanda di irrisione (e poi soppressione) di tutte le forme di opposizione e di dissidenza. Le quali, come tali, sono presentate in quanto fattori di distruzione del nuovo ordine di sicurezze a venire, quelle che dovrebbero garantire la restaurazione di un nuovo “patriottismo nazionalistico”.

Stante l’attuale stato di cose, più che cercare improbabili, se non impossibili, aderenze al vecchio fascismo mussoliniano, è allora meglio ragionare su come Berlusconi sia invece stato l’autentico beneficiario dell’età post-costituzionale, nella quale siamo entrati dal momento in cui sono declinati i partiti della cosiddetta Prima Repubblica, quella che – per l’appunto – si basava sulla centralità della partecipazione politica (quindi non solo elettorale) e sul rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione vigente. Beninteso, ne è stato per l’appunto un protagonista di primo piano. Non però il vero artefice, come invece amava presentarsi. In quanto ha saputo avvantaggiarsi di un trapasso sia politico come anche – e soprattutto – sociale ed economico, che ha volto a suo immediato favore. Senza però generarlo. In altre parole, dallo sfrangiarsi prima e dal frantumarsi poi delle forme e dei modi in cui si è articolata, per tutto il Novecento, la società industriale, Berlusconi è riuscito a cavalcare l’onda di una trasformazione convulsa, senza una decisa direzione di marcia, in un Paese che già da tempo stava smarrendo i suoi indirizzi di fondo.
 Anche per questo, dopo avere goduto dell’appoggio di diversi personaggi del vecchio sistema partitico, soprattutto di Bettino Craxi e dell’allora Partito socialista (con invece un’aperta diffidenza verso la sinistra democristiana considerata, assai più dei comunisti, il vero obiettivo da colpire ed affondare), nel momento della disgregazione di quest’ultimo si è repentinamente sostituito ad esso, di fatto giocando su alcuni elementi di fondo. Tra di essi, basti ricordare: il definitivo sdoganamento delle pulsioni populiste, alle quali ha dato un concreto indirizzo di potere, ossia una precisa finalità, che ha permesso a quelle forze politiche, che ad esse si richiamavano, di assumere poi il ruolo di formazioni di governo; la piena legittimazione di quella destra illiberale e post-costituzionale, storicamente già rappresentata in Italia dall’allora Movimento sociale italiano e quindi valorizzata come soggetto estraneo al “sistema partitocratico”, espressione con la quale è stata liquidata, in maniera volutamente qualunquista, l’intera esperienza politica italiana, dai Comitati di Liberazione Nazionale, tra il 1943 e il 1945, fino all’inizio degli anni Novanta; la trasformazione dell’agone politico, già soggetto – precedentemente alla stessa Tangentopoli – ad uno sfilacciamento di credibilità, quindi ad una caduta della partecipazione collettiva, in un teatro di raffigurazioni e immagini, nel quale a dominare sono stati a lungo i mezzi di comunicazione di massa; la commistione tra agire politico e imprenditorialità, laddove il primo è stato presentato essenzialmente come un problema di efficacia ed efficienza che solo la competenza imprenditoriale avrebbe potuto soddisfare.
Anche per questo, dopo avere goduto dell’appoggio di diversi personaggi del vecchio sistema partitico, soprattutto di Bettino Craxi e dell’allora Partito socialista (con invece un’aperta diffidenza verso la sinistra democristiana considerata, assai più dei comunisti, il vero obiettivo da colpire ed affondare), nel momento della disgregazione di quest’ultimo si è repentinamente sostituito ad esso, di fatto giocando su alcuni elementi di fondo. Tra di essi, basti ricordare: il definitivo sdoganamento delle pulsioni populiste, alle quali ha dato un concreto indirizzo di potere, ossia una precisa finalità, che ha permesso a quelle forze politiche, che ad esse si richiamavano, di assumere poi il ruolo di formazioni di governo; la piena legittimazione di quella destra illiberale e post-costituzionale, storicamente già rappresentata in Italia dall’allora Movimento sociale italiano e quindi valorizzata come soggetto estraneo al “sistema partitocratico”, espressione con la quale è stata liquidata, in maniera volutamente qualunquista, l’intera esperienza politica italiana, dai Comitati di Liberazione Nazionale, tra il 1943 e il 1945, fino all’inizio degli anni Novanta; la trasformazione dell’agone politico, già soggetto – precedentemente alla stessa Tangentopoli – ad uno sfilacciamento di credibilità, quindi ad una caduta della partecipazione collettiva, in un teatro di raffigurazioni e immagini, nel quale a dominare sono stati a lungo i mezzi di comunicazione di massa; la commistione tra agire politico e imprenditorialità, laddove il primo è stato presentato essenzialmente come un problema di efficacia ed efficienza che solo la competenza imprenditoriale avrebbe potuto soddisfare.

Non di meno, ed è un altro passaggio importante, è riuscito a legare l’immagine di sé, in quanto presunto “innovatore”, modernizzatore, semplificatore con il ritorno in auge – dopo il riflusso consumatosi per tutti gli anni Ottanta della lunga stagione delle rivendicazioni e dei diritti – di schemi culturali espressamente retrogradi. Avremo ancora modo di soffermarci, nel futuro, sul suo dichiarato sessismo, sul suo patriarcalismo, sul suo familismo amorale. Va tuttavia rilevato che la sua destrezza è stata quella di coniugare un’inesistente «nuovo miracolo italiano» alla restaurazione, in diversi segmenti della società italiana, di atteggiamenti regressivi. Così ha avuto modo di scrivere la Società italiana delle storiche, il 14 giugno 2023: “Berlusconi ha legittimato, nella comunicazione e nei comportamenti pubblici, la reificazione e la mercificazione delle donne e dei corpi femminili, esaltando una maschilità patriarcale e paternalistica e contribuendo così a rallentare, e in qualche caso addirittura a invertire, il percorso verso una società più paritaria e rispettosa delle differenze di genere avviatosi con la caduta del fascismo, la Resistenza e la nascita dell’Italia repubblicana, e poi reso più celere dai femminismi degli anni Settanta del Novecento”.

Dietro l’appartenente contraddizione tra moderno (l’ “impresa”) e l’arcaico (il maschile come indice di possesso), si rivela quindi la destrezza del gioco di potere che ha sempre accompagnato un Silvio Berlusconi estremamente abile nel manipolare la comunicazione pubblica, avendo comunque ad obbiettivo la valorizzazione di sé e del suo milieu di interessi. Fingendo che questi ultimi siano lo specchio nel quale la collettività italiana debba riconoscere i suoi effettivi lineamenti. Silvio Berlusconi e il berlusconismo – pertanto – non si possono liquidare come un fenomeno transitorio. Poiché, in realtà, Berlusconi non è mai stato un capitano d’impresa per come lo si intendeva tradizionalmente nella società industriale. Le sue fortune, al netto delle vicende giudiziarie che lo hanno ripetutamente interessato e coinvolto, sono legate alla combinazione tra l’iniziale impegno nell’edilizia, l’intervento – assai perspicace – nel circuito televisivo (quand’esso, dalla seconda metà degli anni Settanta, andava differenziandosi e pluralizzandosi) nonché l’attenzione continua per l’editoria, un po’ in tutte le sue forme.
 Va detto che da sé non ha inventato nulla. Semmai la sua vera abilità è stata quella di comprendere quale fosse il mutamento in atto nel comune sentire, cercando in indirizzarne gli esiti. Come tale, rimane un vero e proprio “imprenditore dell’immaginario”, che ha saputo alternare paure a desideri, angosce a speranze, immedesimazioni così come rifiuti, intervenendo pesante nella formazione dell’opinione pubblica.
Va detto che da sé non ha inventato nulla. Semmai la sua vera abilità è stata quella di comprendere quale fosse il mutamento in atto nel comune sentire, cercando in indirizzarne gli esiti. Come tale, rimane un vero e proprio “imprenditore dell’immaginario”, che ha saputo alternare paure a desideri, angosce a speranze, immedesimazioni così come rifiuti, intervenendo pesante nella formazione dell’opinione pubblica.
A conclusione di questa prima riflessione, proponiamo quindi alcuni passaggi chiave, alcune parole indice, ovvero delle tracce di riflessione, nel merito delle quali proseguire nel lavoro politico di indagine e ricerca sul presente: l’esaltazione dell’essere impolitico (“non mi interesso del resto della società, valgo per me stesso e tanto basti!”), la spoliticizzazione e, con essa, la disintermediazione; l’anticomunismo come collante ideologico interclassista; il sessismo e il machismo come ideologie della prevaricazione non solo di genere ma di ceto sociale. Così la studiosa Enrica Asquer: “l’eredità del berlusconismo va misurata oggi anche nello straordinario dibattito sul nesso tra potere, sessualità e genere, praticando un conflitto anche aspro tra (auto)rappresentazioni del femminile”.
Le lenti che dobbiamo inforcare per analizzare quegli anni non possono essere quelle della “storia dei costumi”, sessuali o meno che siano. Ora più di allora dobbiamo mobilitare una cassetta degli attrezzi che ci consenta pienamente di uscire dalla denuncia scandalizzata e di entrare compiutamente dentro l’analisi del berlusconismo come produttore di immaginario e di una cultura di consumo molto potente); il rapporto tra calcio (il Milan) e la politica come due passioni immediatamente sovrapponibili e, quindi, intercambiabili; la riduzione della stessa politica ad una commistione tra marketing e “governo pop” (così Michele Prospero e Giorgio Galli, tra gli altri).
Come si sarà inteso, se si è giunti fino a queste ultime parole, c’è un enorme lavoro da fare. Su se stessi ma, anche e soprattutto, sulle società nelle quali viviamo. Se non si parte da ciò, altrimenti, si rischia di essere perdenti a priori. Le battaglie politiche non le si conduce per spirito di partecipazione, come neanche per impulso di sopraffazione, bensì per ricerca di una possibile giustizia, per ognuno di noi e, quindi, per tutti, nessuno escluso. Che cosa sarà la giustizia sociale è, per ognuno di noi, un interrogativo aperto.
Claudio Vercelli, storico, Università cattolica del Sacro Cuore, Istituto di studi storici Salvemini
Pubblicato sabato 8 Luglio 2023
Stampato il 31/03/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/longform/silvio-berlusconi-la-grande-bolla-che-ha-stregato-la-politica/






