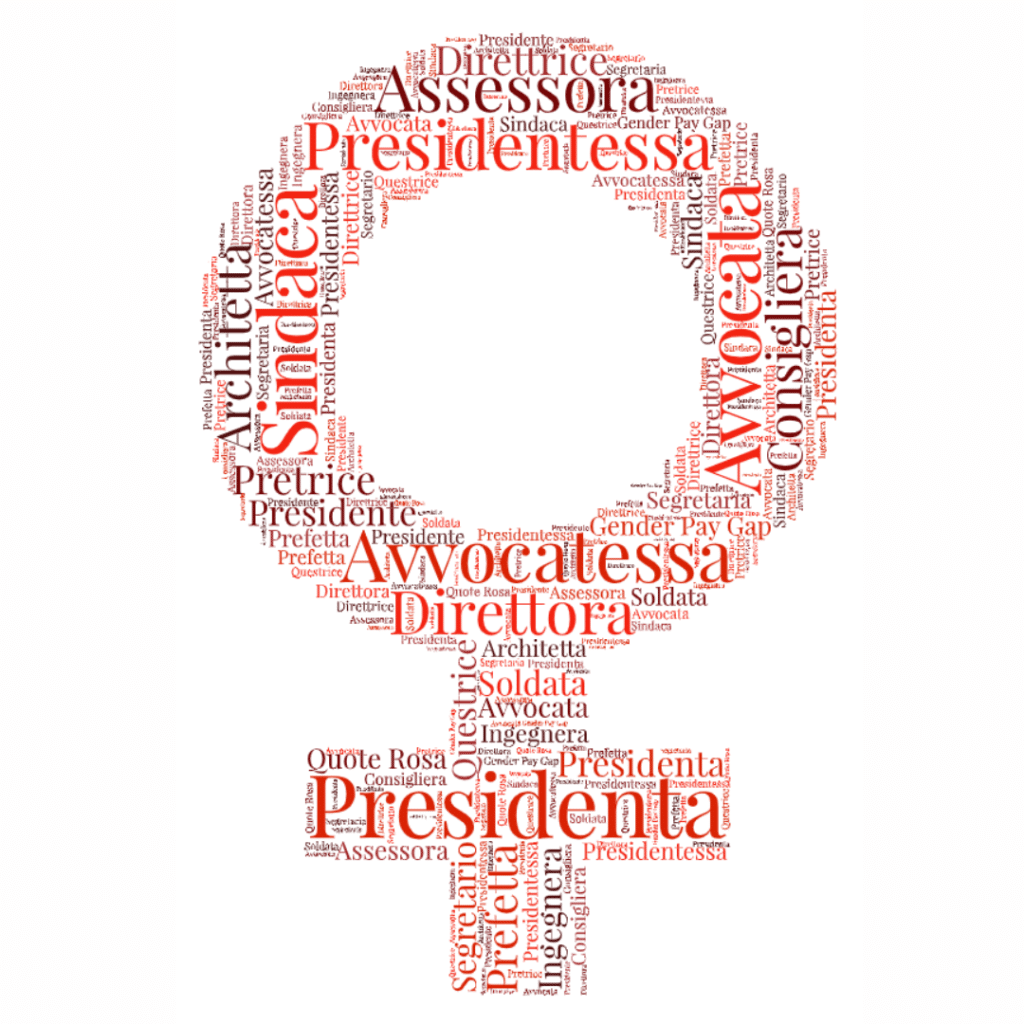Mario Draghi in Aula al Senato, il giorno della fiducia al governo, nel ringraziare Maria Elisabetta Casellati per avergli dato parola, l’ha chiamata “il Presidente”. E ha ripetuto per due volte l’appellativo. Ma qual è il termine corretto: presidente, presidentessa o presidenta? E si dice: avvocata, avvocatessa o avvocato donna? Direttrice, direttore o direttora? La progressiva immersione delle donne nel mondo del lavoro ha dato luogo a diatribe intorno agli appellativi con i quali definire le nuove figure professionali. Un’immersione dovuta anche all’entrata in vigore delle cosiddette “quote rosa” che, dal 2011, impongono una percentuale obbligatoria di entrambi i generi nei consigli di amministrazione e nelle società presenti in borsa e a controllo pubblico.

Come intuibile, anche una rappresentanza controversa e, per molti aspetti, incompleta, come le quote rosa, ha richiesto sanzioni da parte delle istituzioni per essere sempre rispettata, soprattutto all’indomani della sua introduzione. La Premio Nobel per la Pace 2004 Wangari Maathai ha descritto il fenomeno in termini semplici ed efficaci: «Più in alto si va, meno donne ci sono».
Spesso molte donne preferiscono adottare il titolo maschile nelle mansioni intellettuali, confermando, tuttavia, quanto il maschile, inteso come genere grammaticale e sessuale, sia il più autentico detentore di prestigio. Se, quindi, la donna vuole raggiungere posizioni apicali deve adeguarsi in virtù di quel concetto di parità che è stato (e continua a essere) interpretato come adeguamento al modello maschile: essere definita con un titolo maschile equivale al riconoscimento della parità con l’uomo.

“Ma è solo una questione di desinenza” o “il ruolo è neutro” sono le motivazioni che sovente si adducono per giustificare questa scelta. «Il ruolo non è neutro e non lo è mai stato! La dimostrazione è che in tutti i contesti in cui la presenza femminile è abituale, il maschile non si usa» spiega la sociolinguista Vera Gheno, già collaboratrice dell’Accademia della Crusca e docente dell’Università di Firenze. È vero che si dovrebbe uscire dal binarismo di genere – quello composto esclusivamente da uomo e donna che trascura altre sessualità come l’omosessualità e la transessualità – ma non per questo possiamo dimenticare che l’uso generalizzato del maschile passato per neutro ha significato la cancellazione delle donne laddove rivestono ruoli tradizionalmente riservati agli uomini.
 «Il problema – chiosa l’autrice del libro Femminili singolari (EffeQu, 2019) – emerge tutte le volte che abbiamo a che fare con professioni in cui, fino a poco tempo fa, le donne non erano abituali o addirittura escluse tout court da certe cariche. Questo non deve sconvolgere perché noi esseri umani siamo animali abitudinari e quindi il dover cambiare le nostre abitudini (anche linguistiche) comporta uno sforzo mentale. Il fatto di essere donne non ci mette al sicuro dal dire cose di stampo patriarcale, perché si tratta di una pigrizia cognitiva in maniera uguale per donne e uomini». Uno dei settori saldamente ancorati al carattere maschile è quello dell’ingegneria, dove le donne sono solo il 28% dei laureati a livello mondiale, secondo una recente indagine condotta dall’Unesco Science Report. Per inciso, la lavoratrice che opera in questo ambito si definisce ingegnera.
«Il problema – chiosa l’autrice del libro Femminili singolari (EffeQu, 2019) – emerge tutte le volte che abbiamo a che fare con professioni in cui, fino a poco tempo fa, le donne non erano abituali o addirittura escluse tout court da certe cariche. Questo non deve sconvolgere perché noi esseri umani siamo animali abitudinari e quindi il dover cambiare le nostre abitudini (anche linguistiche) comporta uno sforzo mentale. Il fatto di essere donne non ci mette al sicuro dal dire cose di stampo patriarcale, perché si tratta di una pigrizia cognitiva in maniera uguale per donne e uomini». Uno dei settori saldamente ancorati al carattere maschile è quello dell’ingegneria, dove le donne sono solo il 28% dei laureati a livello mondiale, secondo una recente indagine condotta dall’Unesco Science Report. Per inciso, la lavoratrice che opera in questo ambito si definisce ingegnera.

Sulle resistenze dell’uso degli appellativi femminili si è acceso un dibattito pubblico quando, lo si ricorderà, all’inizio della pandemia le tre scienziate dell’Istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani di Roma, che per prime hanno isolato il coronavirus, vennero definite dai principali organi di informazione nazionale ricercatori, virologi, medici e, nei casi peggiori, ragazze o angeli della ricerca. «Non si usa la sessuazione del linguaggio perché il nome è potere, esistenza, possibilità di diventare degne di entrare nella storia in quanto donne (…). Trasmettere la storia sessuando il linguaggio è narrarsi, dirsi, obbligare ad essere dette con il proprio nome di genere» scriveva la partigiana e politica Lidia Menapace, scomparsa di recente a causa del covid.
«Questa renitenza al cambiamento è una forma di conservatorismo del famoso “si è sempre fatto così”, poi in realtà, se si allarga lo sguardo verso le epoche precedenti, si scopre che si è sempre usato il femminile alla bisogna» afferma Gheno.
 Mentre cameriera, sarta, operaia, pastora, impiegata, regina, zarina fanno parte ormai del nostro lessico quotidiano, deputata, architetta, avvocata, direttrice, ministra, sindaca, medica fanno ancora fatica ad affermarsi con naturalezza nel parlato quotidiano. Per inciso: presidente, come insegnante, tirocinante e via dicendo sono participi presenti che hanno bisogno semplicemente di cambiare l’articolo.
Mentre cameriera, sarta, operaia, pastora, impiegata, regina, zarina fanno parte ormai del nostro lessico quotidiano, deputata, architetta, avvocata, direttrice, ministra, sindaca, medica fanno ancora fatica ad affermarsi con naturalezza nel parlato quotidiano. Per inciso: presidente, come insegnante, tirocinante e via dicendo sono participi presenti che hanno bisogno semplicemente di cambiare l’articolo.
Eppure avvocata è uno degli appellativi della Madonna: si pensi alla preghiera Salve o Regina, che recita “Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi”. Analogamente, ministra era presente anche in passato e indicava l’amministratrice di un culto religioso. E allora perché “suonano male”?
«Non è il termine a suonare male, ma il suo significato. Non è un problema di forma, ma di sostanza. I femminili singolari sono naturali e sono una conseguenza delle cose. Alcuni non esistevano perché la carica non era ricoperta da una donna. Perché avrei dovuto utilizzare sindaca se non avevo sindaca in natura? La questione risuona maggiormente, quindi, perché è strettamente legata alla rivendicazione femminile: “voglio un appellativo che mi rappresenti perché così ti accorgi che ci sono”» fa notare Gheno.

Funziona così: compare il fenomeno e la lingua lo registra. Succede anche per le mansioni ricoperte dagli uomini: il parrucchiere è una figura recente nell’ambito della cura estetica della persona svolta principalmente dalle donne, così come oggi vediamo uomini nelle corsie degli ospedali che coprono il ruolo di ostetrico, attività femminile per antonomasia. Perché, dunque, non utilizzare il femminile quando necessario? Il rischio è quello di avallare il pregiudizio che la presenza delle donne in alcune posizioni lavorative sia un’anomalia.
Anche il neocostituito governo Draghi è stato al centro di polemiche, a causa degli 8 ministeri (di cui solo 3 con portafoglio) assegnati a delle ministre, su un totale di 23 dicasteri. Una presenza, quella femminile, che è stata commentata come puramente esornativa. Qualcuno ha inveito contro il Partito democratico e Liberi e uguali, formazioni che del progressismo e delle lotte per la parità dovrebbero essere alfieri. Altri sostengono che per emergere davvero resta solo il modello Emma Bonino (o Giorgia Meloni): farsi un proprio partito.

«Per me donna di sinistra e femminista brucia ancora di più, che neanche la sinistra sia stata coerente alle affermazioni che spesso fa ma non mette in pratica nella politica – ha scritto in un post Facebook l’ex segretaria generale della Cgil Susanna Camusso. Non condivido il circoscriverlo a problema del Pd (…) non voglio difendere la sinistra e le sue responsabilità evidenti, ma risolverla additando un colpevole è un modo per far sì che nulla cambi.»
C’è un termine che più di tutti suscita polemiche: femminicidio, che esiste perché si tratta di un problema sociale. L’uccisione di una donna in quanto donna, infatti, avviene nell’85% dei casi per mano di un partner, ex partner o familiare di sesso maschile, come riportano i dati Istat. Non esiste il fenomeno inverso, cioè l’uccisone di un uomo per mano femminile, che è presente in maniera nettamente inferiore, poiché circa il 70% degli uomini muore per mano di sconosciuti o non identificati. Per questa ragione maschicidio risulta pretestuoso.

Il femminicidio si consuma invece in seno alla famiglia. «L’obiezione che spesso si fa alla parola femminicidio è che non serve perché esiste già omicidio, ma abbiamo matricidio, infanticidio, uxoricio che indicano la relazione tra vittima e carnefice e femminicidio si inserisce in questo ambito» spiega Gheno.
Ci sono tuttavia sostantivi maschili che, se declinati al femminile, assumono carattere dispregiativo. In una sola parola: sessista.

Esiste un elenco stilato dal linguista Stefano Bartezzaghi e interpretato in un monologo dall’attrice Paola Cortellesi che recita: «Un cortigiano: un uomo che vive a corte. Una cortigiana: una mignotta. Un massaggiatore: un cinesiterapista. Una massaggiatrice: una mignotta. Un uomo di strada: un uomo del popolo. Una donna di strada: una mignotta. Un uomo disponibile: un uomo gentile e premuroso. Una donna disponibile: una mignotta. Un passeggiatore: un uomo che cammina. Una passeggiatrice: una mignotta. Uno squillo: il suono del telefono. Una squillo…» E l’elenco continua.
«Si è sempre controllato molto di più i costumi sessuali femminili rispetto a quelli maschili, è uno dei lasciti di una società patriarcale dove per l’uomo non solo è lecito avere una vita sessuale abbastanza libera ma è visto anche come punto d’onore mentre la donna viene giudicata in maniera negativa» commenta la sociolinguista. Pensiamo a femminiere e dongiovanni rispetto ai femminili volgari e non di rado infamanti, che non hanno bisogno di essere citati. O agli epiteti in fatto di gusti sessuali: tardona se si tratta di una donna a cui piacciono uomini più giovani in confronto al corrispettivo maschile con un retrogusto tenero, come papi.
 «Anche le offese per uomo sono sempre in relazione alla donna: figlio di puttana, cornuto o insulti alla sorella. Insomma è una spia abbastanza rilevante di quanto la nostra società sia ben lontana dall’essere paritaria e lo stigma di comportamenti sessuali lascivi è tutto sulla donna, non sull’uomo. L’uomo viene accusato di altre cose per altro. Un castigo per l’uomo è quello di non essere sufficientemente virile e quindi si insinua che sia omosessuale. Anche questo è un lascito patriarcale che vuole che donne e uomini si comportino secondo degli stereotipi. Queste parole non fanno altro che riprodurre squilibri di genere non tanto nella lingua italiana, ma nella cultura e che poi hanno delle conseguenze negative anche su chi non si adegua al maschile e al femminile e viene considerato divergente dalla normalità – sottolinea Vera Gheno, che conclude – Gli usi linguistici non sono indifferenti, raccontano molto della nostra visione della società e della direzione che vogliamo che la nostra società prenda. Sarebbe un bene che tutti riflettessimo sul modo in cui usiamo le parole e sul perché le utilizziamo». Perché, come sostengono molti studiosi, la lingua è un binario su cui viaggia il pensiero.
«Anche le offese per uomo sono sempre in relazione alla donna: figlio di puttana, cornuto o insulti alla sorella. Insomma è una spia abbastanza rilevante di quanto la nostra società sia ben lontana dall’essere paritaria e lo stigma di comportamenti sessuali lascivi è tutto sulla donna, non sull’uomo. L’uomo viene accusato di altre cose per altro. Un castigo per l’uomo è quello di non essere sufficientemente virile e quindi si insinua che sia omosessuale. Anche questo è un lascito patriarcale che vuole che donne e uomini si comportino secondo degli stereotipi. Queste parole non fanno altro che riprodurre squilibri di genere non tanto nella lingua italiana, ma nella cultura e che poi hanno delle conseguenze negative anche su chi non si adegua al maschile e al femminile e viene considerato divergente dalla normalità – sottolinea Vera Gheno, che conclude – Gli usi linguistici non sono indifferenti, raccontano molto della nostra visione della società e della direzione che vogliamo che la nostra società prenda. Sarebbe un bene che tutti riflettessimo sul modo in cui usiamo le parole e sul perché le utilizziamo». Perché, come sostengono molti studiosi, la lingua è un binario su cui viaggia il pensiero.
Mariangela Di Marco
Pubblicato lunedì 22 Febbraio 2021
Stampato il 03/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/8-marzo-tutto-lanno/la-parita-e-nelle-parole/